Tra guerre di nazionalismi e catastrofe climatica, non abbiamo rinunciato all’estate (non l’hanno fatto neppure a Zaporizhia). Sulla mia costa, tra Viareggio e Livorno, in estate si degusta il cacciucco. Quando questa “Mosca” apparirà, sarà passato anche l’ottobre 2022 e si sarà ricordato il fascismo che salì al potere cent’anni fa. Nei tre anni successivi al 1922 divenne regime e Stato totalitario e, sebbene la macchina fosse imperfetta (anche sgangherata qua e là), rimase ferocissima contro democratici, operai, contadini ribelli.
Non fu solo “mussolinismo”, il fascismo, ma senza Mussolini non sarebbe stato possibile e concepibile: naturale, perciò, che per non pochi oppositori e ribelli l’attentato al duce apparisse una soluzione per rovesciare l’intero regime. Ci provarono in tanti: nel 1925 il socialista unitario Tito Zaniboni con il generale Luigi Capello, nel 1926 l’anarchico Gino Lucetti e il giovanissimo Anteo Zamboni, tra 1931 e 1932 ancora due anarchici: Michele Schirru e Angelo Pellegrino Sbardellotto. Tutti la pagarono cara.
L’immagine del tirannicida disposto a pagare con la vita il coraggio di un gesto estremo per riconquistare la libertà, Bruto che accoltella Cesare, era stata cara sin dal Cinquecento agli umanisti -Alamanno Rinuccini, Niccolò Machiavelli, Niccolò Ridolfi. Tra XVI e XVII secolo, molte intelligenze politiche giustificarono, in nome del diritto supremo di resistenza, l’omicidio del sovrano che avesse violato il patto con il proprio popolo: vennero definiti “monarcomachi” l’inglese John Milton, l’italiano Roberto Bellarmino, i francesi Hotman e Duplessis-Mornay, lo spagnolo Francisco Suarez. Il modello fu sempre l’uccisione di Giulio Cesare da parte di Bruto, che l’illuminista Montesquieu consacrò nel Settecento come “azione divina”. Non per caso nel Risorgimento i nostri mazziniani la idoleggiarono, mentre Mussolini bollò Bruto e Cassio come “assassini e traditori” in un suo pessimo lavoretto di teatro scritto con Giovacchino Forzano, che qui a Tirrenia avrebbe fondato un’improbabile Cinecittà.
Oggi che leggete questa “Mosca” in Italia si è installato un governo dominato dagli eredi del nazionalismo fascista, ma non dovrete equivocare. Ripensate piuttosto all’estate trascorsa, anzi al cacciucco.
Costanzo Ciano fu un valoroso ufficiale di Marina durante la guerra di Libia e la Grande Guerra, un seguace di D’Annunzio, un feroce capo squadrista responsabile della morte di molti militanti socialisti, un gerarca tiranno della sua città, un ministro e alto funzionario del regime. Suo figlio Galeazzo fu ministro degli esteri e genero del duce (che “tradì” nella sessione del Gran Consiglio del 25 luglio ’43). Costanzo, detto “ganascia” nella sua Livorno, amava la buona tavola e l’abbondanza (da qui il nome?). Nonostante la camicia nera, al risotto cucinato con il nero di seppia preferiva però il cacciucco rosso, innaffiato con tantissimo vino, rosso (“la politica a tavola non mi sconfinfera”, pare dicesse). Il 26 giugno 1939 cenò nella casa dei camerati Adolfo e Bruno Baiocchi, con tanto cacciucco rosso e tanto vino rosso ghiacciato. Esagerò, pare.
Tornato nella villa di Ponte a Moriano di Lucca, ebbe un malore fatale. La vendetta del cacciucco.
La vendetta del cacciucco
discussioni
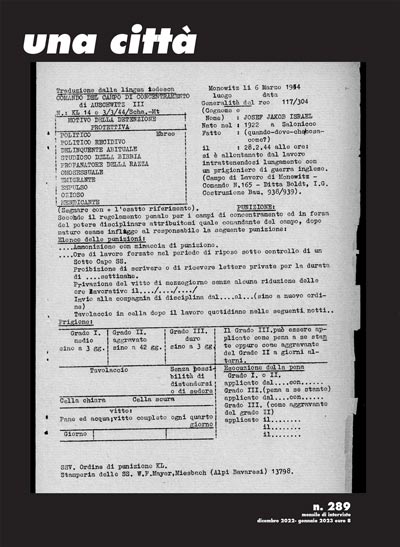
Una Città n° 289 / 2022 dicembre-gennaio
Articolo di Michele Battini
La vendetta del cacciucco
di Michele Battini
Archivio
"IN MANO AGLI EBREI"
Una Città n° 189 / 2011 novembre
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Michele Battini è professore ordinario di Storia Contemporanea e presidente del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici nell’Università di Pisa. è membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza Ferruccio Parri e...
Leggi di più
Non siamo tutti galileiani
Una Città n° 314 / 2025 ottobre-novembre
Un “caso” illumina la storia plurisecolare dei rapporti conflittuali tra saperi teologici e scientifici, e tra i poteri dall’Antico Regime: quello di Galilei e della sua persecuzione. Lo dimostra perfettamente Massimo Bucciantini in Alla...
Leggi di più
Primo Levi e Sandro Delmastro. Tra storia e letteratura
Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto
“Ferro”, lo splendido capitolo de Il Sistema periodico di Primo Levi contiene il ritratto morale di Sandro Delmastro, indimenticabile e indimenticato amico di Levi, e si conclude così: “Sandro era Sandro Delmastro, il primo caduto...
Leggi di più
Meditazioni sullo sterminio e sul Giorno della Memoria
Una Città n° 306 / 2024 dicembre 2024-gennaio 2025
Partiamo dalla domanda sempre fondamentale. Come si spiega l’insorgenza dell’antisemitismo di Stato proprio nel 1938, in quel momento della già non breve storia del regime fascista? La decisione persecutoria venne prima adombrata (con u...
Leggi di più
Nervi dei nostri nervi
Una Città n° 305 / 2024 novembre
I. Comporre una ricerca e scriverne il testo a quattro mani può costituire un rischio, e per molte ragioni. Può risultare difficile connettere le rispettive sezioni della ricerca e del libro che ne è risultato; può emergere un ...
Leggi di più


















