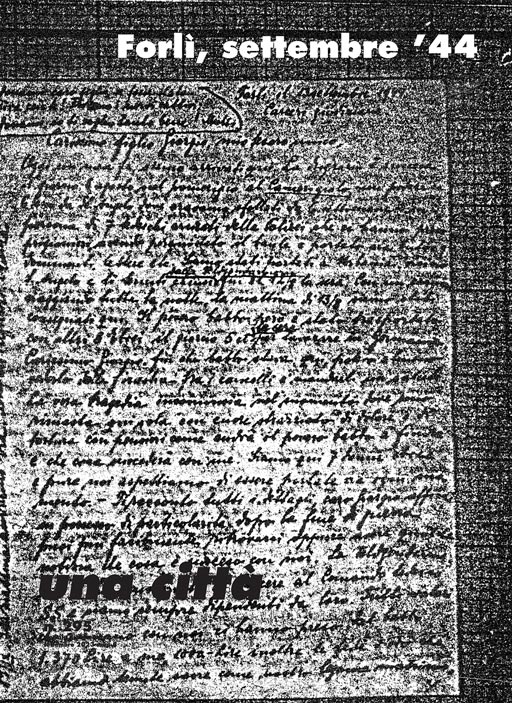Mio padre era morto nel 1927 di cancro allo stomaco. Più tardi ci saremmo detti spesso che aveva avuto fortuna.
Nel 1933 io stavo finendo il liceo, l’era nazista stava iniziando. Di circa 20 alunni ero l’unica ebrea e fino ad allora avevo avuto un buon rapporto con i miei compagni. Essendo brava nei temi in lingua tedesca, e soprattutto in francese e in inglese, ma uno zero in matematica, eravamo costretti ad aiutarci a vicenda. Le cose cambiarono bruscamente dopo il 1933. Proprio le donne e le ragazze furono le prime a entusiasmarsi per Hitler aderendo alle sue idee ed entrando a far parte del “Bund deutscher Mädl”. Così, da un giorno all’altro, mi ritrovai completamente isolata, nessuno parlava più con me. Era una situazione ben difficile da sopportare per una ragazzina di 16 anni.
Nel marzo 1933 terminai comunque il liceo e mi iscrissi in un istituto privato per il commercio. Nel frattempo gli ebrei tedeschi avevano iniziato a preoccuparsi. I miei zii, però, avevano combattuto nella Prima guerra mondiale, entrambi insigniti della più alta croce al merito. Erano tedeschi convinti, loro si dichiaravano cittadini tedeschi di fede ebraica per sottolineare la loro appartenenza allo stato tedesco. Ricordo che avevano appeso l’onorificenza sopra al letto, erano persuasi che quando i nazisti sarebbero arrivati per arrestarli si sarebbero fermati vedendo quelle croci. Purtroppo si rivelò un calcolo errato. Ho dunque frequentato quell’anno di istituto per il commercio e poi ho dovuto cercarmi un posto di lavoro. La scuola si era impegnata a trovare un lavoro agli studenti che avessero ottenuto dei buoni voti all’esame. (Nel ’34 in Germania iniziava a diventare difficile trovare un lavoro). Era indubbio che io rientrassi fra gli studenti migliori, ma visto che ero certa che non mi avrebbero procurato un lavoro, mi ero interessata già prima, ottenendo un posto di apprendista presso la comunità ebraica che all’epoca aveva ancora un’amministrazione imponente. Durante la festa di fine corso il direttore con somma gioia annunciò di aver trovato un posto agli studenti migliori. Quando chiamò il mio nome, mi disse rammaricato di non essere riuscito a trovarmene uno di lavoro, perché non poteva pretendere da nessun tedesco di dare un lavoro a un’ebrea. Io me l’aspettavo e risposi con orgoglio che non era necessario, perché avevo già trovato un’occupazione. Fu per me una grande soddisfazione.
Il 15 marzo 1934 ho iniziato a lavorare alla comunità ebraica. Aggiungo che prima mio fratello e io eravamo entrati a far parte del “Bund deutsch-jüdischer Jugend” (associazione della gioventù ebrea tedesca), nato per raggruppare i giovani e offrire loro la possibilità di una vita collettiva. Il gruppo non era politico, noi avevamo un’unica preoccupazione, vale a dire che ne sarebbe stato di noi. Il 13 marzo 1934 i nazisti ci assalirono in una baracca, asserendo che stavamo discutendo di testi marxisti che per giunta ci eravamo procurati di contrabbando. Iniziarono a picchiarci. Alfred, nell’intento di proteggermi, perse due denti. Ci nascondemmo nella vicina stazione della metropolitana. Arrivai al mio nuovo lavoro piena di lividi e la cosa mi rese subito nota. I miei zii -di cui uno esercitava la patria potestà su di noi- volevano vietarci di partecipare a questi gruppi, ma noi non ubbidimmo. Mio fratello era apprendista nell’ingrosso di confezioni che mio zio aveva a Berlino nella Spandauer Straße. Accanto al lavoro iniziammo a prendere lezioni di lingue straniere, soprattutto inglese (le conoscenze acquisite a scuola non bastavano certo) e in seguito, quando iniziò a prospettarsi l’eventualità che saremmo andati verso la Svizzera o l’Italia, mio fratello iniziò a studiare l’italiano. Devo aggiungere che mio fratello era proprio un genio delle lingue e più tardi la cosa gli fu ripetutamente riconosciuta in Italia.
Il gruppo di amici andava assottigliandosi sempre di più. Quasi ogni giorno ce n’era uno che ci salutava o che spariva prelevato dai nazisti. Vivevamo in una paura costante, preoccupati per quello che stava succedendo, ma anche per cosa ci avrebbe riservato il futuro. I miei zii finirono per riconoscere che bisognava fare qualcosa. E lo zio che aveva il negozio di confezioni e un reddito che gli permetteva di vivere bene si recò in Svizzera con mio fratello per sondare le possibilità di emigrare in quel Paese. Il motto della famiglia era: “Qualunque cosa accada dobbiamo restare insieme”. In Svizzera però si resero presto conto che la situazione non era facile: difficilmente avrebbero ottenuto un permesso di soggiorno per tutti e ancor meno un lavoro. Mio fratello e io non volevamo vivere con gli aiuti degli zii, volevamo lavorare e visto che la Svizzera non sembrava una soluzione, ci venne l’idea di partire per l’Italia. Eravamo Alfred e io, i due zii, due cugine e più tardi la moglie di uno zio.
Non so come finimmo a Cremona. Forse perché volevano vivere isolati per quanto possibile e non in una grande città dove avrebbero potuto notarci e forse anche perché lì credevamo ci fossero delle opportunità di lavoro e di guadagnare qualcosa. A stavo finendo il liceo…
Alla fine rilevammo un panificio che, come si usa in Italia, vendeva anche generi alimentari di prima necessità come latte, zucchero, pasta, olio, insomma tutto. Il negozio andava bene. Mia madre era riuscita a portare in Italia quasi tutti i mobili e tutto ciò che si riusciva a trasportare. Fino al 1936 era ancora possibile espatriare con il passaporto e noi fortunatamente lo avevamo. Dopo non sarebbe più stato possibile.
Arrivai quindi in Italia e come prima cosa mio fratello mi insegnò l’italiano. Avevo già seguito un corso all’ambasciata italiana, ma il mio italiano lo devo a mio fratello. Ho ancora davanti a me l’immagine di noi due che con impegno dalla mattina alla sera passavamo le giornate a studiare vocaboli. Anche se grazie alla mia conoscenza del francese riuscivo a capire con una certa rapidità, non riuscivo a buttarmi e parlare, ero convinta che nessuno mi avrebbe capito. Così Alfred passò ai metodi drastici: mi portò a Milano, mi lasciò in centro dicendomi che avrei dovuto cavarmela da sola per ritornare a casa e che sarei stata costretta a parlare. Fu così che riuscii a superare il mio blocco.
A Milano trovai un lavoro come addetta alla corrispondenza in lingua italiana-tedesca. Per alcuni mesi andò tutto bene. E qui devo tributare una lode ai lavoratori italiani che sapevano perché lavoravo lì, senza essere registrata, e mostrarono molta comprensione aiutandomi come potevano. Fare la pendolare fra Milano e Cremona era abbastanza faticoso. Tornavo molto tardi dal lavoro. La famiglia considerò che sarebbe stato meglio se avessi iniziato come commessa nel panificio, ma anche questo non era così semplice, perché, non so come sia adesso, ma all’epoca a Cremona c’erano soprattutto poveri contadini e questi parlavano in dialetto cremonese. Questo dialetto non era tanto semplice, ma comunque lo imparai e, anzi, dopo poco tempo ero in grado di capire e di farmi capire senza problemi. Le cose sembravano andar bene: io mi divertivo in bottega, imparavo tante cose... come i nomi di 32 tipi di pasta! Non so come sia adesso, ma all’epoca lo zucchero era merce di monopolio e noi dovevamo incartarlo in grossa carta di color grigio-blu e quando un contadino veniva per comprare 100 g di zucchero -erano poveri- l’involucro pesava più del contenuto, davvero.
Avevamo iniziato a conoscere dei giovani, fra cui la figlia di un’inglese che aveva sposato un italiano durante la Prima guerra mondiale. Poi mia cugina, di nove anni più giovane di me e che all’epoca era una scolaretta, portò in casa molti bambini del vicinato. Dopo qualche minuto erano già lì a giocare con la palla o altro. Come detto, la vita continuava normalmente, fino a quando a Hitler non venne l’idea di andare a trovare Mussolini nel 1938 e ci misero agli arresti domiciliari, perché questi ebrei a Cremona potevano costituire un pericolo per Hitler che era a Roma! Subito dopo furono applicate in Italia le cosiddette leggi di Norimberga e la situazione si aggravò in particolare, per uno dei due zii.
Nel frattempo, purtroppo, la famiglia si stava sfasciando. La mia famiglia non era certo rigidamente osservante, ma gli zii erano tedeschi convinti di fede ebraica e quindi rispettavano le festività, frequentavano la sinagoga e seguivano le usanze e i costumi ebraici. Per questo era stato particolarmente difficile per mio zio -quello che aveva finanziato tutto e che all’epoca era vicino alla cinquantina- spiegare a sua madre che da più di vent’anni intratteneva una relazione con una cristiana. Non ne aveva avuto il coraggio. Oggigiorno pare impossibile che un uomo della sua età... ma la nonna era quella che dettava legge in famiglia e lui credeva che non avrebbe mai acconsentito a quella relazione. Mio zio però fece sorgere in questa donna un sentimento di rabbia nei confronti della famiglia, perché le disse che l’avrebbe sposata volentieri, ma che sua madre e sua sorella non l’avrebbero mai permesso. Fu un errore che in seguito avremmo pagato a caro prezzo. Lo zio la chiamò comunque in Italia con il desiderio di sposarla nonostante tutto, ma a quel punto erano le leggi di Norimberga che non permettevano un matrimonio misto fra un ebreo e una cristiana. I due volarono infine a Londra, dove si sposarono. Al loro ritorno, la moglie vide lo scopo principale della sua vita nel vendicarsi per i 20 anni persi, furono tramati innumerevoli intrighi che portarono allo sfascio della famiglia. Mio zio era comprensibilmente dalla parte di sua moglie e così mia madre, Alfred e io, benché assolutamente privi di mezzi, ci trasferimmo in un piccolo e assai povero alloggio a Cremona. Alfred continuava a lavorare e anch’io cercavo di guadagnare qualcosa facendo la babysitter. Mia madre voleva assolutamente che emigrassi in Inghilterra, il che era possibile
solo con l’aiuto del comitato ebraico di Milano. Allora per giovani donne ebree c’erano ancora delle possibilità di essere prese in Inghilterra come ragazze alla pari, ma per donne anziane come mia madre non sarebbe mai stato possibile e per gli uomini men che meno. Comprensibilmente avevo una grande paura di emigrare da sola, anche perché ero una ragazza che aveva sempre vissuto ben protetta e sostenuta dalla mia famiglia. Adesso però la mia partenza diventava necessaria, perché mia madre e mio fratello continuavano a dirmi che solo se io fossi andata avanti, loro avrebbero avuto la possibilità di raggiungermi, che io avrei trovato il modo per fare partire pure loro.
Il 16 agosto 1939, due settimane prima dell’inizio della guerra, presi l’aereo per l’Inghilterra.
Credevo di conoscere l’inglese abbastanza bene, ma una volta giunta a Londra dovetti ricredermi. Dovevo chiedere la strada per un posto piuttosto piccolo dove vivevano più mucche che persone. Chiesi al bobby come arrivare al comitato ebraico a Londra ed egli mi rispose in un inglese che non ero assolutamente in grado di capire. Ricordo che per aiutarmi a capire si mise a cantare “It’s a long way to...”. Visto che avevo imparato questa canzone a scuola, compresi che dovevo prendere un mezzo pubblico. Riuscii ad arrivare e da lì raggiunsi il paese in cui viveva la famiglia che mi avrebbe ospitato. Nelle prime due settimane tutto si svolse più o meno bene; la donna che aveva scritto quelle amorevoli lettere era una maestra, come pure suo marito, uno scozzese. Ma con l’inizio della guerra la donna diventò isterica. Continuava a gridare che si era presa il nemico straniero in casa e credeva di doversi rivalere su di me per tutto quanto di brutto potesse derivarle dalla guerra. Mi tormentava. Sopportai per due mesi e poi non seppi più cosa fare. Aveva sequestrato il mio passaporto e tutti gli oggetti di valore. Mia madre, infatti, mi aveva dato dell’argenteria. Mi restava un’unica possibilità, rivolgermi alla polizia. La polizia ascoltò la mia storia. Temevo che avrebbero creduto di più a una residente che a una straniera, invece no: dissero che conoscevano quella signora e che sarebbero subito intervenuti. Due poliziotti vennero con me, presero la mia valigia, obbligarono la donna a tirare fuori tutto ciò che mi aveva preso e mi portarono a Manchester. Il comitato ebraico mi procurò subito un lavoro lì. Fino al 1943 lavorai come donna di servizio e aiutante di un medico. Eravamo nel periodo peggiore della guerra. Ci furono numerosi bombardamenti a Manchester. Fra i miei compiti c’era quello di accompagnare un medico che girava la notte per curare feriti: in pratica correvo con una pila davanti alla macchina perché la città era immersa nel buio. Ciò però mi permise di farmi molti amici, numerosi pazienti mi conoscevano. Ebbi così l’ultima opportunità di scrivere a mia madre che nel frattempo mi ero sistemata bene. Ma non dissi che la maestra si era rivelata una bestia. Mentii raccontando che aveva avuto un altro bambino, per cui il lavoro era diventato troppo pesante per me e me ne ero andata, ma che adesso avevo un nuovo datore di lavoro che, “nomen est omen”, si chiamava Lewin, un medico ebreo. Lo accompagnavo spesso i fine settimana quando andava dai suoi genitori emigrati dalla Polonia durante la Prima guerra mondiale e ricordo che questi erano convinti che la causa di tutto erano gli ebrei tedeschi che si erano assimilati troppo, per cui Dio ci stava punendo. Ho passato in Inghilterra tutti gli anni della guerra. Riguardo gli inglesi ancor oggi devo riconoscere che sono stata nei bunker assieme a loro, con gli aerei tedeschi che volavano sopra di noi e mai uno di loro mi ha detto che quello non era il mio posto. Hanno veramente dimostrato grande comprensione e grande sensibilità.
Un giorno ebbi di nuovo l’occasione, dopo molti anni, di sentir parlare tedesco e per giunta il più stretto dialetto di Berlino. Ero venuta a sapere che a Manchester si era creata un’associazione culturale di emigrati dalla Germania. La sede, per mia fortuna, si trovava giusto a un chilometro di distanza dal luogo in cui abitavo; più di tanto, infatti, a noi non era consentito allontanarci da casa. E fu lì che nel 1943 conobbi colui che sarebbe diventato mio marito. Non era ebreo, era comunista, aveva fatto la resistenza fra la Germania e la Cecoslovacchia, poi si era rifugiato in Inghilterra. Allo scoppio della guerra era stato internato in Canada dagli inglesi, ma richiamato nel marzo 1943 perché avevano bisogno di braccia. Tre mesi dopo ci sposammo. Credo che il fatto di essere sola e sentire terribilmente la solitudine contribuì alla mia decisione di sposarmi dopo soli tre mesi. Sentivo il bisogno di potermi di nuovo appoggiare a qualcuno (lui aveva 13 anni più di me). Mio marito lavorava come elettricista a Manchester e io nel negozio di un ottico, dove mi occupavo dell’amministrazione e della vendita. Nel 1945 nacque nostra figlia Vera.
Vera aveva appena compiuto quattro settimane quando ebbi le prime notizie, prima dalla Croce Rossa e poi dal ministero degli esteri britannico. Nessuno nelle numerose famiglie di emigranti ebrei aveva ancora avuto notizie. Fui la prima. Una prima lettera smentiva che un certo Alfred Lewin fosse stato rinchiuso in un lager in Olanda; una seconda mi diceva della morte in Italia di mia madre e di mio fratello. Non riuscii a sapere altro.
Non credo sarei riuscita a sopravvivere a quella notizia se non avessi avuto la mia bambina da stringere fra le braccia. La sua esistenza fu così determinante che mi sono sentita sempre in debito verso di lei.
Sono passati 56 anni e in tutti questi anni mi ha sempre tormentato l’idea di non sapere come fossero finiti i miei. Pensavo che i loro corpi fossero stati sotterrati chissà dove. Quando altri portavano fiori sulle tombe dei loro cari, dicevo sempre: “Voi almeno potete farlo, io non saprei dove portarli”. Per cui il fatto di poter essere qui è come un sollievo”. È una storia che si chiude. Adesso posso pensare più serenamente alla loro morte. Quindi sono estremamente grata a chi ha reso possibile che io fossi qui.