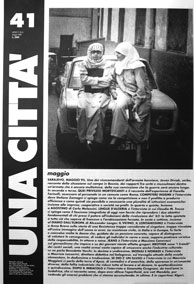Il dato più vistoso è senz’altro la rinuncia alla riforma della Scuola superiore come progetto globale da realizzare attraverso la via politica parlamentare. Non che mancassero in precedenza prove dell’impotentia generandi dei parlamenti di più legislature; il fatto nuovo degli anni recenti e dell’ultima gestione è la comparsa di iniziative concrete che testimoniano la scelta di strade diverse da quella della Grande Riforma. Si sono avviati su queste strade, non necessariamente convergenti verso gli stessi obiettivi, tre soggetti: il Governo, l’Apparato ministeriale, il Ministro della Pubblica Istruzione.
Vediamo come. Il Governo Berlusconi ha adottato misure di modifica all’assetto della scuola attraverso la Legge finanziaria per il ’95. Prima di lui aveva adoperato lo stesso strumento, con più ampi propositi, anche il Governo Ciampi (finanziaria per il ’94): quei propositi, anzi, sono stati adottati e riproposti dal Governo Berlusconi. Si tratta quindi di provvedimenti che nascono dall’esigenza della restrizione e del riordino della spesa pubblica e non da un intento diretto di riforma; eppure essi implicano trasformazioni anche radicali del volto della scuola. Le norme che prevedono l’autonomia degli Istituti superiori (art. 4 finanziaria ’94, art. 23 finanziaria ’95) segnano addirittura l’abbattimento dei pilastri centralistici e gerarchici su cui si regge il sistema scolastico vigente; ma non sono da sottovalutare, per le potenzialità riformatrici che contengono, le deleghe offerte al governo in materia di modifica degli Organi Collegiali e le disposizioni circa la nomina dei commissari per la Maturità ’95 nell’ambito del comune di residenza.
Accanto alla “via amministrativa” seguita dai governi anche l’Apparato del Ministero ha fatto sentire la sua azione modificatrice, in particolare sull’assetto didattico. Essa si è sviluppata al riparo dello sguardo della stampa e dell’opinione pubblica, osservatori del resto alquanto distratti ed incompetenti in tema di scuola. E infatti pochi sanno, per esempio, che si è di recente provveduto a “razionalizzare” le esperienze di sperimentazione di centinaia di scuole, razionalizzazione ottenuta disciplinando le iniziative secondo il piano di sperimentazione promosso e governato dal Ministero. L’operazione è motivata dall’obiettivo di mettere ordine nella folta vegetazione delle esperienze locali di innovazione didattica, ma produce anche l’effetto di chiudere la lunga libera stagione di innovazioni provenienti dal basso. Si tratta infatti di una svolta di tipo centralistico, che contrasta con il progetto di concessione dell’autonomia ai singoli Istituti: nei prossimi anni la “scuola militante” potrà difficilmente innovare senza l’ombrello protettivo del Ministero. La forza esercitata dal centro, del resto, la si avverte anche all’interno delle stesse sperimentazioni guidate, nelle quali le Direzioni Generali si sono mosse con molta decisione, anche quando si trattava di modificare curricoli di età venerabile e delicatissimi equilibri. E’ il caso, per esempio, dell’introduzione dello scritto di Fisica nel Liceo Scientifico e di quello di Matematica nel Classico, con tanto di valutazione quadrimestrale e finale, all’interno dei corsi con sperimentazione del Piano Nazionale di Informatica.
L’operazione è stata compiuta con semplice circolare: per le scuole interessate rifiutare di introdurre lo scritto nel curricolo avrebbe significato l’esclusione dalla Sperimentazione del Pni.
Più in generale l’Apparato esercita in varie forme, dalle circolari ai corsi di aggiornamento, una forte pressione per trasformare la didattica. Si tratta, grosso modo, di distoglierla dalla pratica tradizionale per avvicinarla a quella della media inferiore, introducendo una pratica pedagogica di tipo tecnologico, che si rifà soprattutto alla psicologia cognitiva, alla programmazione didattica per obiettivi e alle ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!