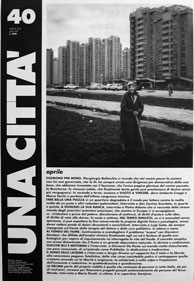A me sembra che le cose non siano andate nel migliore dei modi possibili: lo testimoniano il senso di disagio, di amarezza, di impotenza che in molti, insegnanti e genitori, abbiamo provato -quest’anno più ancora dell’anno passato.
Sono convinta che gli obiettivi politici di volta in volta escogitati dal movimento, e che ne costituiscono l’aspetto più appariscente, ne siano invece un ingrediente secondario, e fonte di equivoci: quando ad esempio su di essi si costituisce una unanimità di consensi che maschera agli occhi dei soggetti i termini reali del confronto. E’ più facile lottare contro il governo di turno che contro l’insegnante di tutti i giorni. Ma l’amplificazione giornalistica più o meno strumentale degli aspetti politici, se dà agli studenti l’illusione momentanea di contare qualcosa, di essere qualcuno, rende più amaro e intollerabile il ritorno a una normalità che li mortifica; dove gli stessi insegnanti che sono stati solidali con gli aspetti politici della lotta, sono pronti alla vendetta sulla ribellione scolastica e generazionale. A me appare chiaro che il movente reale di queste cicliche agitazioni (che la vox populi dà per scontato si ripeteranno regolarmente ad ogni inizio d’anno) sia duplice: 1- la scuola è un luogo dove si sta male, ed è uno star male che non ha più un significato accettabile (la sofferenza può essere accettata, soprattutto da un giovane, solo se ritiene che ne valga veramente la pena); 2- la scuola rimane l’unico luogo dove può avvenire in forme non distruttive o autolesionistiche un confronto tra generazioni che è di importanza vitale per la formazione degli adolescenti, ma che la società contemporanea non consente più, avendo abolito riti e simbologie ritenuti primitivi e crudeli senza sostituirvi nulla di altrettanto significativo.
Non in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, ma in una misura che non può essere ignorata, negli intervalli tra un ciclo di agitazioni e l’altro, il rifiuto della scuola si esprime epidemicamente in un assenteismo di proporzioni paurose, che riduce la durata media di un anno scolastico -in molti istituti tecnici e professionali- a un numero ridicolo di giornate; ammesso che si possa ancora parlare di “anno scolastico” quando il processo di apprendimento avvenga a corrente alternata, due giorni sì e tre no. E’ una realtà su cui si tace, così come specularmente si tace sul fatto che i licei statali si reggono su una mastodontica struttura privata di ripetizioni, tramite le quali le famiglie sono costrette a pagare lo scotto per un privilegio di status logoro, ma ancora funzionante. Basterebbero questi due aspetti per rendere le operazioni di valutazione finale, sia di promozione che di bocciatura, ugualmente arbitrarie, fino a quel trionfo dell’arbitrio e dell’ipocrisia che è l’esame di maturità. Ma riconoscere pubblicamente queste realtà equivarrebbe, più o meno, a una dichiarazione di bancarotta (fraudolenta) da parte dell’istituzione scolastica.
Che le periodiche esplosioni del movimento siano l’autolegittimazione in forma politica di uno spontaneo ed endemico rifiuto di massa lo si constata nella fase finale quando, esauritasi la mobilitazione politica, l’obiettivo esplicito diventa “arrivare a Natale”: cioè portare a compimento l’abolizione dell’anno scolastico, almeno nella sua prima metà. Coloro che guidano la lotta in questa fase sono solo in parte gli studenti politicizzati, più spesso sono coloro che sentono di avere il mandato, da parte di una massa che può così tranquillamente starsene a casa, a “sospendere i lavori”: puramente e semplicemente. La natura inconscia e ambigua di questo mandato spiega l’assenza di ogni regola democratica nel rapporto tra occupanti e massa: violazione del principio di maggioranza, violazione sistematica del voto assembleare ecc. Un aspetto interessante è che, mentre la parte politica del movimento viene gestita per lo più dai “grandi” delle ultime classi, membri dei comitati che tradizionalmente dominano nelle scuole e c ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!