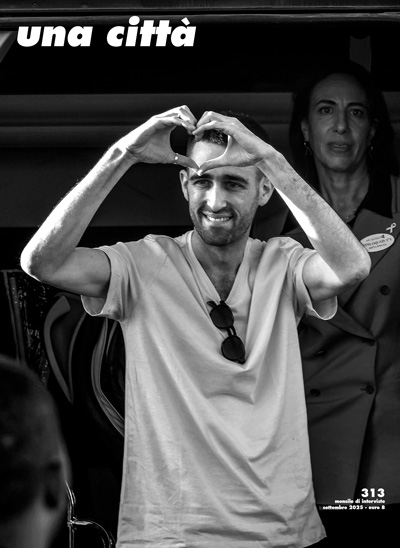Lavoratori senza rappresentanza
cosa sta succedendo

Una Città n° 310 / 2025 maggio-giugno
Intervista a Sheri Berman
Realizzata da Barbara Bertoncin
LAVORATORI SENZA RAPPRESENTANZA
Contestualmente a uno spostamento al centro sulle questioni economiche, all’inizio del XXI secolo i partiti socialdemocratici si sono invece spostati a sinistra sui temi socio-culturali, immigrazione, multiculturalismo, ecc. con l’effetto di creare un “gap di rappresentanza” nella loro base portando molti lavoratori a votare partiti di destra, gli unici a dar voce, pur strumentalmente, alle loro preoccupazioni. Da dove ricominciare? Intervista a Sheri Berman.
Sheri Berman è professoressa di Scienze politiche presso il Barnard College, Columbia University. I suoi interessi di ricerca includono lo sviluppo della democrazia e della dittatura, la politica europea, il populismo e il fascismo, e la storia della sinistra. Il suo attuale progetto di ricerca si intitola “The Political Consequences of Economic Ideas: Neoliberalism, the Left, and the Fate of Democracy”.
Iniziamo dallo stato di salute della sinistra. I tuoi lavori precedenti si sono concentrati sullo spostamento dei partiti di sinistra verso il centro nelle questioni economiche. Oggi una delle questioni più spinose e al contempo cruciali a sinistra è l’immigrazione.
Negli anni Novanta abbiamo assistito a una riduzione della distanza tra i partiti di centro-sinistra e di centro-destra sulle questioni economiche. Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, nel periodo di massimo splendore del neoliberismo, anche i partiti laburisti, socialdemocratici e socialisti, hanno accettato alcuni dei principi e alcune politiche sostenute dai neoliberali.
Questo passaggio ha comportato una serie di conseguenze importanti. In primo luogo, ha indebolito il “brand” del centrosinistra, intendendo con questo termine ciò che gli elettori associano a un partito. Quando pensiamo a un partito: cosa rappresenta per noi, quali sono le sue politiche distintive, quali gli obiettivi a lungo termine? Durante i decenni del dopoguerra, il centro-sinistra aveva un profilo e un programma economico piuttosto chiari: la sua collocazione prevedeva un’accettazione del capitalismo, accanto però a politiche interventiste che si occupavano, in particolare, dei lavoratori colpiti dai cambiamenti del mercato, e dei meno abbienti, ecc. Questa fisionomia, con il passare del tempo, è sfumata per poi avvicinarsi al neoliberismo alla fine del XX secolo.
Via via che questi partiti si allontanavano dalla loro agenda tradizionale, che era contraddistinta da quello che potremmo definire un “programma di classe”, i loro elettori tradizionali a loro volta li abbandonavano. I vecchi partiti erano fisiologicamente associati alla classe operaia, e in generale ai lavoratori a basso reddito e senza istruzione universitaria. Molti di questi all’inizio si sono trovati un po’ alla deriva, come dire, in uno stato di apatia o alienazione e semplicemente hanno smesso di votare.
Questa è la prima osservazione da fare e riguarda appunto una sorta di convergenza economica che si è verificata tra il centro-sinistra e il centro-destra tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo.
Venendo alla seconda parte della tua domanda, relativa non solo al tema dell’immigrazione, ma direi più in generale alle questioni sociali e culturali, è importante sottolineare come proprio quello spostamento abbia avuto un impatto cruciale su tutta una serie di problemi. L’avvicinamento nei programmi economici tra i partiti tradizionali ha infatti avuto come effetto che gli elettori, non vedendo differenze sostanziali, hanno cominciato a prestare attenzione ad altri temi e interessi per decidere chi votare. È logico, no? Gli scienziati politici parlano di uno “shift”, di uno spostamento dell’asse della concorrenza politica verso questioni non economiche, dove i partiti tornavano a essere diversi.
Nello stesso periodo, anche nel tentativo di recuperare un profilo progressista, molti partiti di centro-sinistra si sono spostati a sinistra su questioni socio-culturali, a favore dell’immigrazione, del multiculturalismo, ecc. Quindi c’è stato, contemporaneamente, un avvicinamento alle loro controparti di centro-destra sulle questioni economiche, e un allontanamento su altre faccende.
Un’altra tendenza parallela che emerge in questo periodo è che i partiti di centro-sinistra iniziano a essere sempre più dominati dal tipo di persone che probabilmente leggeranno questa intervista, elettori colti, con una formazione universitaria e che negli ultimi 15-20 anni si sono spostati più a sinistra sulle questioni sociali e culturali. In qualche modo questi partiti si spostano insieme alle persone che li guidano e agli elettori a cui si rivolgono. Parliamo di tendenze in un certo senso interattive. Sono fenomeni legati l’uno all’altro in modi interessanti e complicati.
In questo sommovimento tu denunci l’emergere di un “gap di rappresentazione”. Puoi spiegare?
Torniamo alla questione di questi partiti di centro-sinistra che si allontanano dai loro elettori tradizionali. Come ricordavo, nei primi decenni del dopoguerra, i partiti di centro-sinistra in Europa occidentale avevano una base elettorale fortemente dominata da basso reddito e basso livello di istruzione. Teniamo presente che questi elettori erano tendenzialmente tra il moderato e il conservatore sulle questioni sociali e culturali, ma siccome la competizione politica era strutturata principalmente sulle questioni economiche, erano queste a orientare il voto. All’inizio del XXI secolo avvengono i due fenomeni cui ho già accennato: i partiti di centro-sinistra si spostano a sinistra sui temi sociali e culturali e verso il centro su quelli economici.
Questo crea un divario, che gli scienziati politici chiamano “gap di rappresentanza”, tra i partiti di centro-sinistra, che hanno abbandonato il profilo operaio come tratto distintivo, e gli elettori su cui tradizionalmente facevano affidamento, i quali, come dicevo, avevano posizioni moderate o conservatrici proprio sui temi in cui i “loro” vecchi partiti andavano assumendo posizioni più radicali.
Veniamo alla questione dell’immigrazione. Tu stessa metti in guardia sul fatto che, se non si affrontano i temi che preoccupano tante persone, si finisce nei guai. Infatti i guai sono arrivati. Basta guardare ai risultati delle ultime elezioni. E tuttavia non possiamo credere che tutti i lavoratori siano diventati improvvisamente xenofobi e razzisti. Quindi cosa sta succedendo?
Permettimi di dire due cose, collegate tra loro. Comincerò dal tuo ultimo punto, ovvero che non c’è assolutamente alcuna prova, in base ai sondaggi condotti, che le persone a basso reddito e senza istruzione universitaria, in Europa occidentale, o comunque in Europa e Stati Uniti, siano diventate più xenofobe o razziste nel corso del tempo.
Questa è la spiegazione più facile che viene proposta per l’ascesa del populismo di destra e la crescente popolarità di questi partiti tra i lavoratori. Ma, ripeto, non c’è alcuna evidenza per questa affermazione. Se si guardano le rilevazioni, a partire dagli anni Settanta e Ottanta, tutti questi gruppi in realtà sono diventati più progressisti.
Quello che osserviamo è che, a partire dal 2010 circa, le persone con un titolo di studio universitario hanno evidenziato un rapido e costante spostamento verso sinistra. Quindi si è creato un crescente divario tra gli elettori istruiti e quelli non istruiti sulle tematiche sociali e culturali. Ma, nel complesso, la tendenza secolare è rimasta orientata verso una minore xenofobia e un minor razzismo. Quindi una correlazione diretta tra scarsa istruzione e voto per l’estrema destra non è confortata dai dati.
Come si spiega allora il fatto che i partiti che nei loro slogan fanno appelli xenofobi o addirittura razzisti raccolgono la preferenza di una parte di questi elettori? Questo ci riporta al tema della rappresentanza. Quello che succede è che questi elettori si guardano intorno e dicono: “Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo nelle nostre società. È in corso un cambiamento demografico incredibilmente rapido. Siamo allarmati per l’ordine pubblico, per il terrorismo…”. Dall’altra parte, i partiti di centro-sinistra, quando i loro elettori esprimono questo disagio, non offrono alcuna risposta; anzi, sembrano non riconoscere nemmeno l’esistenza di un problema. Questo produce una situazione in cui gli unici partiti a dare voce a queste preoccupazioni rimangono quelli populisti di estrema destra. Questi ultimi, poi, non si limitano a riconoscere il problema, ma giocano sulla paura e sull’ansia per attirare gli elettori.
In tutto questo c’è un’altra tendenza in atto e cioè che in molti paesi europei i partiti di centro-destra tradizionali si sono anch’essi spostati un po’ più a sinistra su questi temi. Se pensiamo al Partito conservatore di David Cameron o al Partito cristiano democratico di Angela Merkel, avevano entrambi posizioni conservatrici, non solo in materia economica, ma anche sui temi socio-culturali. In questi ultimi anni anche questi partiti hanno subìto una trasformazione che li ha portati a essere un po’ più progressisti sui temi culturali e sociali, allargando quel gap di rappresentanza di cui parlavamo.
Anche a sinistra abbiamo assisito ad alcuni esperimenti; penso al partito di Sahra Wagenknecht...
Si tratta di un caso molto interessante. Lei arriva da un partito che è erede del comunismo, quindi di estrema sinistra. Cerca di mettere insieme questo background con una posizione fortemente di destra sui temi dell’immigrazione. Devo dire che ciò che trovo bizzarro di questo partito è che è piuttosto estremo su entrambe le cose. Non è un partito con un profilo socialdemocratico sul piano economico e anche sull’immigrazione non propone un approccio di centro-sinistra vecchio stile, fondato sull’uguaglianza di tutti gli esseri umani, per cui è giusto offrire aiuto a chi ne ha bisogno, ma con un approccio prudente. Quello che il partito di Sahra Wagenknecht propone è una ricetta di estrema destra. Un partito davvero strano. Il suo obiettivo era verosimilmente quello di conquistare gli elettori dell’Afd che cercavano politiche economiche più di sinistra.
Abbiamo parlato dei paesi dell’Europa occidentale, e i paesi dell’Europa centrale e orientale? Vedi emergere dinamiche differenti?
Direi che ci sono delle somiglianze, ma anche delle differenze cruciali. La principale e più ovvia, che impone di fare paragoni con grande cautela, è che alcuni di questi paesi sono il prodotto del crollo dell’Unione Sovietica; hanno ottenuto la loro indipendenza dopo il 1989 e quindi non hanno un background di democrazia liberale.
Ciò in parte spiega come mai, nonostante le grandi aspettative e la fiducia riposte sul loro tragitto, questi paesi abbiano espresso il sostegno a partiti non solo xenofobi, ma talvolta apertamente antidemocratici. Questo può rattristare, ma non deve sorprendere perché si tratta di aree che non vantano una storia e un’esperienza consolidata di liberalismo e democrazia.
Quindi, si possono fare dei confronti, però dovremmo stare attenti a paragonare queste forze esplicitamente antidemocratiche con ciò che accade in Europa occidentale. Anche qui vedo dei partiti che potremmo collocare nella categoria di quelli esplicitamente antidemocratici; penso ad Alba Dorata in Grecia e probabilmente all’Afd in Germania, ma molti partiti anche di destra radicale non sono in realtà antidemocratici; possono essere molto conservatori, con posizioni estreme, ma non rappresentano una minaccia per l’ordine democratico, almeno non nella loro attuale incarnazione. Probabilmente altri scienziati politici mi contesterebbero, ma, ad esempio, non metterei l’attuale versione del Rassemblement National in Francia in quella categoria, né ci metterei il partito di Meloni.
Sono partiti molto conservatori su una serie di questioni, ma non rappresentano un pericolo chiaro e attuale per la democrazia. Altro discorso va fatto per Orban o Diritto e giustizia in Polonia. Anche in questo caso, il contesto dell’Europa centro-orientale è molto diverso da quello dell’Europa occidentale.
Quello che sta succedendo negli Stati Uniti ha a che fare con questi discorsi? Si è detto che il non aver affrontato la questione dell’immigrazione sia una delle ragioni che hanno fatto vincere Trump.
È proprio così. Se si guardano i dati sulle elezioni del 2024, l’immigrazione, insieme all’economia, sono stati i grandi temi che hanno orientato il voto degli americani. La situazione è dunque in qualche modo assimilabile a quanto avvenuto in Europa. Di nuovo, gli elettori erano delusi per l’incapacità, o la riluttanza, della precedente amministrazione democratica ad affrontare la questione. Questo però è ben diverso dal sostenere esplicitamente il genere di cose che Trump sta facendo ora, come far sparire gli stranieri illegali, separare le famiglie...
Dobbiamo stare attenti a non confondere le critiche di questi elettori ai partiti di centro-sinistra con l’appoggio indiscriminato ai partiti populisti di destra. Queste persone pretendono che si faccia qualcosa; la loro è una reazione alla mancanza di iniziative da parte dei partiti tradizionali.
Gli elettori americani da tempo avevano espresso preoccupazione per il tasso di immigrazione illegale. Negli Stati Uniti ci sono letteralmente milioni e milioni di immigrati clandestini.
Forse va bene così. Resta il fatto che molti elettori erano angosciati per la situazione e il Partito democratico si è rifiutato di riconoscere che si trattava di un problema reale. Trump ha avuto così l’opportunità di convogliare su di sé tutta l’insoddisfazione creata da questo vuoto di proposte. Ovviamente, ripeto, questo non significa che non ci siano altri modi per affrontare la questione, ma il fatto che i democratici abbiano negato il problema ha suscitato un diffuso sentimento di rabbia tra i suoi elettori, perfino tra gli immigrati regolari.
Dicevi che l’incapacità, a sinistra, di distinguere tra la frustrazione per i problemi generati dall’immigrazione clandestina e il razzismo vero e proprio, è stato un altro grave errore.
Certamente, primo perché è un’equiparazione empiricamente scorretta e, in secondo luogo, perché così ha rinunciato ad appellarsi a quegli elettori che non sono affatto razzisti e xenofobi. I partiti di centro-sinistra ovviamente non devono rivolgersi a razzisti e xenofobi. Non è quello il nostro “brand”. E però un partito di sinistra deve saper parlare con i lavoratori preoccupati per gli effetti dell’immigrazione clandestina. Se invece li ignoriamo o li confondiamo con i razzisti, li consegniamo su un piatto d’argento a partiti pronti a sfruttare questi sentimenti di paura per scopi molto negativi. È una dinamica da non sottovalutare e il caso americano dovrebbe servirci da lezione.
Abbiamo parlato degli errori commessi dalla sinistra. Vedi in Europa qualche modello da seguire?
I problemi che la sinistra si trova oggi ad affrontare non sono la conseguenza di decisioni politiche sbagliate fatte negli ultimi anni. Torniamo un po’ al discorso iniziale e alla scelta, che risale agli anni Novanta, di abbracciare gran parte dell’agenda neoliberale, contribuendo così a spostare la competizione politica dalle questioni economiche a quelle non economiche. Una dinamica che ha portato gli attuali partiti di centro-sinistra a non rappresentare più la classe operaia, bensì le persone istruite, con un buon reddito e attente ai temi culturali. Questa evidentemente non è una cosa che si può cambiare da un giorno all’altro.
Penso che, se i partiti di sinistra vogliono tornare ad avere, non dico una vocazione maggioritaria, ma almeno un numero di voti sufficienti a contrastare le coalizioni dominanti, devono impegnarsi in una strategia a lungo termine che abbia come obiettivo principale quello di riportare la concorrenza politica sulle questioni economiche. Questo vuol dire anche approntare strategie valide per affrontare le sfide che le società si trovano ad affrontare oggi. Non sto dicendo che sia facile, ma questa è l’unica strada percorribile per il centro-sinistra.
Penso a un partito con un’impostazione, diciamo, tradizionale, con un profilo e delle aspirazioni socialdemocratiche. Per cui se il capitalismo va bene per generare crescita e innovazione, resta il fatto che ci dobbiamo far carico del suo impatto negativo sui soggetti più vulnerabili.
Serve un’agenda in grado di convincere gli elettori a tornare a votare sulla base delle loro preferenze economiche. Se a orientare il voto restano le preferenze sociali e culturali, gli elettori saranno più facilmente spinti verso i partiti di estrema sinistra o, dall’altra parte, verso i partiti populisti.
C’è qualche partito di sinistra, socialdemocratico, che si sta muovendo in questa direzione?
Ce ne sono diversi che ci stanno provando. Il partito danese è quello di cui più si parla. Qualcuno lo accusa di essersi spostato verso il centro o addirittura verso la destra. Personalmente non la vedo così. Anche il partito socialdemocratico svedese sta tentando di compiere un’operazione simile: si è concentrato quasi esclusivamente sulle questioni economiche, cercando di spostare il proprio programma a sinistra.
Alla fine, il modo migliore per affrontare le questioni legate all’immigrazione è quello di assicurarsi che tutti abbiano un lavoro, che nessuno sia costretto a vivere di sussidi, eccetera.
In fondo è quello che noi socialdemocratici sappiamo fare meglio. Se vogliamo, i partiti di centro-destra hanno un problema analogo perché sono quelli che hanno perso più elettori a vantaggio dei partiti di estrema destra. Quindi, in prospettiva, anch’essi hanno interesse a riportare la discussione sulle questioni economiche. In un contesto di questo tipo, i partiti di estrema sinistra e quelli populisti di destra avrebbero senz’altro meno successo.
Sul tema dell’accoglienza, le formule oscillano tra due polarità: accoglierli tutti o creare una fortezza, un muro. Per quanto riguarda la convivenza, in questi anni abbiamo assistito alla crisi sia del modello universalista francese che di quello multiculturale inglese. Quale dovrebbe essere un modello socialdemocratico?
Le questioni sono tante, ma direi che la prima domanda a cui dobbiamo dare risposta è: quante persone possiamo accogliere? La seconda: una volta che sono qui, cosa dobbiamo aspettarci da loro e cosa possiamo pretendere da loro? Come dobbiamo porci con questi nuovi membri della nostra comunità?
Se questi sono i nodi, direi che, sia in Europa occidentale che negli Stati Uniti, è importante valutare l’opportunità di una sorta di rallentamento e di revisione del numero degli accessi.
Per il centro-sinistra, ovviamente, questo non può significare abbandonare le persone in fuga da situazioni difficili. Un partito socialdemocratico si preoccupa dei rifugiati, delle persone che fuggono da guerre e conflitti, o anche da situazioni economiche drammatiche, perché tutto questo rientra nelle sue aspirazioni universaliste.
Tuttavia, un rallentamento è importante, non solo per motivi politici, ma anche perché l’accoglienza dei rifugiati è diversa da quella dei migranti per motivi economici.
Quindi un primo tema è: quante persone possiamo far entrare? E poi c’è l’altra questione: la differenza tra il modello inglese e quello assimilazionista perlopiù associato alla Francia. Il modello britannico si è rivelato problematico per molte ragioni, non ultima il fatto che è molto difficile creare una società coesa se non si incoraggiano le persone ad assimilarsi economicamente, socialmente e culturalmente. Questo non significa necessariamente che tutti debbano vivere esattamente nello stesso modo, o che chi si trasferisce in un altro paese debba abbandonare le proprie tradizioni e la propria storia. Sarebbe un approccio vagamente totalitario.
Detto questo, alcune cose sono considerate doverose: la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole del gioco, l’accettazione delle norme sociali e culturali del paese in cui ci si trova. Mi rendo conto di essere vaga, ma perché è molto difficile stabilire dei confini tra delle aspettative ragionevoli e il tentativo di imporre una monocultura. La sinistra non dovrebbe essere coinvolta in quest’ultimo compito, e tuttavia non può nemmeno approvare contesti in cui si creino delle sorte di società parallele, come abbiamo visto in Gran Bretagna.
I partiti di centro-sinistra in particolare, ma anche i partiti conservatori tradizionali, dovrebbero essere in grado di affrontare tali questioni senza fare concessioni al razzismo o alla xenofobia. Un democratico liberale non può ammettere che le persone siano giudicate sulla base di qualcosa di diverso dalle loro qualità individuali. Non possono esserci cittadini di seconda classe in base alle appartenenze etniche o religiose. D’altro canto, dal punto di vista della collettività, trovo perfettamente legittimo che i partiti di centro-sinistra si impegnino per creare e mantenere una qualche forma di cultura comunitaria coesa, con regole del gioco condivise. Ovviamente tutto questo non è affatto facile e si tratta di processi graduali.
C’è un dibattito interno tra i democratici su questi temi?
I dibattiti sull’immigrazione sono incentrati sui numeri molto più che sui temi dell’assimilazione. Questa diversità ha a che fare con la storia degli Stati Uniti, che è diversa da quella dell’Europa, così come sono diversi gli immigrati che arrivano. Ma qui il vero problema sono i numeri. Tant’è che molti nuovi immigrati hanno appoggiato, o perlomeno tollerato, molta della retorica di Trump che in effetti aveva come bersaglio gli immigrati clandestini, non le persone come loro, che hanno un lavoro, sono in regola, ecc.
Il dibattito poi si estende a quale strategia adottare con Trump. Alcuni dicono: “Guardate che alla fine farà un tale casino che si danneggerà da solo, per cui noi ci limiteremo a raccogliere i pezzi e ricominciare…”. Altri auspicano una strategia più offensiva. Su questo c’è un’ampia discussione in corso all’interno del Partito democratico e in generale tra i progressisti, i gruppi della società civile, gli accademici, gli attivisti. Sono tutte questioni molto sentite oggi.
Non abbiamo parlato dell’antiamericanismo che caratterizza tanti partiti di sinistra in Europa…
È una questione che ha un aspetto anche divertente, se vogliamo, perché una delle peculiarità della politica europea è che l’antiamericanismo è un tratto comune sia all’estrema destra che all’estrema sinistra. In questi ultimi anni poi le cose sono peggiorate, per una serie di motivi, non ultimo il fatto che Trump ha messo in crisi i posizionamenti tradizionali. Penso alle esternazioni sull’Afd in Germania o alle dichiarazioni di J. D. Vance quando si è recato a Monaco o ai commenti di Marco Rubio contro la sentenza della corte Costituzionale tedesca che ha dichiarato l’Afd un partito estremista. L’estrema destra tedesca è tradizionalmente molto antiamericana, ma questo inedito sostegno sta rimescolando le carte. Non dobbiamo poi dimenticare che i trumpiani sono molto diversi dal Partito repubblicano tradizionale...
Insomma, è evidente che l’antiamericanismo non ha più molto senso, né dal punto di vista pratico, né dal punto di vista intellettuale. Stanno succedendo cose molto strane nelle relazioni transatlantiche.
Comunque, se nell’estrema destra le cose sono un po’ cambiate, nell’estrema sinistra l’antiamericanismo resiste, anche se in modo stratificato: all’aspetto anti-Trump si sovrappone ora il sentimento anti-israeliano. Anche qui è curioso come invece nell’estrema destra si stia consolidando un atteggiamento perlomeno di tolleranza verso Israele; un fenomeno insolito dal punto di vista storico.
E poi c’è la guerra: sia quella in Ucraina che quella a Gaza hanno creato alleanze nuove e talvolta inattese. Anche qui è curioso come l’estrema sinistra e l’estrema destra si trovino entrambe a simpatizzare per la Russia. In fondo, questo non è così anomalo per l’estrema sinistra; è decisamente più strano per l’estrema destra. Di queste dinamiche arrivano gli echi anche negli Stati Uniti, dove i trumpisti sono, se non filo-russi, certamente simpatizzanti di Putin. Per quanto riguarda la sinistra, in questo momento Israele è diventato un problema più grosso di quello costituito dall’Ucraina. Al contrario, l’estrema destra si trova improvvisamente ad abbracciare, non solo la causa israeliana, ma proprio Netanyahu, che è in fondo lui stesso un uomo di estrema destra. Siamo davanti a un vero sconvolgimento, a un totale rimescolamento dello spettro politico che conoscevamo.
Per concludere? In fondo lo stato di salute della sinistra è legato allo stato di salute della democrazia...
Vorrei essere più fiduciosa. Parte del problema è che in questo momento sono seduta qui negli Stati Uniti dove, onestamente, la situazione appare parecchio peggiore di quella dell’Europa occidentale. Non solo perché abbiamo quest’amministrazione di estrema destra, ma anche perché la sinistra è divisa e incapace di adottare strategie per rafforzare l’unità interna.
Non sono particolarmente ottimista sugli Stati Uniti, anche se penso che Trump, i trumpiani, dovranno presto fare i conti con le conseguenze delle cose che hanno fatto. E tuttavia, se il Partito democratico dovesse vincere le elezioni di midterm più sulla base dei fallimenti dei trumpiani piuttosto che per proprio merito, beh, non sarebbe una cosa positiva nel lungo termine. Ovviamente sarebbe meglio che il Partito democratico riconquistasse del potere perché vorrebbe dire che l’ha sottratto ai repubblicani, però nel lungo periodo, se non hai qualcosa da offrire, ma ti limiti ad approfittare dell’insoddisfazione degli elettori nei confronti della destra, i problemi di fondo rimarranno irrisolti.
Per rispondere alla tua domanda, credo che la democrazia, per funzionare bene, abbia assolutamente bisogno di un forte centro-sinistra... e anche di un forte centro-destra. La stabilità relativa che abbiamo conosciuto in Europa occidentale nel Dopoguerra era anche dovuta al fatto che il sistema era dominato da partiti di centro-sinistra e di centro-destra che accettavano le regole del gioco democratico; insomma, pur avendo programmi diversi, agivano all’interno di un quadro condiviso, accettato. La crisi di entrambi i soggetti ha contribuito a far emergere le dinamiche molto preoccupanti a cui stiamo assistendo.
Anche per questo è importante osservare se e come questi due partiti mainstream (quelli che qualcuno oggi definisce anche establishment) riusciranno a riconquistare i loro elettori. Diversamente ci aspetta un lungo periodo di instabilità.
(a cura di Barbara Bertoncin)
Iniziamo dallo stato di salute della sinistra. I tuoi lavori precedenti si sono concentrati sullo spostamento dei partiti di sinistra verso il centro nelle questioni economiche. Oggi una delle questioni più spinose e al contempo cruciali a sinistra è l’immigrazione.
Negli anni Novanta abbiamo assistito a una riduzione della distanza tra i partiti di centro-sinistra e di centro-destra sulle questioni economiche. Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, nel periodo di massimo splendore del neoliberismo, anche i partiti laburisti, socialdemocratici e socialisti, hanno accettato alcuni dei principi e alcune politiche sostenute dai neoliberali.
Questo passaggio ha comportato una serie di conseguenze importanti. In primo luogo, ha indebolito il “brand” del centrosinistra, intendendo con questo termine ciò che gli elettori associano a un partito. Quando pensiamo a un partito: cosa rappresenta per noi, quali sono le sue politiche distintive, quali gli obiettivi a lungo termine? Durante i decenni del dopoguerra, il centro-sinistra aveva un profilo e un programma economico piuttosto chiari: la sua collocazione prevedeva un’accettazione del capitalismo, accanto però a politiche interventiste che si occupavano, in particolare, dei lavoratori colpiti dai cambiamenti del mercato, e dei meno abbienti, ecc. Questa fisionomia, con il passare del tempo, è sfumata per poi avvicinarsi al neoliberismo alla fine del XX secolo.
Via via che questi partiti si allontanavano dalla loro agenda tradizionale, che era contraddistinta da quello che potremmo definire un “programma di classe”, i loro elettori tradizionali a loro volta li abbandonavano. I vecchi partiti erano fisiologicamente associati alla classe operaia, e in generale ai lavoratori a basso reddito e senza istruzione universitaria. Molti di questi all’inizio si sono trovati un po’ alla deriva, come dire, in uno stato di apatia o alienazione e semplicemente hanno smesso di votare.
Questa è la prima osservazione da fare e riguarda appunto una sorta di convergenza economica che si è verificata tra il centro-sinistra e il centro-destra tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo.
Venendo alla seconda parte della tua domanda, relativa non solo al tema dell’immigrazione, ma direi più in generale alle questioni sociali e culturali, è importante sottolineare come proprio quello spostamento abbia avuto un impatto cruciale su tutta una serie di problemi. L’avvicinamento nei programmi economici tra i partiti tradizionali ha infatti avuto come effetto che gli elettori, non vedendo differenze sostanziali, hanno cominciato a prestare attenzione ad altri temi e interessi per decidere chi votare. È logico, no? Gli scienziati politici parlano di uno “shift”, di uno spostamento dell’asse della concorrenza politica verso questioni non economiche, dove i partiti tornavano a essere diversi.
Nello stesso periodo, anche nel tentativo di recuperare un profilo progressista, molti partiti di centro-sinistra si sono spostati a sinistra su questioni socio-culturali, a favore dell’immigrazione, del multiculturalismo, ecc. Quindi c’è stato, contemporaneamente, un avvicinamento alle loro controparti di centro-destra sulle questioni economiche, e un allontanamento su altre faccende.
Un’altra tendenza parallela che emerge in questo periodo è che i partiti di centro-sinistra iniziano a essere sempre più dominati dal tipo di persone che probabilmente leggeranno questa intervista, elettori colti, con una formazione universitaria e che negli ultimi 15-20 anni si sono spostati più a sinistra sulle questioni sociali e culturali. In qualche modo questi partiti si spostano insieme alle persone che li guidano e agli elettori a cui si rivolgono. Parliamo di tendenze in un certo senso interattive. Sono fenomeni legati l’uno all’altro in modi interessanti e complicati.
In questo sommovimento tu denunci l’emergere di un “gap di rappresentazione”. Puoi spiegare?
Torniamo alla questione di questi partiti di centro-sinistra che si allontanano dai loro elettori tradizionali. Come ricordavo, nei primi decenni del dopoguerra, i partiti di centro-sinistra in Europa occidentale avevano una base elettorale fortemente dominata da basso reddito e basso livello di istruzione. Teniamo presente che questi elettori erano tendenzialmente tra il moderato e il conservatore sulle questioni sociali e culturali, ma siccome la competizione politica era strutturata principalmente sulle questioni economiche, erano queste a orientare il voto. All’inizio del XXI secolo avvengono i due fenomeni cui ho già accennato: i partiti di centro-sinistra si spostano a sinistra sui temi sociali e culturali e verso il centro su quelli economici.
Questo crea un divario, che gli scienziati politici chiamano “gap di rappresentanza”, tra i partiti di centro-sinistra, che hanno abbandonato il profilo operaio come tratto distintivo, e gli elettori su cui tradizionalmente facevano affidamento, i quali, come dicevo, avevano posizioni moderate o conservatrici proprio sui temi in cui i “loro” vecchi partiti andavano assumendo posizioni più radicali.
Veniamo alla questione dell’immigrazione. Tu stessa metti in guardia sul fatto che, se non si affrontano i temi che preoccupano tante persone, si finisce nei guai. Infatti i guai sono arrivati. Basta guardare ai risultati delle ultime elezioni. E tuttavia non possiamo credere che tutti i lavoratori siano diventati improvvisamente xenofobi e razzisti. Quindi cosa sta succedendo?
Permettimi di dire due cose, collegate tra loro. Comincerò dal tuo ultimo punto, ovvero che non c’è assolutamente alcuna prova, in base ai sondaggi condotti, che le persone a basso reddito e senza istruzione universitaria, in Europa occidentale, o comunque in Europa e Stati Uniti, siano diventate più xenofobe o razziste nel corso del tempo.
Questa è la spiegazione più facile che viene proposta per l’ascesa del populismo di destra e la crescente popolarità di questi partiti tra i lavoratori. Ma, ripeto, non c’è alcuna evidenza per questa affermazione. Se si guardano le rilevazioni, a partire dagli anni Settanta e Ottanta, tutti questi gruppi in realtà sono diventati più progressisti.
Quello che osserviamo è che, a partire dal 2010 circa, le persone con un titolo di studio universitario hanno evidenziato un rapido e costante spostamento verso sinistra. Quindi si è creato un crescente divario tra gli elettori istruiti e quelli non istruiti sulle tematiche sociali e culturali. Ma, nel complesso, la tendenza secolare è rimasta orientata verso una minore xenofobia e un minor razzismo. Quindi una correlazione diretta tra scarsa istruzione e voto per l’estrema destra non è confortata dai dati.
Come si spiega allora il fatto che i partiti che nei loro slogan fanno appelli xenofobi o addirittura razzisti raccolgono la preferenza di una parte di questi elettori? Questo ci riporta al tema della rappresentanza. Quello che succede è che questi elettori si guardano intorno e dicono: “Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo nelle nostre società. È in corso un cambiamento demografico incredibilmente rapido. Siamo allarmati per l’ordine pubblico, per il terrorismo…”. Dall’altra parte, i partiti di centro-sinistra, quando i loro elettori esprimono questo disagio, non offrono alcuna risposta; anzi, sembrano non riconoscere nemmeno l’esistenza di un problema. Questo produce una situazione in cui gli unici partiti a dare voce a queste preoccupazioni rimangono quelli populisti di estrema destra. Questi ultimi, poi, non si limitano a riconoscere il problema, ma giocano sulla paura e sull’ansia per attirare gli elettori.
In tutto questo c’è un’altra tendenza in atto e cioè che in molti paesi europei i partiti di centro-destra tradizionali si sono anch’essi spostati un po’ più a sinistra su questi temi. Se pensiamo al Partito conservatore di David Cameron o al Partito cristiano democratico di Angela Merkel, avevano entrambi posizioni conservatrici, non solo in materia economica, ma anche sui temi socio-culturali. In questi ultimi anni anche questi partiti hanno subìto una trasformazione che li ha portati a essere un po’ più progressisti sui temi culturali e sociali, allargando quel gap di rappresentanza di cui parlavamo.
Anche a sinistra abbiamo assisito ad alcuni esperimenti; penso al partito di Sahra Wagenknecht...
Si tratta di un caso molto interessante. Lei arriva da un partito che è erede del comunismo, quindi di estrema sinistra. Cerca di mettere insieme questo background con una posizione fortemente di destra sui temi dell’immigrazione. Devo dire che ciò che trovo bizzarro di questo partito è che è piuttosto estremo su entrambe le cose. Non è un partito con un profilo socialdemocratico sul piano economico e anche sull’immigrazione non propone un approccio di centro-sinistra vecchio stile, fondato sull’uguaglianza di tutti gli esseri umani, per cui è giusto offrire aiuto a chi ne ha bisogno, ma con un approccio prudente. Quello che il partito di Sahra Wagenknecht propone è una ricetta di estrema destra. Un partito davvero strano. Il suo obiettivo era verosimilmente quello di conquistare gli elettori dell’Afd che cercavano politiche economiche più di sinistra.
Abbiamo parlato dei paesi dell’Europa occidentale, e i paesi dell’Europa centrale e orientale? Vedi emergere dinamiche differenti?
Direi che ci sono delle somiglianze, ma anche delle differenze cruciali. La principale e più ovvia, che impone di fare paragoni con grande cautela, è che alcuni di questi paesi sono il prodotto del crollo dell’Unione Sovietica; hanno ottenuto la loro indipendenza dopo il 1989 e quindi non hanno un background di democrazia liberale.
Ciò in parte spiega come mai, nonostante le grandi aspettative e la fiducia riposte sul loro tragitto, questi paesi abbiano espresso il sostegno a partiti non solo xenofobi, ma talvolta apertamente antidemocratici. Questo può rattristare, ma non deve sorprendere perché si tratta di aree che non vantano una storia e un’esperienza consolidata di liberalismo e democrazia.
Quindi, si possono fare dei confronti, però dovremmo stare attenti a paragonare queste forze esplicitamente antidemocratiche con ciò che accade in Europa occidentale. Anche qui vedo dei partiti che potremmo collocare nella categoria di quelli esplicitamente antidemocratici; penso ad Alba Dorata in Grecia e probabilmente all’Afd in Germania, ma molti partiti anche di destra radicale non sono in realtà antidemocratici; possono essere molto conservatori, con posizioni estreme, ma non rappresentano una minaccia per l’ordine democratico, almeno non nella loro attuale incarnazione. Probabilmente altri scienziati politici mi contesterebbero, ma, ad esempio, non metterei l’attuale versione del Rassemblement National in Francia in quella categoria, né ci metterei il partito di Meloni.
Sono partiti molto conservatori su una serie di questioni, ma non rappresentano un pericolo chiaro e attuale per la democrazia. Altro discorso va fatto per Orban o Diritto e giustizia in Polonia. Anche in questo caso, il contesto dell’Europa centro-orientale è molto diverso da quello dell’Europa occidentale.
Quello che sta succedendo negli Stati Uniti ha a che fare con questi discorsi? Si è detto che il non aver affrontato la questione dell’immigrazione sia una delle ragioni che hanno fatto vincere Trump.
È proprio così. Se si guardano i dati sulle elezioni del 2024, l’immigrazione, insieme all’economia, sono stati i grandi temi che hanno orientato il voto degli americani. La situazione è dunque in qualche modo assimilabile a quanto avvenuto in Europa. Di nuovo, gli elettori erano delusi per l’incapacità, o la riluttanza, della precedente amministrazione democratica ad affrontare la questione. Questo però è ben diverso dal sostenere esplicitamente il genere di cose che Trump sta facendo ora, come far sparire gli stranieri illegali, separare le famiglie...
Dobbiamo stare attenti a non confondere le critiche di questi elettori ai partiti di centro-sinistra con l’appoggio indiscriminato ai partiti populisti di destra. Queste persone pretendono che si faccia qualcosa; la loro è una reazione alla mancanza di iniziative da parte dei partiti tradizionali.
Gli elettori americani da tempo avevano espresso preoccupazione per il tasso di immigrazione illegale. Negli Stati Uniti ci sono letteralmente milioni e milioni di immigrati clandestini.
Forse va bene così. Resta il fatto che molti elettori erano angosciati per la situazione e il Partito democratico si è rifiutato di riconoscere che si trattava di un problema reale. Trump ha avuto così l’opportunità di convogliare su di sé tutta l’insoddisfazione creata da questo vuoto di proposte. Ovviamente, ripeto, questo non significa che non ci siano altri modi per affrontare la questione, ma il fatto che i democratici abbiano negato il problema ha suscitato un diffuso sentimento di rabbia tra i suoi elettori, perfino tra gli immigrati regolari.
Dicevi che l’incapacità, a sinistra, di distinguere tra la frustrazione per i problemi generati dall’immigrazione clandestina e il razzismo vero e proprio, è stato un altro grave errore.
Certamente, primo perché è un’equiparazione empiricamente scorretta e, in secondo luogo, perché così ha rinunciato ad appellarsi a quegli elettori che non sono affatto razzisti e xenofobi. I partiti di centro-sinistra ovviamente non devono rivolgersi a razzisti e xenofobi. Non è quello il nostro “brand”. E però un partito di sinistra deve saper parlare con i lavoratori preoccupati per gli effetti dell’immigrazione clandestina. Se invece li ignoriamo o li confondiamo con i razzisti, li consegniamo su un piatto d’argento a partiti pronti a sfruttare questi sentimenti di paura per scopi molto negativi. È una dinamica da non sottovalutare e il caso americano dovrebbe servirci da lezione.
Abbiamo parlato degli errori commessi dalla sinistra. Vedi in Europa qualche modello da seguire?
I problemi che la sinistra si trova oggi ad affrontare non sono la conseguenza di decisioni politiche sbagliate fatte negli ultimi anni. Torniamo un po’ al discorso iniziale e alla scelta, che risale agli anni Novanta, di abbracciare gran parte dell’agenda neoliberale, contribuendo così a spostare la competizione politica dalle questioni economiche a quelle non economiche. Una dinamica che ha portato gli attuali partiti di centro-sinistra a non rappresentare più la classe operaia, bensì le persone istruite, con un buon reddito e attente ai temi culturali. Questa evidentemente non è una cosa che si può cambiare da un giorno all’altro.
Penso che, se i partiti di sinistra vogliono tornare ad avere, non dico una vocazione maggioritaria, ma almeno un numero di voti sufficienti a contrastare le coalizioni dominanti, devono impegnarsi in una strategia a lungo termine che abbia come obiettivo principale quello di riportare la concorrenza politica sulle questioni economiche. Questo vuol dire anche approntare strategie valide per affrontare le sfide che le società si trovano ad affrontare oggi. Non sto dicendo che sia facile, ma questa è l’unica strada percorribile per il centro-sinistra.
Penso a un partito con un’impostazione, diciamo, tradizionale, con un profilo e delle aspirazioni socialdemocratiche. Per cui se il capitalismo va bene per generare crescita e innovazione, resta il fatto che ci dobbiamo far carico del suo impatto negativo sui soggetti più vulnerabili.
Serve un’agenda in grado di convincere gli elettori a tornare a votare sulla base delle loro preferenze economiche. Se a orientare il voto restano le preferenze sociali e culturali, gli elettori saranno più facilmente spinti verso i partiti di estrema sinistra o, dall’altra parte, verso i partiti populisti.
C’è qualche partito di sinistra, socialdemocratico, che si sta muovendo in questa direzione?
Ce ne sono diversi che ci stanno provando. Il partito danese è quello di cui più si parla. Qualcuno lo accusa di essersi spostato verso il centro o addirittura verso la destra. Personalmente non la vedo così. Anche il partito socialdemocratico svedese sta tentando di compiere un’operazione simile: si è concentrato quasi esclusivamente sulle questioni economiche, cercando di spostare il proprio programma a sinistra.
Alla fine, il modo migliore per affrontare le questioni legate all’immigrazione è quello di assicurarsi che tutti abbiano un lavoro, che nessuno sia costretto a vivere di sussidi, eccetera.
In fondo è quello che noi socialdemocratici sappiamo fare meglio. Se vogliamo, i partiti di centro-destra hanno un problema analogo perché sono quelli che hanno perso più elettori a vantaggio dei partiti di estrema destra. Quindi, in prospettiva, anch’essi hanno interesse a riportare la discussione sulle questioni economiche. In un contesto di questo tipo, i partiti di estrema sinistra e quelli populisti di destra avrebbero senz’altro meno successo.
Sul tema dell’accoglienza, le formule oscillano tra due polarità: accoglierli tutti o creare una fortezza, un muro. Per quanto riguarda la convivenza, in questi anni abbiamo assistito alla crisi sia del modello universalista francese che di quello multiculturale inglese. Quale dovrebbe essere un modello socialdemocratico?
Le questioni sono tante, ma direi che la prima domanda a cui dobbiamo dare risposta è: quante persone possiamo accogliere? La seconda: una volta che sono qui, cosa dobbiamo aspettarci da loro e cosa possiamo pretendere da loro? Come dobbiamo porci con questi nuovi membri della nostra comunità?
Se questi sono i nodi, direi che, sia in Europa occidentale che negli Stati Uniti, è importante valutare l’opportunità di una sorta di rallentamento e di revisione del numero degli accessi.
Per il centro-sinistra, ovviamente, questo non può significare abbandonare le persone in fuga da situazioni difficili. Un partito socialdemocratico si preoccupa dei rifugiati, delle persone che fuggono da guerre e conflitti, o anche da situazioni economiche drammatiche, perché tutto questo rientra nelle sue aspirazioni universaliste.
Tuttavia, un rallentamento è importante, non solo per motivi politici, ma anche perché l’accoglienza dei rifugiati è diversa da quella dei migranti per motivi economici.
Quindi un primo tema è: quante persone possiamo far entrare? E poi c’è l’altra questione: la differenza tra il modello inglese e quello assimilazionista perlopiù associato alla Francia. Il modello britannico si è rivelato problematico per molte ragioni, non ultima il fatto che è molto difficile creare una società coesa se non si incoraggiano le persone ad assimilarsi economicamente, socialmente e culturalmente. Questo non significa necessariamente che tutti debbano vivere esattamente nello stesso modo, o che chi si trasferisce in un altro paese debba abbandonare le proprie tradizioni e la propria storia. Sarebbe un approccio vagamente totalitario.
Detto questo, alcune cose sono considerate doverose: la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole del gioco, l’accettazione delle norme sociali e culturali del paese in cui ci si trova. Mi rendo conto di essere vaga, ma perché è molto difficile stabilire dei confini tra delle aspettative ragionevoli e il tentativo di imporre una monocultura. La sinistra non dovrebbe essere coinvolta in quest’ultimo compito, e tuttavia non può nemmeno approvare contesti in cui si creino delle sorte di società parallele, come abbiamo visto in Gran Bretagna.
I partiti di centro-sinistra in particolare, ma anche i partiti conservatori tradizionali, dovrebbero essere in grado di affrontare tali questioni senza fare concessioni al razzismo o alla xenofobia. Un democratico liberale non può ammettere che le persone siano giudicate sulla base di qualcosa di diverso dalle loro qualità individuali. Non possono esserci cittadini di seconda classe in base alle appartenenze etniche o religiose. D’altro canto, dal punto di vista della collettività, trovo perfettamente legittimo che i partiti di centro-sinistra si impegnino per creare e mantenere una qualche forma di cultura comunitaria coesa, con regole del gioco condivise. Ovviamente tutto questo non è affatto facile e si tratta di processi graduali.
C’è un dibattito interno tra i democratici su questi temi?
I dibattiti sull’immigrazione sono incentrati sui numeri molto più che sui temi dell’assimilazione. Questa diversità ha a che fare con la storia degli Stati Uniti, che è diversa da quella dell’Europa, così come sono diversi gli immigrati che arrivano. Ma qui il vero problema sono i numeri. Tant’è che molti nuovi immigrati hanno appoggiato, o perlomeno tollerato, molta della retorica di Trump che in effetti aveva come bersaglio gli immigrati clandestini, non le persone come loro, che hanno un lavoro, sono in regola, ecc.
Il dibattito poi si estende a quale strategia adottare con Trump. Alcuni dicono: “Guardate che alla fine farà un tale casino che si danneggerà da solo, per cui noi ci limiteremo a raccogliere i pezzi e ricominciare…”. Altri auspicano una strategia più offensiva. Su questo c’è un’ampia discussione in corso all’interno del Partito democratico e in generale tra i progressisti, i gruppi della società civile, gli accademici, gli attivisti. Sono tutte questioni molto sentite oggi.
Non abbiamo parlato dell’antiamericanismo che caratterizza tanti partiti di sinistra in Europa…
È una questione che ha un aspetto anche divertente, se vogliamo, perché una delle peculiarità della politica europea è che l’antiamericanismo è un tratto comune sia all’estrema destra che all’estrema sinistra. In questi ultimi anni poi le cose sono peggiorate, per una serie di motivi, non ultimo il fatto che Trump ha messo in crisi i posizionamenti tradizionali. Penso alle esternazioni sull’Afd in Germania o alle dichiarazioni di J. D. Vance quando si è recato a Monaco o ai commenti di Marco Rubio contro la sentenza della corte Costituzionale tedesca che ha dichiarato l’Afd un partito estremista. L’estrema destra tedesca è tradizionalmente molto antiamericana, ma questo inedito sostegno sta rimescolando le carte. Non dobbiamo poi dimenticare che i trumpiani sono molto diversi dal Partito repubblicano tradizionale...
Insomma, è evidente che l’antiamericanismo non ha più molto senso, né dal punto di vista pratico, né dal punto di vista intellettuale. Stanno succedendo cose molto strane nelle relazioni transatlantiche.
Comunque, se nell’estrema destra le cose sono un po’ cambiate, nell’estrema sinistra l’antiamericanismo resiste, anche se in modo stratificato: all’aspetto anti-Trump si sovrappone ora il sentimento anti-israeliano. Anche qui è curioso come invece nell’estrema destra si stia consolidando un atteggiamento perlomeno di tolleranza verso Israele; un fenomeno insolito dal punto di vista storico.
E poi c’è la guerra: sia quella in Ucraina che quella a Gaza hanno creato alleanze nuove e talvolta inattese. Anche qui è curioso come l’estrema sinistra e l’estrema destra si trovino entrambe a simpatizzare per la Russia. In fondo, questo non è così anomalo per l’estrema sinistra; è decisamente più strano per l’estrema destra. Di queste dinamiche arrivano gli echi anche negli Stati Uniti, dove i trumpisti sono, se non filo-russi, certamente simpatizzanti di Putin. Per quanto riguarda la sinistra, in questo momento Israele è diventato un problema più grosso di quello costituito dall’Ucraina. Al contrario, l’estrema destra si trova improvvisamente ad abbracciare, non solo la causa israeliana, ma proprio Netanyahu, che è in fondo lui stesso un uomo di estrema destra. Siamo davanti a un vero sconvolgimento, a un totale rimescolamento dello spettro politico che conoscevamo.
Per concludere? In fondo lo stato di salute della sinistra è legato allo stato di salute della democrazia...
Vorrei essere più fiduciosa. Parte del problema è che in questo momento sono seduta qui negli Stati Uniti dove, onestamente, la situazione appare parecchio peggiore di quella dell’Europa occidentale. Non solo perché abbiamo quest’amministrazione di estrema destra, ma anche perché la sinistra è divisa e incapace di adottare strategie per rafforzare l’unità interna.
Non sono particolarmente ottimista sugli Stati Uniti, anche se penso che Trump, i trumpiani, dovranno presto fare i conti con le conseguenze delle cose che hanno fatto. E tuttavia, se il Partito democratico dovesse vincere le elezioni di midterm più sulla base dei fallimenti dei trumpiani piuttosto che per proprio merito, beh, non sarebbe una cosa positiva nel lungo termine. Ovviamente sarebbe meglio che il Partito democratico riconquistasse del potere perché vorrebbe dire che l’ha sottratto ai repubblicani, però nel lungo periodo, se non hai qualcosa da offrire, ma ti limiti ad approfittare dell’insoddisfazione degli elettori nei confronti della destra, i problemi di fondo rimarranno irrisolti.
Per rispondere alla tua domanda, credo che la democrazia, per funzionare bene, abbia assolutamente bisogno di un forte centro-sinistra... e anche di un forte centro-destra. La stabilità relativa che abbiamo conosciuto in Europa occidentale nel Dopoguerra era anche dovuta al fatto che il sistema era dominato da partiti di centro-sinistra e di centro-destra che accettavano le regole del gioco democratico; insomma, pur avendo programmi diversi, agivano all’interno di un quadro condiviso, accettato. La crisi di entrambi i soggetti ha contribuito a far emergere le dinamiche molto preoccupanti a cui stiamo assistendo.
Anche per questo è importante osservare se e come questi due partiti mainstream (quelli che qualcuno oggi definisce anche establishment) riusciranno a riconquistare i loro elettori. Diversamente ci aspetta un lungo periodo di instabilità.
(a cura di Barbara Bertoncin)
Archivio
AVETE GIA' PRONTO IL VOSTRO RIGHELLO?
Una Città n° 282 / 2022 marzo
Realizzata da Stefano Ignone
Realizzata da Stefano Ignone
L’invasione russa dell’Ucraina rappresenta la più grande minaccia alla pace in Europa sin dalla fine della Guerra fredda e dalle guerre nella ex-Yugoslavia. Mantenere la pace in tutto il mondo è uno dei compiti primari della sini...
Leggi di più
CRISI, DEMOCRAZIA, AUTORITARISMO
Una Città n° 265 / 2020 aprile
Realizzata da Stefano Ignone
Realizzata da Stefano Ignone
Secondo un vecchio adagio, le crisi non trasformano le persone, ma rivelano di che pasta siano fatte. Lo stesso adagio si può applicare ai sistemi politici: in tempo di crisi, emergono le loro forze e debolezze. Quando è cominciata la crisi ...
Leggi di più
L'ORGOGLIO E LA VERGOGNA
Una Città n° 309 / 2025 aprile
Realizzata da Barbara Bertoncin
Realizzata da Barbara Bertoncin
Arlie Russell Hochschild, sociologa statunitense e professoressa emerita all’Università della California, Berkeley, è celebre per i suoi studi sulle emozioni nella vita sociale e politica. Tra le sue opere più recenti: Strangers...
Leggi di più
Il viaggio dei 110 e l’elefante nella stanza ucraino
Si è parlato spesso in relazione alla Global Sumud Flottilla di "elefante nella stanza", per sottolineare che i governi e una parte della discussione pubblica discuteva sulle decisioni e comportamenti della Flotilla come se a essere illeg...
Leggi di più
Uno sguardo al Vietnam di oggi
Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto
Può un viaggio turistico di gruppo permettere di fare osservazioni sociali, politiche ed economiche su un paese esotico come il Vietnam, tanto lontano dalla realtà quotidiana in cui viviamo? Probabilmente quanto scrivo potrà essere co...
Leggi di più