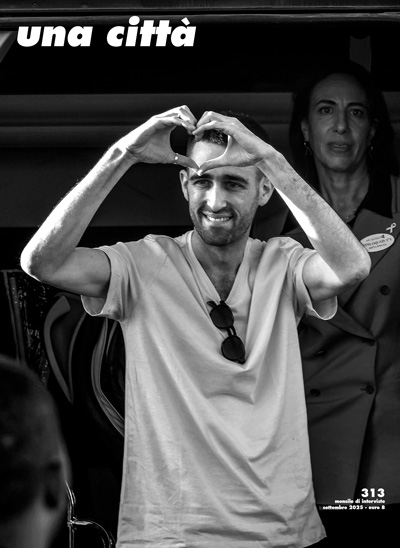La realtà, per quel che ne può capire un lettore di libri e giornali, è forse orribile davvero, ma molto più complicata. Soprattutto all’origine di molto orrore, senza risalire alla Guerra d’Etiopia, ci sono proprio le grandi potenze e, in particolare, in Somalia, per ovvi motivi, l’Italia.
Tra due rive
A Torino, chi lavora con gli immigrati, ha incontrato i somali (in effetti soprattutto le somale) una trentina di anni fa, nelle associazioni universalistiche e nei gruppi di ricerca. In un ambiente di immigrati molto connotati politicamente, con storie di resistenza o di espulsione alle spalle, esiliati politici in sostanza, le somale, malgrado, alla fine degli anni Ottanta, si fosse alla vigilia della caduta del Governo di Siad Barre, facevano eccezione, non sembravano avere una posizione politica in senso proprio. Questo rendeva un po’ reticente il loro rapporto con eritrei, ruandesi, maghrebini, ma certo non le metteva in difficoltà con i -pochi- ricercatori italiani del gruppo, che cercavano di mettere in luce la realtà sociale e culturale, i rapporti di lavoro, dei migranti, non le loro opinioni politiche, anche se le ascoltavano volentieri.
La vera sorpresa fu il livello di istruzione delle somale, alto, forse più alto di quello degli altri migranti, malgrado il 94% di analfabetismo femminile delle statistiche correnti. Avevamo cercato delle interpreti, pensando che poche parlassero italiano, che lì non si insegnava più nelle scuole, salvo all’Università nazionale somala. Non ce ne fu bisogno. In sostanza, le somale di Torino, anche quelle che facevano le serve, venivano dal vertice sociale del paese; forse dall’un per mille più alto della società somala.
Il nostro tramite, forse bisognerebbe dire la nostra garante, con il mondo dei somali, fu Starlin Harush, amica di Maria Viarengo/Abebù Alberto (a seconda che la si chiami all’uso italiano o a quello oromò; una, forse la più importante, delle anime del gruppo di ricerca) e di molte somale, eritree, etiopi, di molte donne del Corno d’Africa, della ex-Africa Orientale Italiana. Starlin fu una dei più di venti firmatari della ricerca; ma dire che fu una ricercatrice è insieme troppo e troppo poco. Starlin non fece interviste e non fu intervistata. Permise, promosse, le interviste; e fu una fonte straordinaria, una vera commentatrice in continua, del mondo politico e culturale somalo, degli eventi drammatici che si susseguirono in quegli anni, dei clan e delle loro rivalità, delle necessità di superarle. Lei, come dice il nome, era figlia di Harush, veterinario, referente di una confraternita sufi, esponente importante degli Habr Ghedir, del ceppo Hawiye. Sua sorella Halima era il vero capo della famiglia (oltre che autrice di articoli sull’Unità). Starlin ne era l’Ambasciatore, il Ministro degli esteri, in Italia e in Europa. Da lei abbiamo sentito i resoconti della battaglia di Mogadiscio, durante l’intervento americano e italiano "Restore Hope”, degli scontri a Checkpoint Pasta, della sempre fallita caccia a Mohammed Farah Aidid, un importante signore della guerra degli Habr Ghedir. La spiegazione del fallimento era la stessa che ha dato Evans-Pritchard della impossibilità degli italiani di sottomettere i Senussi d ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!