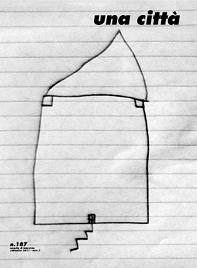Più di trent’anni fa hai deciso di trasferirti nella periferia sud est
di Madrid, nel quartiere della Celsa, che adesso non esiste più. Puoi
raccontare?
Più di trent’anni fa hai deciso di trasferirti nella periferia sud est
di Madrid, nel quartiere della Celsa, che adesso non esiste più. Puoi
raccontare?Alla Celsa l’80% della popolazione era gitana. Gli altri formavano un assortimento di diversi tipi marginali. Nel quartiere c’era una scuola pubblica, una piccola parrocchia e un asilo. Offrii la mia collaborazione alla scuola. All’epoca lavoravo per l’Università. Proposi un’attività ricreativa con i bambini e una consulenza come psicologo.
Poco dopo lasciai l’Università: quel lavoro non mi interessava più, mi interessavano i bambini emarginati. Pensavo che la cosa più importante fosse conoscere direttamente la loro vita.I problemi di questa prima fase, che durò più o meno dieci anni, sono legati esclusivamente alla miseria: i bambini non avevano casa, vestiti, né alimentazione adeguata. Bisognava entrare in contatto con le famiglie e portare innanzitutto un aiuto materiale. Più tardi avrebbero cominciato loro stessi a chiedere una mano. In questo modo entrai lentamente nella vita delle famiglie. All’inizio ero uno che passava di là, uno sconosciuto. I primi tempi nessuno si fidava di me.
Quando videro che ero inoffensivo per i loro bambini mi invitarono a casa a prendere il caffè. Entrai in confidenza con molti gitani, mi invitavano ai matrimoni, ai battesimi, alle feste…Molti bambini si dedicavano a cercare immondizia nella discarica vicino al quartiere. Alcuni raccoglievano metallo, altri residui organici per alimentare i maiali e poi andavano a venderli. Nel quartiere c’erano condizioni di vita molto dure, però anche diversi mezzi di sostentamento. Si faceva vendita ambulante.
A volte si usciva con una carretta e si raccoglievano mobili vecchi, lavatrici e televisioni per venderle fuori dal quartiere. Alcuni fabbricavano ceste o esercitavano altre attività tipiche dei gitani. Nessuno consumava droga. Negli anni Settanta, come dicevo, l’unico problema era la miseria. Mancavano molte cose, però tutti i bambini avevano una famiglia, molto ampia, quasi una tribù.
E non era solo la famiglia a proteggerli. Se interveniva la polizia, tutti i vicini difendevano i bambini, anche se non erano i loro. C’era un’usanza ancestrale per cui i genitori e i nonni inculcavano ai più piccoli le loro credenze e i loro costumi. Vivevano però isolati dal resto della popolazione. Tutto il quartiere metteva in guardia i bambini, che facessero molta attenzione ai payos, i non gitani…
A un certo punto hai preso in affitto un appartamento per dare a questi ragazzi la chance di integrarsi nelle scuole cittadine.
Nonostante la maggior parte dei gitani diffidasse del mio ambiente payo, alcune famiglie accettarono di lasciar andare i propri figli.
In questa casa eravamo sempre in tre. Una mia amica faceva da madre e un paio di persone ci davano una mano. Se i bambini avevano famiglia preferivamo che dormissero a casa loro. Facevamo in modo che non perdessero le radici e i legami con il proprio ambiente. Venivano in questa casa per studiare, o prima di andare al lavoro. Ottenemmo qualche sovvenzione e, sull’esempio della prima, aprimmo altre case. Capimmo che era un servizio necessario anche altrove. Creammo dei posti che chiamammo centri di appoggio, in cui si cercava di individuare i problemi dei giovani del quartiere e di risolverli insieme a loro. I centri si specializzarono nell’aiuto in tribunale. Alcuni avvocati a inizio carriera ci affiancarono nell’impresa.
Cercavamo di avere sempre tre fonti di finanziamento. Noi non vivevamo di questo. Avevamo i nostri lavori e se ci avanzava denaro lo investivamo. Ci interessava molto che i bambini vedessero che non vi ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!