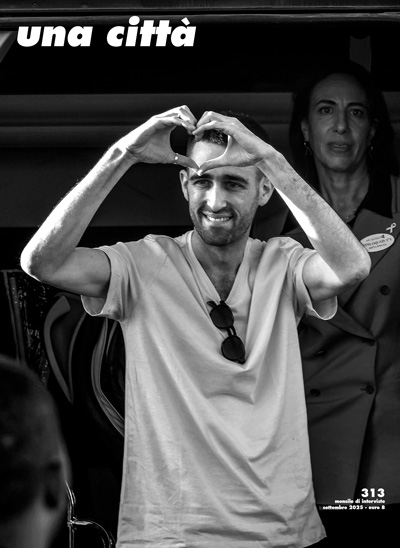"Ucraina è Ucraina!"
cosa sta succedendo

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto
Intervista a Anna Zafesova
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
"Ucraina è ucraina!"
Da un lato un paese, la Russia, che negli ultimi due decenni è stato travolto da un autentico shock socio-culturale, oltre che politico, e che ha spinto tanti a rimpiangere un passato grigio ma rassicurante; di qui il successo della ricetta di Putin: stabilità in cambio della libertà. Dall’altro, l’Ucraina, che, anche grazie a una diffusa emigrazione, soprattutto delle donne, ha familiarizzato con l’Europa e ha scelto di guardare avanti. Intervista a Anna Zafesova.
Anna Zafesova, giornalista, sovietologa, traduttrice e scrittrice, è stata corrispondente da Mosca per il quotidiano “La Stampa”, di cui è tuttora editorialista. Il libro di cui si parla nell’intervista è Russia, l’impero che non sa morire (Rizzoli 2025).
Nel libro parli, per la Russia, di “shock del futuro”, e fai capire come nessuno avesse ben compreso la portata delle trasformazioni avvenute negli ultimi due decenni.
Credo che in effetti non l’avesse capito nessuno, oltretutto è qualcosa che stiamo vivendo anche nelle società occidentali. Penso alla polarizzazione, al sovranismo, tutti fenomeni senz’altro legati anche a cambiamenti estremamente rapidi, probabilmente i più rapidi che ci siano stati mai nella storia dell’umanità, stravolgimenti che si stanno verificando nell’arco di una vita, se non di mezza vita umana.
Nel caso della Russia parliamo di cambiamenti estremamente rapidi e potenti: questo paese si è trovato non solo a dover recuperare un ritardo preesistente rispetto all’Europa, ma a farlo in un momento in cui tutto il mondo subiva a sua volta un’accelerazione incredibile, di tecnologia, di globalizzazione, di cambiamento di rapporti, gerarchie sociali, geografiche, politiche, ecc.
Per l’ex Unione Sovietica l’impatto di questo cambiamento è stato infinitamente più brutale. Sicuramente in Occidente abbiamo sottovalutato questo fenomeno, così come l’hanno sottovalutato anche i diretti interessati, perché c’era l’idea che un miglioramento non potesse che essere positivo. Certo, diventare più liberi, poter più facilmente accedere al mondo, alla cultura, alla ricchezza e alla possibilità di realizzare le proprie idee, non può che essere un bene; il problema è che molti ex sovietici non erano attrezzati per fruirne senza attraversare uno shock che li ha profondamente segnati.
Non a caso, Vladimir Putin, per un quarto di secolo, ha proposto ai russi la “stabilità”. Era quella la sua ricetta. Di solito, in politica la stabilità viene apprezzata quando si sta bene, in momenti di relativo benessere, quando nessuno vuole cambiare. Nel caso della Russia, invece, la stabilità era apprezzata nonostante non si stesse proprio benissimo. Pur di non avere altri cambiamenti, altri shock, si preferiva conservare quel poco che si aveva senza rischiare più. Perfino tra gli intellettuali russi di stampo diciamo “liberale”, la parola “rivoluzione”, anche quella d’Ottobre, aveva assunto una connotazione negativa.
D’altra parte, il paese che oggi noi chiamiamo Federazione russa, e che è stato per più di settant’anni Unione sovietica, è nato da uno shock, appunto la Rivoluzione d’Ottobre, e poi è collassato in un altro shock, la Perestrojka di Michael Gorbachev, processo che si è concluso con la deflagrazione dell’Unione. Si è trattato di una rivoluzione, non soltanto politica o economica, che ha impattato anche sulle famiglie, sulle relazioni tra genitori e figli, tra dipendenti e datori di lavoro, sul rapporto con il denaro -nell’Urss il denaro non era rilevante, era molto più importante l’accesso a beni che scarseggiavano, che non era garantito dal possesso di contante.
Con la Perestrojka è cambiato veramente tutto: il modo di sposarsi, di fare figli, di cercare lavoro, di progettare la propria vita, e questo ha avuto un impatto su milioni e milioni di famiglie, anche su chi fieramente proclamava di non interessarsi alla politica e di considerarla una cosa noiosa, sporca. Nessuno, in un paese che all’epoca contava circa trecento milioni di abitanti, ne è uscito indenne, cioè senza sconvolgimenti, casomai anche positivi, ma comunque enormi.
Ecco, in Occidente abbiamo sottovalutato tutto ciò, non abbiamo capito niente, fino a che non è apparso Putin e ha cominciato a raccontare ai russi e a se stesso la favola di un passato al quale la Russia doveva tornare perché il presente non era positivo.
Mi hanno colpito molto i racconti di vita quotidiana sotto il comunismo, anche il semplice fare la spesa era qualcosa di molto lontano dalla nostra esperienza...
Ho fatto di recente una conferenza in un liceo a Biella e ho percepito la difficoltà degli studenti a comprendere il mio racconto. Figuriamoci, ci sono cose che anche chi studiava la Russia non riusciva a capire, pensa i quindicenni di oggi… Ho provato a far immaginare loro come potesse essere frequentare una scuola sovietica del 1983, tutti in uniforme, i capelli della stessa lunghezza, le ragazze che non possono truccarsi, il non poter fumare, non conoscere il significato della parola “sesso”, guardare, ascoltare e leggere tutti le stesse cose, e poi avere davanti a sé una vita estremamente regolamentata: dopo la scuola il militare, poi alcuni l’università, altri un istituto tecnico… Non credo di esserci riuscita, tanto più che i ragazzi davanti a me, anche visivamente, erano tutti diversissimi, quelli con i capelli lunghi, quelli rapati, quelle con il velo… Poi ho detto loro: “Immaginate di entrate in un negozio perché volete comprare il formaggio e di non trovarlo”.
Secondo me non riesci neanche a spiegarglielo. “Cosa vuol dire non c’è il formaggio? Vai in un altro negozio!”. Non solo, entravi in un emporio, e invece di sentire i profumi di cibo buono ti veniva quasi un conato di vomito, perché le patate erano sporche, piene di terra... ma poi c’era questo odore di marcio, di terra, di umido. (Tutti questi orrori poi venivano trasformati in piaceri della vita attraverso la cucina delle nonne). Nel paese che aveva lanciato il primo uomo nello spazio non si riusciva a trovare il latte a lunga conservazione; nei negozi c’era sempre questo odore di rancido, perché non essendoci alcuna refrigerazione ed essendo le confezioni bucate, il latte andava a male e c’era sempre quel rivolo… quindi dovevi sempre controllare la data di produzione: se era del giorno prima o del giorno stesso aveva comunque poca vita. Infatti nei negozi si aspettava il “latte di domani”, quello che superava la quota del piano giornaliero e che di solito arrivava solo nel pomeriggio.
Ecco, questa cosa devi averla annusata, per capirla.
Nel ripercorrere le radici del risentimento russo verso l’Ucraina, denunci anche la nostra cecità...
Mi è capitato di rileggere un’intervista fatta nel giugno 2015 da Luciano Fontana e Paolo Valentino a Putin per il “Corriere della Sera”. Un’intervista che aveva fatto discutere, perché la Crimea era già stata annessa e ci si chiedeva quanto fosse corretto intervistare Putin senza contraddittorio.
L’intervista era sicuramente noiosa: Putin alla fine ripeteva sempre le stesse cose: “È colpa dell’Occidente”, “In Ucraina c’è stato il golpe nazista”... Senza voler per forza risalire al Settecento, è incredibile come, in realtà, anche il recente allontanamento della Russia dall’Europa sia avvenuto sotto i nostri occhi, mentre noi mandavamo i nostri migliori giornalisti a domandare a Putin “Perché?”, a parlargli di cooperazione... Cioè, abbiamo continuato a rivolgerci a lui come se fosse europeo, come se fosse uno con cui abbiamo avuto qualche diverbio… Ma parliamo di uno che per la prima volta dopo il ’45 si è annesso un territorio in Europa! Non è come noi! Già due anni prima nel suo discorso alle camere riunite aveva detto che “la Russia non è Europa” e che la Russia non doveva condividere i valori europei... Insomma, è avvenuto tutto sotto i nostri occhi.
Che dire? Un po’ non volevamo crederci, un po’ avevamo i nostri problemi con Al-Qaeda e l’Isis. Anzi, proprio per la minaccia del terrorismo, la Casa Bianca aveva rivalutato l’alleanza con Putin, che comunque era bianco e cristiano, quindi in quest’idea di scontro di civiltà Putin doveva stare con noi. Idea, per fortuna, poi completamente dimenticata, ma ricordiamoci che c’è stato un tempo in cui persone anche molto illuminate, gli stessi che oggi chiedono che Putin sia processato all’Aja per crimini contro l’umanità, pensavano che fosse un alleato prezioso.
Perché Putin ha voluto prendersi la Crimea e ora l’Ucraina? Da dove nasceva questa “necessità”?
Non era “necessario” per nessuno, tant’è vero che gli stessi russi non si aspettavano neppure l’annessione della Crimea. Sicuramente c’era molta nostalgia per l’Urss, un sentimento presente anche in altri paesi. Ma, attenzione, lo abbiamo visto anche alle recenti elezioni in Moldova e Romania: c’è una parte della popolazione, soprattutto quella più anziana, vittima di questo “future shock”, che è nostalgica e molto sensibile ai richiami alla stabilità, al passato, anche al socialismo, a una povertà con però delle garanzie.
È un discorso che esisteva anche in Ucraina: tuttora lì ti diranno che tutto sommato con l’Unione sovietica si stava bene, avevi la macchina -poi non è vero, l’avevano in pochissimi-, e prima o poi ti veniva assegnato un piccolo appartamento, nessuno era ricco ma nessuno era nemmeno poverissimo, la gente andava a scuola e all’ospedale… A dirti queste cose sono ucraini che non vogliono l’invasione russa!
Questo per dire che tale nostalgia era abbastanza assestata, non rappresentava un problema, e i russi già prima potevano andare a fare le vacanze in Crimea senza bisogno di visto.
La verità è che non ci andavano più, perché il livello dei servizi offerti, a parità di prezzo, era di molto inferiore a quelli della costa spagnola o turca; infatti, il turismo in Crimea era praticamente morto. Motivo per cui la Crimea stessa era nostalgica dell’Unione sovietica; molti crimeani pensavano che tornare alla Russia equivalesse a un rifiorire, a diventare una Rimini pansovietica.
Quando poi Putin ha annesso la Crimea, gli stessi russi sono rimasti sorpresi: “Ma come? Si poteva fare?”. Dalla sorpresa è scaturito poi un orgoglio nazionalista, che ha contagiato anche molti liberali anti-putiniani, perché comunque resiste l’idea per cui “più territorio si ha più si è grandi”. Sicuramente, in questo senso, l’indipendenza dell’Ucraina era stata percepita da tanti russi come un errore, perché mentre gli uzbeki, i georgiani o gli abitanti dei paesi baltici erano percepiti come diversi -per lingua, religione, storia, tratti somatici- gli ucraini erano da sempre i loro “cugini di campagna”. Ma anche questa percezione si andava appianando.
Se la Russia avesse continuato a evolversi, diventando più ricca, più promettente, con più università, case editrici, eccetera, sarebbe tornata naturalmente a essere un polo d’attrazione per quasi tutto lo spazio ex sovietico. Prendiamo, ad esempio, l’immigrato clandestino tagiko che andava a lavorare nei cantieri moscoviti per mantenere la famiglia in patria; ebbene, il Tagikistan soprattutto, ma anche in parte l’Uzbekistan, vive delle rimesse degli immigrati in Russia. Oppure, uno dei maggiori oligarchi russi, Michail Friedman, è nato a Leopoli, però se ne è andato a Mosca perché lì a suo dire pativa meno l’antisemitismo. O il direttore del maggiore festival cinematografico russo, l’ucraino Alexander Rodniansky, anche lui era andato a vivere in Russia -poi, con la guerra, si è schierato con l’Ucraina e vive da esule in Italia.
Ripeto, la Russia sarebbe diventata naturalmente un polo di attrazione dell’ex spazio postsovietico. Ovviamente, più Mosca mostrava il volto di un centro imperiale che pretendeva fedeltà dagli altri paesi, più questi si allontanavano cercando di entrare nell’orbita dell’Ue e degli Stati Uniti.
Quindi, tornando alla domanda, no, non c’era alcun bisogno di annessioni. O meglio, il bisogno stava tutto nella sopravvivenza del regime di Putin, che riteneva di dover reggere il suo comando in buona parte su questo sogno di grandezza, sulla militarizzazione, e per dirottare l’attenzione dai problemi economici interni, dalla corruzione e dalla totale assenza di alternanza del potere.
Dopodiché, nella visione di Putin, a rendere “imperiale” la Russia, è l’Ucraina. Basta guardare la cartina geografica: la Russia diventa un impero europeo solo se ha l’Ucraina e la Bielorussa. Senza, rimane un grande paese essenzialmente asiatico.
Putin interpreta questa voglia di tornare alla grandeur e contemporaneamente il bisogno di quel grigiore che aveva anche degli aspetti rassicuranti…
È così. Il grigiore era rassicurante perché si sapeva cosa ti avrebbe riservato il domani.
Un’altra componente psicologica che non si era minimamente compresa in Occidente è che gli ex sovietici avevano scelte molto ridotte a qualunque livello: cosa indossare, quale profumo mettersi, che spettacolo teatrale scegliere, perché era tutto scarso. La Tv mostrava sempre gli stessi film o cartoni animati… Per esempio, c’era una serie popolarissima, l’equivalente di Tom e Jerry, dove c’era un lupo che inseguiva un leprotto. Molto carina, disegnata bene, però ne sono uscite credo venti puntate in vent’anni! È curioso notare come ancora oggi generazioni molto diverse di ex sovietici si raccolgano intorno a un film, a un cibo, a una canzone, a un libro, ma perché erano sempre gli stessi per decenni. Era un mondo molto poco variabile. I russi, è vero, volevano l’abbondanza occidentale, però non erano assolutamente pronti a entrare in un supermercato per scegliere tra trenta tipi di formaggio.
Vivevano in un mondo dove erano abituati a poter essere fregati dallo stato, e per questo, infatti, nutrivano una grande diffidenza; però, allo stesso tempo, sapevano che il formaggio era formaggio, il latte era latte... l’idea che un prodotto occidentale potesse essere una truffa, un falso o una schifezza non c’era. Nei primi anni post-comunisti l’area sovietica venne invasa da porcate di ogni genere, dalla vodka polacca farlocca, alle finte magliette Chanel dalla Turchia…
Non erano preparati neppure alla pubblicità, o alle catene di sant’Antonio, alle truffe bancarie. Nei primi anni milioni di persone hanno perso dei soldi perché non c’era nessun tipo di anticorpo: la pubblicità veniva considerata un’informazione, non una cosa da prendere con le pinze. Se qualcuno ti prometteva il 300% in un mese, gli credevi e gli portavi i soldi. Allo stesso modo, se qualcuno ti diceva che un detersivo lavava “bianco che più bianco non si può” ci credevi.
Allo stesso modo erano impreparati a una politica aperta, pubblica, competitiva, dove si litiga, dove si fanno promesse che poi non si realizzano. C’era un rapporto gerarchico codificato: le autorità ti dicevano cosa dovevi fare, la televisione pure, e non poteva essere diversamente.
Ricordo persone anche non troppo anziane che erano sconvolte dalla velocità dei telegiornali moderni, perché erano abituati a un tg con due conduttori, un lui e una lei, impettiti, perfetti, che con voci metalliche, a turno -rigorosamente leggendo- dicevano cose del tipo: “Oggi il segretario generale del comitato centrale del Partito comunista ha incontrato gli esponenti del settore agro industriale della Siberia…”. Era un rito quasi religioso.
Poi è arrivato il telegiornale che dava le notizie vere. Gli aerei cadevano... ma quando mai erano caduti aerei in Unione sovietica? Non si poteva dire, perché i tg dovevano dare l’impressione di un paese senza droga, prostituzione o povertà, dove tutto andava bene. Era l’Occidente, casomai, a essere il luogo della tossicodipendenza, del vizio, della criminalità. L’Urss veniva raccontata come un mondo dove una ragazza poteva passeggiare alle due di notte in minigonna senza temere per la sua virtù. E invece no, aveva assolutamente da temere!
C’è un passaggio in cui dici che i russi hanno quasi volontariamente rinunciato alla propria libertà.
Senza dubbio i russi non sapevano che farsene della libertà, anche perché nessuno gli aveva mai detto cosa fosse. Per come la vedevano, con la libertà in Russia era arrivato il caos economico, la disoccupazione, la confusione. Persone che fino al giorno prima avevano un lavoro d’ufficio e un qualche tipo di prestigio sociale, a un certo punto passavano a commerciare, che so, vodka, diventando magari anche più benestanti, però decadendo socialmente. Sicuramente la monotonia del passato veniva idealizzata come il bel mondo dove tutto era rassicurante, come una sorta di infanzia mitizzata. Pensa ai bambini che vogliono mangiare sempre le stesse cose, guardare sempre lo stesso cartone, farsi leggere sempre la stessa fiaba e spaventarsi sempre nello stesso momento.
Non mi ricordo chi è stato a dire che “la libertà arriva nuda”. Ecco, in Russia la libertà è arrivata abbastanza svestita e malconcia: con essa sono arrivate la corruzione, le ruberie, l’inganno, gli oligarchi, la criminalità, l’assenza di regole… Pensate cosa poteva significare un licenziamento su due piedi in un paese dove prima tutti dovevano avere un lavoro, anche con uno stipendio ridicolo, e si veniva assunti a vita anche per non fare niente, perché non poteva esserci disoccupazione. All’improvviso ci si è trovati a dover lottare per la sopravvivenza!
A questa situazione si erano aggiunti i conflitti interetnici, la guerra in Cecenia, il terrorismo…
Così, all’inizio degli anni Duemila, quando è arrivato Putin con lo slogan “meno libertà e più sicurezza” i russi lo hanno votato. Per questo dico che i russi hanno restituito volontariamente la libertà.
Io credo che chi ha votato Putin sapesse benissimo che avrebbe imposto il pugno di ferro. Quanto sarebbe stato duro quel pugno sarebbe stato difficile immaginarlo anche per i politologi, figuriamoci per l’elettore comune. Comunque, avevano perfettamente intuito che con Putin ci sarebbe stata meno libertà, e gli andava bene. Si chiamava “ordine”, un altro classico del discorso russo: l’ordine è quando il criminale va in galera, le donne sono donne e gli uomini sono uomini. Insomma, credo che per la maggior parte delle persone che l’hanno votato la scelta fosse ovvia: meno libertà, soprattutto politica e più protezione, sia militare-poliziesca, ma anche sociale ed economica.
Putin questa cosa fino a un certo punto l’ha assicurata. Dopo venticinque anni, però, ha tolto all’improvviso tutte le sicurezze. Oggi i russi hanno scoperto che i loro figli possono essere mandati in guerra, o che si possono perdere i risparmi o le pensioni perché c’è bisogno di carri armati, e che all’improvviso si può viaggiare solo in Cina e in Turchia. Ma questo è successo quando ormai non potevano più esprimersi.
Venendo all’Ucraina, da tempo ragioni sulla biforcazione, sulle diverse strade che hanno preso i due paesi, uno che guarda ai giovani, al futuro, e l’altro rivolto al passato...
Credo che la cosa più importante che ho fatto a partire dal 2019 sia stata andare in Ucraina e studiare il fenomeno Zelensky, in un momento in cui il resto del mondo, non solo in Italia, lo inquadrava come il “comico diventato presidente”. Zelensky in realtà è stato il compimento di un processo che era in corso da tre decenni, quello appunto della costruzione di una nazione, che ovviamente era stato un lavoro corale. La verità è che gli europei, nella loro ignoranza, nemmeno sapevano dove fosse l’Ucraina, e certo non sapevano che stava nascendo un paese vero, che aveva lavorato sulla riappropriazione della propria storia, della lingua, della cultura (anche in maniera discutibile, certe volte), con il risultato di far crescere una generazione di persone che si sentivano ucraine e non più post-sovietiche.
Prima di allora, l’ultima volta che ero stata in Ucraina era nel 2010, per la campagna presidenziale Yanukovych-Timoshenko. Mi ero presentata con la classica logica binaria che si utilizza ancora, “filorussi-antirussi”. Loro mi guardavano sconvolti... non era quello il punto. Ovviamente c’erano quelli che spingevano per un’integrazione europea e chi diceva che bisognava continuare a commerciare con la Russia. All’epoca c’era anche uno spazio culturale molto più condiviso, gli artisti ucraini andavano a esibirsi al Cremlino e viceversa. Non c’era ancora questa contrapposizione ideologica. Insomma, nel 2010 ho capito molto in fretta che in Occidente stavamo applicando logiche completamente sbagliate.
Da qualche tempo, con degli amici e colleghi ucraini, a Milano facciamo un festival che si chiama “Ucraina è Ucraina”. Abbiamo preso spunto dal famoso spot del “Corriere della Sera” per la sua “Enciclopedia degli anni Novanta”, in cui si vede un cosmonauta che atterra con la sua capsula in un campo e dice “madre Russia”, a quel punto gli si avvicina una contadina e gli dice: “Ma no, questa è Ucraina”. E lui: “Ma la Russia non è Ucraina?”, al che la contadina risponde “Ucraina è Ucraina!” (https://www.youtube.com/watch?v=7XtqfyJi7uE).
Ecco, il punto è che l’Ucraina è Ucraina, non è una Russia o un’ex Russia.
La Russia non ha minimamente percepito il fatto che era nato un paese che aveva recuperato parte delle sue identità (non solo russe o sovietiche), che si sentiva ed era molto più in Europa e che aveva compiuto quel passaggio generazionale che la Russia non ha mai voluto fare. Oggi è lampante: basta guardare un telegiornale per confrontare la classe dirigente di Zelensky con Putin e quelli che lo circondano: ci sono quarant’anni di differenza!
L’Ucraina è un paese che non si è immerso nella nostalgia. D’altra parte, di cosa doveva avere nostalgia? Dell’impero russo? Piuttosto, per l’Ucraina è l’Europa ad aver rappresentato una grandissima àncora. Nel momento in cui si sono lasciati alle spalle il passato, avevano un futuro al quale guardare e dire: “Vogliamo essere quella cosa lì”. La Russia non l’ha fatto, sia perché l’Europa non ha mai manifestato alcuna disponibilità, perché aveva ancora abbastanza paura, sia perché comunque l’idea di diventare Europa è il dilemma della storia russa dal Settecento in poi.
L’Ucraina ha fatto ciò che anche la Russia avrebbe potuto fare. È la differenza, passatemi il paragone, tra l’India e la Gran Bretagna. Per la Russia c’era un passaggio in più da fare, però avrebbe potuto fare come la Gran Bretagna: salvare del proprio passato imperiale la parte bella, la cultura, il melting pot, la letteratura, le arti, e ripudiare il colonialismo, lo sfruttamento, il razzismo, eccetera. Ma non l’ha fatto.
La scelta tra futuro e passato è diventata molto evidente nel 2014, quando l’Ucraina è scesa in piazza per chiedere l’Europa. La Russia poi l’ha invasa al grido di “Siamo stati fratelli per mille anni”. Cosa, oltretutto, non vera.
Pare che l’emigrazione abbia giovato un ruolo cruciale. Le mamme dei giovani del 2014 avevano lavorato in Europa, mentre magari i loro papà andavano in Russia...
Questa è un’idea che ho tratto da un articolo di Daniele Raineri pubblicato su “Il Foglio” all’epoca dell’Euromaidan. Siccome in Italia si diceva che quel movimento era pieno di nazisti, Ranieri era andato lì a chiedere ai ragazzi cosa sapevano dell’Europa e del suo passato. Questi gli hanno risposto: “Abbiamo ascoltato i nostri padri, abbiamo ascoltato le nostre madri e ci è piaciuta molto di più la storia delle nostre madri”. Ma lì c’era già tutta una generazione di ucraini cresciuti o comunque con un un pezzo di infanzia vissuta in Europa. Penso a Chef Klopotenko, il più famoso chef ucraino, uno che ha cucinato per tutti i potenti, da Macron a Draghi… Quando l’ho intervistato e gli ho chiesto quale fosse un piatto speciale che aveva mangiato da piccolo, mi ha risposto: “I tortellini in brodo!”. Era venuto in Emilia-Romagna a sette anni -i famosi “bambini di Cernobyl”, cosa che lui non era, ma all’epoca tutti i bambini ucraini passavano per “bambini di Cernobyl”- e li aveva scoperti lì. In Ucraina c’è un piatto simile, i vareniki, che però non sono mai in brodo: insomma, per lui l’idea di mettere nel brodo una pasta ripiena e che poi ci si grattasse sopra il formaggio era fuori dalla grazia di dio. Era la sua madeleine.
Abbiamo molto sottovalutato le vicende dei tanti ragazzini ucraini che hanno avuto un contatto ravvicinato con l’Europa, in particolare con l’Italia, dove poi venivano a lavorare le madri. L’esperienza dell’emigrazione o comunque del viaggio avanti e indietro per lavorare o studiare in Europa era diventata per i giovani ucraini una cosa normale; per i russi, invece, è rimasto un qualcosa di riservato all’élite. I russi, infatti, giudicano l’Europa dagli alberghi che hanno visitato, non dalla quotidianità. C’è stata pochissima emigrazione russa “non oligarchica”. Da noi invece è cresciuta una generazione di ucraine, alcune hanno già la pensione! Qui hanno amici, dottori, hanno mandato i figli a scuola, hanno le case popolari... Per loro l’Europa non era un concetto, un’ideologia, ma una cosa molto viva, pratica.
In conclusione scrivi che solo con una sconfitta in guerra potrà portare giustizia agli ucraini e, forse, libertà alla Russia.
Premetto che penso che i russi abbiano perso un’occasione straordinaria: loro hanno avuto Gorbachev, uno di quei miracoli che ogni tanto capitano. Gorbachev ha fatto il prodigio incredibile di prendere un paese del quale tutto il mondo aveva paura, una dittatura totalitaria dove si diceva che si mangiassero i bambini, con diecimila testate atomiche, e farlo diventare simpatico. Era riuscito a distruggere il comunismo sovietico presentando i sovietici come i vincitori; aveva perso la Guerra fredda, ma siccome era stato lui a rinunciarvi, il paese aveva guadagnato molto credito. A cominciare da un posto al G8 per cui in realtà non aveva assolutamente i requisiti economici. Ecco, i russi hanno completamente sprecato quest’occasione. Ora in tanti, da Putin in giù, dicono che con la Perestrojka “abbiamo perso l’Europa dell’est”. Ma no, non l’avete persa, semmai l’avete liberata! È da qui che nasce tutto il risentimento post-sovietico. La percezione russa è: “Noi non abbiamo perso la Guerra fredda e voi ci trattate come degli sconfitti”.
Anche la vittoria sul nazismo viene trasformata in una vittoria sull’Occidente e sull’Europa, il punto più alto e glorioso della storia russa. Fin lì possiamo essere d’accordo, però se diventa “la cosa più bella che abbiamo fatto, possiamo rifarlo perché è stato bellissimo”... Cioè, non è stata una tragedia, è stata la volta in cui abbiamo scorrazzato per l’Europa e “gliel’abbiamo fatta vedere”. Insomma, temo che finché i sostenitori della Russia di Putin non assaporeranno la sconfitta, non riusciranno a cambiare. Per questo i russi che si sono schierati con la resistenza ucraina sognano l’arrivo di un carro armato ucraino nella Piazza Rossa.
(a cura di Barbara Bertoncin e Bettina Foa)
Nel libro parli, per la Russia, di “shock del futuro”, e fai capire come nessuno avesse ben compreso la portata delle trasformazioni avvenute negli ultimi due decenni.
Credo che in effetti non l’avesse capito nessuno, oltretutto è qualcosa che stiamo vivendo anche nelle società occidentali. Penso alla polarizzazione, al sovranismo, tutti fenomeni senz’altro legati anche a cambiamenti estremamente rapidi, probabilmente i più rapidi che ci siano stati mai nella storia dell’umanità, stravolgimenti che si stanno verificando nell’arco di una vita, se non di mezza vita umana.
Nel caso della Russia parliamo di cambiamenti estremamente rapidi e potenti: questo paese si è trovato non solo a dover recuperare un ritardo preesistente rispetto all’Europa, ma a farlo in un momento in cui tutto il mondo subiva a sua volta un’accelerazione incredibile, di tecnologia, di globalizzazione, di cambiamento di rapporti, gerarchie sociali, geografiche, politiche, ecc.
Per l’ex Unione Sovietica l’impatto di questo cambiamento è stato infinitamente più brutale. Sicuramente in Occidente abbiamo sottovalutato questo fenomeno, così come l’hanno sottovalutato anche i diretti interessati, perché c’era l’idea che un miglioramento non potesse che essere positivo. Certo, diventare più liberi, poter più facilmente accedere al mondo, alla cultura, alla ricchezza e alla possibilità di realizzare le proprie idee, non può che essere un bene; il problema è che molti ex sovietici non erano attrezzati per fruirne senza attraversare uno shock che li ha profondamente segnati.
Non a caso, Vladimir Putin, per un quarto di secolo, ha proposto ai russi la “stabilità”. Era quella la sua ricetta. Di solito, in politica la stabilità viene apprezzata quando si sta bene, in momenti di relativo benessere, quando nessuno vuole cambiare. Nel caso della Russia, invece, la stabilità era apprezzata nonostante non si stesse proprio benissimo. Pur di non avere altri cambiamenti, altri shock, si preferiva conservare quel poco che si aveva senza rischiare più. Perfino tra gli intellettuali russi di stampo diciamo “liberale”, la parola “rivoluzione”, anche quella d’Ottobre, aveva assunto una connotazione negativa.
D’altra parte, il paese che oggi noi chiamiamo Federazione russa, e che è stato per più di settant’anni Unione sovietica, è nato da uno shock, appunto la Rivoluzione d’Ottobre, e poi è collassato in un altro shock, la Perestrojka di Michael Gorbachev, processo che si è concluso con la deflagrazione dell’Unione. Si è trattato di una rivoluzione, non soltanto politica o economica, che ha impattato anche sulle famiglie, sulle relazioni tra genitori e figli, tra dipendenti e datori di lavoro, sul rapporto con il denaro -nell’Urss il denaro non era rilevante, era molto più importante l’accesso a beni che scarseggiavano, che non era garantito dal possesso di contante.
Con la Perestrojka è cambiato veramente tutto: il modo di sposarsi, di fare figli, di cercare lavoro, di progettare la propria vita, e questo ha avuto un impatto su milioni e milioni di famiglie, anche su chi fieramente proclamava di non interessarsi alla politica e di considerarla una cosa noiosa, sporca. Nessuno, in un paese che all’epoca contava circa trecento milioni di abitanti, ne è uscito indenne, cioè senza sconvolgimenti, casomai anche positivi, ma comunque enormi.
Ecco, in Occidente abbiamo sottovalutato tutto ciò, non abbiamo capito niente, fino a che non è apparso Putin e ha cominciato a raccontare ai russi e a se stesso la favola di un passato al quale la Russia doveva tornare perché il presente non era positivo.
Mi hanno colpito molto i racconti di vita quotidiana sotto il comunismo, anche il semplice fare la spesa era qualcosa di molto lontano dalla nostra esperienza...
Ho fatto di recente una conferenza in un liceo a Biella e ho percepito la difficoltà degli studenti a comprendere il mio racconto. Figuriamoci, ci sono cose che anche chi studiava la Russia non riusciva a capire, pensa i quindicenni di oggi… Ho provato a far immaginare loro come potesse essere frequentare una scuola sovietica del 1983, tutti in uniforme, i capelli della stessa lunghezza, le ragazze che non possono truccarsi, il non poter fumare, non conoscere il significato della parola “sesso”, guardare, ascoltare e leggere tutti le stesse cose, e poi avere davanti a sé una vita estremamente regolamentata: dopo la scuola il militare, poi alcuni l’università, altri un istituto tecnico… Non credo di esserci riuscita, tanto più che i ragazzi davanti a me, anche visivamente, erano tutti diversissimi, quelli con i capelli lunghi, quelli rapati, quelle con il velo… Poi ho detto loro: “Immaginate di entrate in un negozio perché volete comprare il formaggio e di non trovarlo”.
Secondo me non riesci neanche a spiegarglielo. “Cosa vuol dire non c’è il formaggio? Vai in un altro negozio!”. Non solo, entravi in un emporio, e invece di sentire i profumi di cibo buono ti veniva quasi un conato di vomito, perché le patate erano sporche, piene di terra... ma poi c’era questo odore di marcio, di terra, di umido. (Tutti questi orrori poi venivano trasformati in piaceri della vita attraverso la cucina delle nonne). Nel paese che aveva lanciato il primo uomo nello spazio non si riusciva a trovare il latte a lunga conservazione; nei negozi c’era sempre questo odore di rancido, perché non essendoci alcuna refrigerazione ed essendo le confezioni bucate, il latte andava a male e c’era sempre quel rivolo… quindi dovevi sempre controllare la data di produzione: se era del giorno prima o del giorno stesso aveva comunque poca vita. Infatti nei negozi si aspettava il “latte di domani”, quello che superava la quota del piano giornaliero e che di solito arrivava solo nel pomeriggio.
Ecco, questa cosa devi averla annusata, per capirla.
Nel ripercorrere le radici del risentimento russo verso l’Ucraina, denunci anche la nostra cecità...
Mi è capitato di rileggere un’intervista fatta nel giugno 2015 da Luciano Fontana e Paolo Valentino a Putin per il “Corriere della Sera”. Un’intervista che aveva fatto discutere, perché la Crimea era già stata annessa e ci si chiedeva quanto fosse corretto intervistare Putin senza contraddittorio.
L’intervista era sicuramente noiosa: Putin alla fine ripeteva sempre le stesse cose: “È colpa dell’Occidente”, “In Ucraina c’è stato il golpe nazista”... Senza voler per forza risalire al Settecento, è incredibile come, in realtà, anche il recente allontanamento della Russia dall’Europa sia avvenuto sotto i nostri occhi, mentre noi mandavamo i nostri migliori giornalisti a domandare a Putin “Perché?”, a parlargli di cooperazione... Cioè, abbiamo continuato a rivolgerci a lui come se fosse europeo, come se fosse uno con cui abbiamo avuto qualche diverbio… Ma parliamo di uno che per la prima volta dopo il ’45 si è annesso un territorio in Europa! Non è come noi! Già due anni prima nel suo discorso alle camere riunite aveva detto che “la Russia non è Europa” e che la Russia non doveva condividere i valori europei... Insomma, è avvenuto tutto sotto i nostri occhi.
Che dire? Un po’ non volevamo crederci, un po’ avevamo i nostri problemi con Al-Qaeda e l’Isis. Anzi, proprio per la minaccia del terrorismo, la Casa Bianca aveva rivalutato l’alleanza con Putin, che comunque era bianco e cristiano, quindi in quest’idea di scontro di civiltà Putin doveva stare con noi. Idea, per fortuna, poi completamente dimenticata, ma ricordiamoci che c’è stato un tempo in cui persone anche molto illuminate, gli stessi che oggi chiedono che Putin sia processato all’Aja per crimini contro l’umanità, pensavano che fosse un alleato prezioso.
Perché Putin ha voluto prendersi la Crimea e ora l’Ucraina? Da dove nasceva questa “necessità”?
Non era “necessario” per nessuno, tant’è vero che gli stessi russi non si aspettavano neppure l’annessione della Crimea. Sicuramente c’era molta nostalgia per l’Urss, un sentimento presente anche in altri paesi. Ma, attenzione, lo abbiamo visto anche alle recenti elezioni in Moldova e Romania: c’è una parte della popolazione, soprattutto quella più anziana, vittima di questo “future shock”, che è nostalgica e molto sensibile ai richiami alla stabilità, al passato, anche al socialismo, a una povertà con però delle garanzie.
È un discorso che esisteva anche in Ucraina: tuttora lì ti diranno che tutto sommato con l’Unione sovietica si stava bene, avevi la macchina -poi non è vero, l’avevano in pochissimi-, e prima o poi ti veniva assegnato un piccolo appartamento, nessuno era ricco ma nessuno era nemmeno poverissimo, la gente andava a scuola e all’ospedale… A dirti queste cose sono ucraini che non vogliono l’invasione russa!
Questo per dire che tale nostalgia era abbastanza assestata, non rappresentava un problema, e i russi già prima potevano andare a fare le vacanze in Crimea senza bisogno di visto.
La verità è che non ci andavano più, perché il livello dei servizi offerti, a parità di prezzo, era di molto inferiore a quelli della costa spagnola o turca; infatti, il turismo in Crimea era praticamente morto. Motivo per cui la Crimea stessa era nostalgica dell’Unione sovietica; molti crimeani pensavano che tornare alla Russia equivalesse a un rifiorire, a diventare una Rimini pansovietica.
Quando poi Putin ha annesso la Crimea, gli stessi russi sono rimasti sorpresi: “Ma come? Si poteva fare?”. Dalla sorpresa è scaturito poi un orgoglio nazionalista, che ha contagiato anche molti liberali anti-putiniani, perché comunque resiste l’idea per cui “più territorio si ha più si è grandi”. Sicuramente, in questo senso, l’indipendenza dell’Ucraina era stata percepita da tanti russi come un errore, perché mentre gli uzbeki, i georgiani o gli abitanti dei paesi baltici erano percepiti come diversi -per lingua, religione, storia, tratti somatici- gli ucraini erano da sempre i loro “cugini di campagna”. Ma anche questa percezione si andava appianando.
Se la Russia avesse continuato a evolversi, diventando più ricca, più promettente, con più università, case editrici, eccetera, sarebbe tornata naturalmente a essere un polo d’attrazione per quasi tutto lo spazio ex sovietico. Prendiamo, ad esempio, l’immigrato clandestino tagiko che andava a lavorare nei cantieri moscoviti per mantenere la famiglia in patria; ebbene, il Tagikistan soprattutto, ma anche in parte l’Uzbekistan, vive delle rimesse degli immigrati in Russia. Oppure, uno dei maggiori oligarchi russi, Michail Friedman, è nato a Leopoli, però se ne è andato a Mosca perché lì a suo dire pativa meno l’antisemitismo. O il direttore del maggiore festival cinematografico russo, l’ucraino Alexander Rodniansky, anche lui era andato a vivere in Russia -poi, con la guerra, si è schierato con l’Ucraina e vive da esule in Italia.
Ripeto, la Russia sarebbe diventata naturalmente un polo di attrazione dell’ex spazio postsovietico. Ovviamente, più Mosca mostrava il volto di un centro imperiale che pretendeva fedeltà dagli altri paesi, più questi si allontanavano cercando di entrare nell’orbita dell’Ue e degli Stati Uniti.
Quindi, tornando alla domanda, no, non c’era alcun bisogno di annessioni. O meglio, il bisogno stava tutto nella sopravvivenza del regime di Putin, che riteneva di dover reggere il suo comando in buona parte su questo sogno di grandezza, sulla militarizzazione, e per dirottare l’attenzione dai problemi economici interni, dalla corruzione e dalla totale assenza di alternanza del potere.
Dopodiché, nella visione di Putin, a rendere “imperiale” la Russia, è l’Ucraina. Basta guardare la cartina geografica: la Russia diventa un impero europeo solo se ha l’Ucraina e la Bielorussa. Senza, rimane un grande paese essenzialmente asiatico.
Putin interpreta questa voglia di tornare alla grandeur e contemporaneamente il bisogno di quel grigiore che aveva anche degli aspetti rassicuranti…
È così. Il grigiore era rassicurante perché si sapeva cosa ti avrebbe riservato il domani.
Un’altra componente psicologica che non si era minimamente compresa in Occidente è che gli ex sovietici avevano scelte molto ridotte a qualunque livello: cosa indossare, quale profumo mettersi, che spettacolo teatrale scegliere, perché era tutto scarso. La Tv mostrava sempre gli stessi film o cartoni animati… Per esempio, c’era una serie popolarissima, l’equivalente di Tom e Jerry, dove c’era un lupo che inseguiva un leprotto. Molto carina, disegnata bene, però ne sono uscite credo venti puntate in vent’anni! È curioso notare come ancora oggi generazioni molto diverse di ex sovietici si raccolgano intorno a un film, a un cibo, a una canzone, a un libro, ma perché erano sempre gli stessi per decenni. Era un mondo molto poco variabile. I russi, è vero, volevano l’abbondanza occidentale, però non erano assolutamente pronti a entrare in un supermercato per scegliere tra trenta tipi di formaggio.
Vivevano in un mondo dove erano abituati a poter essere fregati dallo stato, e per questo, infatti, nutrivano una grande diffidenza; però, allo stesso tempo, sapevano che il formaggio era formaggio, il latte era latte... l’idea che un prodotto occidentale potesse essere una truffa, un falso o una schifezza non c’era. Nei primi anni post-comunisti l’area sovietica venne invasa da porcate di ogni genere, dalla vodka polacca farlocca, alle finte magliette Chanel dalla Turchia…
Non erano preparati neppure alla pubblicità, o alle catene di sant’Antonio, alle truffe bancarie. Nei primi anni milioni di persone hanno perso dei soldi perché non c’era nessun tipo di anticorpo: la pubblicità veniva considerata un’informazione, non una cosa da prendere con le pinze. Se qualcuno ti prometteva il 300% in un mese, gli credevi e gli portavi i soldi. Allo stesso modo, se qualcuno ti diceva che un detersivo lavava “bianco che più bianco non si può” ci credevi.
Allo stesso modo erano impreparati a una politica aperta, pubblica, competitiva, dove si litiga, dove si fanno promesse che poi non si realizzano. C’era un rapporto gerarchico codificato: le autorità ti dicevano cosa dovevi fare, la televisione pure, e non poteva essere diversamente.
Ricordo persone anche non troppo anziane che erano sconvolte dalla velocità dei telegiornali moderni, perché erano abituati a un tg con due conduttori, un lui e una lei, impettiti, perfetti, che con voci metalliche, a turno -rigorosamente leggendo- dicevano cose del tipo: “Oggi il segretario generale del comitato centrale del Partito comunista ha incontrato gli esponenti del settore agro industriale della Siberia…”. Era un rito quasi religioso.
Poi è arrivato il telegiornale che dava le notizie vere. Gli aerei cadevano... ma quando mai erano caduti aerei in Unione sovietica? Non si poteva dire, perché i tg dovevano dare l’impressione di un paese senza droga, prostituzione o povertà, dove tutto andava bene. Era l’Occidente, casomai, a essere il luogo della tossicodipendenza, del vizio, della criminalità. L’Urss veniva raccontata come un mondo dove una ragazza poteva passeggiare alle due di notte in minigonna senza temere per la sua virtù. E invece no, aveva assolutamente da temere!
C’è un passaggio in cui dici che i russi hanno quasi volontariamente rinunciato alla propria libertà.
Senza dubbio i russi non sapevano che farsene della libertà, anche perché nessuno gli aveva mai detto cosa fosse. Per come la vedevano, con la libertà in Russia era arrivato il caos economico, la disoccupazione, la confusione. Persone che fino al giorno prima avevano un lavoro d’ufficio e un qualche tipo di prestigio sociale, a un certo punto passavano a commerciare, che so, vodka, diventando magari anche più benestanti, però decadendo socialmente. Sicuramente la monotonia del passato veniva idealizzata come il bel mondo dove tutto era rassicurante, come una sorta di infanzia mitizzata. Pensa ai bambini che vogliono mangiare sempre le stesse cose, guardare sempre lo stesso cartone, farsi leggere sempre la stessa fiaba e spaventarsi sempre nello stesso momento.
Non mi ricordo chi è stato a dire che “la libertà arriva nuda”. Ecco, in Russia la libertà è arrivata abbastanza svestita e malconcia: con essa sono arrivate la corruzione, le ruberie, l’inganno, gli oligarchi, la criminalità, l’assenza di regole… Pensate cosa poteva significare un licenziamento su due piedi in un paese dove prima tutti dovevano avere un lavoro, anche con uno stipendio ridicolo, e si veniva assunti a vita anche per non fare niente, perché non poteva esserci disoccupazione. All’improvviso ci si è trovati a dover lottare per la sopravvivenza!
A questa situazione si erano aggiunti i conflitti interetnici, la guerra in Cecenia, il terrorismo…
Così, all’inizio degli anni Duemila, quando è arrivato Putin con lo slogan “meno libertà e più sicurezza” i russi lo hanno votato. Per questo dico che i russi hanno restituito volontariamente la libertà.
Io credo che chi ha votato Putin sapesse benissimo che avrebbe imposto il pugno di ferro. Quanto sarebbe stato duro quel pugno sarebbe stato difficile immaginarlo anche per i politologi, figuriamoci per l’elettore comune. Comunque, avevano perfettamente intuito che con Putin ci sarebbe stata meno libertà, e gli andava bene. Si chiamava “ordine”, un altro classico del discorso russo: l’ordine è quando il criminale va in galera, le donne sono donne e gli uomini sono uomini. Insomma, credo che per la maggior parte delle persone che l’hanno votato la scelta fosse ovvia: meno libertà, soprattutto politica e più protezione, sia militare-poliziesca, ma anche sociale ed economica.
Putin questa cosa fino a un certo punto l’ha assicurata. Dopo venticinque anni, però, ha tolto all’improvviso tutte le sicurezze. Oggi i russi hanno scoperto che i loro figli possono essere mandati in guerra, o che si possono perdere i risparmi o le pensioni perché c’è bisogno di carri armati, e che all’improvviso si può viaggiare solo in Cina e in Turchia. Ma questo è successo quando ormai non potevano più esprimersi.
Venendo all’Ucraina, da tempo ragioni sulla biforcazione, sulle diverse strade che hanno preso i due paesi, uno che guarda ai giovani, al futuro, e l’altro rivolto al passato...
Credo che la cosa più importante che ho fatto a partire dal 2019 sia stata andare in Ucraina e studiare il fenomeno Zelensky, in un momento in cui il resto del mondo, non solo in Italia, lo inquadrava come il “comico diventato presidente”. Zelensky in realtà è stato il compimento di un processo che era in corso da tre decenni, quello appunto della costruzione di una nazione, che ovviamente era stato un lavoro corale. La verità è che gli europei, nella loro ignoranza, nemmeno sapevano dove fosse l’Ucraina, e certo non sapevano che stava nascendo un paese vero, che aveva lavorato sulla riappropriazione della propria storia, della lingua, della cultura (anche in maniera discutibile, certe volte), con il risultato di far crescere una generazione di persone che si sentivano ucraine e non più post-sovietiche.
Prima di allora, l’ultima volta che ero stata in Ucraina era nel 2010, per la campagna presidenziale Yanukovych-Timoshenko. Mi ero presentata con la classica logica binaria che si utilizza ancora, “filorussi-antirussi”. Loro mi guardavano sconvolti... non era quello il punto. Ovviamente c’erano quelli che spingevano per un’integrazione europea e chi diceva che bisognava continuare a commerciare con la Russia. All’epoca c’era anche uno spazio culturale molto più condiviso, gli artisti ucraini andavano a esibirsi al Cremlino e viceversa. Non c’era ancora questa contrapposizione ideologica. Insomma, nel 2010 ho capito molto in fretta che in Occidente stavamo applicando logiche completamente sbagliate.
Da qualche tempo, con degli amici e colleghi ucraini, a Milano facciamo un festival che si chiama “Ucraina è Ucraina”. Abbiamo preso spunto dal famoso spot del “Corriere della Sera” per la sua “Enciclopedia degli anni Novanta”, in cui si vede un cosmonauta che atterra con la sua capsula in un campo e dice “madre Russia”, a quel punto gli si avvicina una contadina e gli dice: “Ma no, questa è Ucraina”. E lui: “Ma la Russia non è Ucraina?”, al che la contadina risponde “Ucraina è Ucraina!” (https://www.youtube.com/watch?v=7XtqfyJi7uE).
Ecco, il punto è che l’Ucraina è Ucraina, non è una Russia o un’ex Russia.
La Russia non ha minimamente percepito il fatto che era nato un paese che aveva recuperato parte delle sue identità (non solo russe o sovietiche), che si sentiva ed era molto più in Europa e che aveva compiuto quel passaggio generazionale che la Russia non ha mai voluto fare. Oggi è lampante: basta guardare un telegiornale per confrontare la classe dirigente di Zelensky con Putin e quelli che lo circondano: ci sono quarant’anni di differenza!
L’Ucraina è un paese che non si è immerso nella nostalgia. D’altra parte, di cosa doveva avere nostalgia? Dell’impero russo? Piuttosto, per l’Ucraina è l’Europa ad aver rappresentato una grandissima àncora. Nel momento in cui si sono lasciati alle spalle il passato, avevano un futuro al quale guardare e dire: “Vogliamo essere quella cosa lì”. La Russia non l’ha fatto, sia perché l’Europa non ha mai manifestato alcuna disponibilità, perché aveva ancora abbastanza paura, sia perché comunque l’idea di diventare Europa è il dilemma della storia russa dal Settecento in poi.
L’Ucraina ha fatto ciò che anche la Russia avrebbe potuto fare. È la differenza, passatemi il paragone, tra l’India e la Gran Bretagna. Per la Russia c’era un passaggio in più da fare, però avrebbe potuto fare come la Gran Bretagna: salvare del proprio passato imperiale la parte bella, la cultura, il melting pot, la letteratura, le arti, e ripudiare il colonialismo, lo sfruttamento, il razzismo, eccetera. Ma non l’ha fatto.
La scelta tra futuro e passato è diventata molto evidente nel 2014, quando l’Ucraina è scesa in piazza per chiedere l’Europa. La Russia poi l’ha invasa al grido di “Siamo stati fratelli per mille anni”. Cosa, oltretutto, non vera.
Pare che l’emigrazione abbia giovato un ruolo cruciale. Le mamme dei giovani del 2014 avevano lavorato in Europa, mentre magari i loro papà andavano in Russia...
Questa è un’idea che ho tratto da un articolo di Daniele Raineri pubblicato su “Il Foglio” all’epoca dell’Euromaidan. Siccome in Italia si diceva che quel movimento era pieno di nazisti, Ranieri era andato lì a chiedere ai ragazzi cosa sapevano dell’Europa e del suo passato. Questi gli hanno risposto: “Abbiamo ascoltato i nostri padri, abbiamo ascoltato le nostre madri e ci è piaciuta molto di più la storia delle nostre madri”. Ma lì c’era già tutta una generazione di ucraini cresciuti o comunque con un un pezzo di infanzia vissuta in Europa. Penso a Chef Klopotenko, il più famoso chef ucraino, uno che ha cucinato per tutti i potenti, da Macron a Draghi… Quando l’ho intervistato e gli ho chiesto quale fosse un piatto speciale che aveva mangiato da piccolo, mi ha risposto: “I tortellini in brodo!”. Era venuto in Emilia-Romagna a sette anni -i famosi “bambini di Cernobyl”, cosa che lui non era, ma all’epoca tutti i bambini ucraini passavano per “bambini di Cernobyl”- e li aveva scoperti lì. In Ucraina c’è un piatto simile, i vareniki, che però non sono mai in brodo: insomma, per lui l’idea di mettere nel brodo una pasta ripiena e che poi ci si grattasse sopra il formaggio era fuori dalla grazia di dio. Era la sua madeleine.
Abbiamo molto sottovalutato le vicende dei tanti ragazzini ucraini che hanno avuto un contatto ravvicinato con l’Europa, in particolare con l’Italia, dove poi venivano a lavorare le madri. L’esperienza dell’emigrazione o comunque del viaggio avanti e indietro per lavorare o studiare in Europa era diventata per i giovani ucraini una cosa normale; per i russi, invece, è rimasto un qualcosa di riservato all’élite. I russi, infatti, giudicano l’Europa dagli alberghi che hanno visitato, non dalla quotidianità. C’è stata pochissima emigrazione russa “non oligarchica”. Da noi invece è cresciuta una generazione di ucraine, alcune hanno già la pensione! Qui hanno amici, dottori, hanno mandato i figli a scuola, hanno le case popolari... Per loro l’Europa non era un concetto, un’ideologia, ma una cosa molto viva, pratica.
In conclusione scrivi che solo con una sconfitta in guerra potrà portare giustizia agli ucraini e, forse, libertà alla Russia.
Premetto che penso che i russi abbiano perso un’occasione straordinaria: loro hanno avuto Gorbachev, uno di quei miracoli che ogni tanto capitano. Gorbachev ha fatto il prodigio incredibile di prendere un paese del quale tutto il mondo aveva paura, una dittatura totalitaria dove si diceva che si mangiassero i bambini, con diecimila testate atomiche, e farlo diventare simpatico. Era riuscito a distruggere il comunismo sovietico presentando i sovietici come i vincitori; aveva perso la Guerra fredda, ma siccome era stato lui a rinunciarvi, il paese aveva guadagnato molto credito. A cominciare da un posto al G8 per cui in realtà non aveva assolutamente i requisiti economici. Ecco, i russi hanno completamente sprecato quest’occasione. Ora in tanti, da Putin in giù, dicono che con la Perestrojka “abbiamo perso l’Europa dell’est”. Ma no, non l’avete persa, semmai l’avete liberata! È da qui che nasce tutto il risentimento post-sovietico. La percezione russa è: “Noi non abbiamo perso la Guerra fredda e voi ci trattate come degli sconfitti”.
Anche la vittoria sul nazismo viene trasformata in una vittoria sull’Occidente e sull’Europa, il punto più alto e glorioso della storia russa. Fin lì possiamo essere d’accordo, però se diventa “la cosa più bella che abbiamo fatto, possiamo rifarlo perché è stato bellissimo”... Cioè, non è stata una tragedia, è stata la volta in cui abbiamo scorrazzato per l’Europa e “gliel’abbiamo fatta vedere”. Insomma, temo che finché i sostenitori della Russia di Putin non assaporeranno la sconfitta, non riusciranno a cambiare. Per questo i russi che si sono schierati con la resistenza ucraina sognano l’arrivo di un carro armato ucraino nella Piazza Rossa.
(a cura di Barbara Bertoncin e Bettina Foa)
Archivio
LA LEZIONE DELLA BOSNIA
Una Città n° 308 / 2025 marzo
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
Konstanty Gebert è scrittore e giornalista per il quotidiano polacco “Gazeta Wyborcza”. È stato corrispondente di guerra nei Balcani e advisor del Special Rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori dell’ex ...
Leggi di più
Cosa significa pace per gli ucraini
Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto
Oleksandra Matviichuk è presidente del centro per le libertà civili in Ucraina, che ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2022 per il suo impegno nel documentare i crimini di guerra, le violazioni dei diritti umani e gli abusi di poter...
Leggi di più
DA CHAMBERLAIN A TRUMP
Una Città n° 307 / 2025 febbraio
Realizzata da Stefano Ignone
Realizzata da Stefano Ignone
Le analogie storiche non calzano mai perfettamente: il 2025 non è certo il 1938. La data a noi più prossima ha segnato il tentativo di imporre una pace sulla guerra russo-ucraina, mentre quella più distante era stata contraddistinta d...
Leggi di più
UNA TOMBA PER DUE. ISRAELE, PALESTINA E LA GUERRA
Realizzata da Stefano Ignone
Una citazione attribuita a Confucio dice che chi cerca vendetta dovrebbe scavare due tombe, una delle quali destinata a se stesso. Ciò che sta alla base della guerra tra Israele e Palestina sembrerebbe confermare questo adagio. Gli intellettuali no...
Leggi di più
QUEL FRUTTO AVVELENATO
“Amo le vite che quasi non parlano”, recita un verso famoso di una poesia di Saba del 1944. Da quando, il titolo: “Da quando la mia bocca è quasi muta / amo le vite che quasi non parlano”. Ho invidiato la rapidità e l...
Leggi di più