Il litigioso, surriscaldato clamore politico suscitato da George Orwell con i suoi due romanzi-pamphlet anticomunisti e antitotalitari, La fattoria degli animali (1945) e 1984 (1949), hanno fatto dimenticare la sua ampia produzione saggistica e giornalistica. Bernard Crick, il maggiore studioso e biografo di Orwell, ha riconosciuto, in accordo con il critico americano Irving Howe, che la sua vera grandezza letteraria è quella del saggista, il maggiore nella letteratura inglese, dopo due classici come William Hazlitt e Samuel Johnson. È vero che Orwell nel corso della vita ha pubblicato diversi romanzi più o meno apertamente autobiografici. Ma la sua carriera è stata in prevalenza quella di un giornalista, di un reporter autobiografico e di un intellettuale militante. Benché abbia scritto il breve saggio “In difesa del romanzo” contro coloro che lo pubblicizzavano come merce (“Moltissimi romanzi non dovrebbero essere neppure nominati”), Orwell scrisse anche che l’esistenza del romanzo dovrebbe essere difesa da una critica letteraria seriamente selettiva, scritta magari da dilettanti “non prezzolati” ma onesti, che distinguano i pochi romanzi di serie A dalla marea di romanzi di serie B che “le persone intelligenti”, senza essere per questo degli intellettuali, non accetterebbero mai di leggere. Nel saggio del 1946 “Perché scrivo”, che si tratti di narrativa o di saggistica, Orwell afferma: “Quello che ho maggiormente cercato di fare negli ultimi dieci anni è stato trasformare la scrittura politica in un’arte”. Quegli ultimi dieci anni erano gli anni in cui scrisse “La strada di Wigan Pier”, reportage dal South Yorkshire dei minatori, che è anche un saggio sulle classi sociali inglesi e la loro complessa, sottile stratificazione; un saggio sociale anche autobiografico in cui, non senza umorismo, Orwell dice di appartenere alla upper lower middle-class, in una medietà nella quale si gode e si soffre nello stesso tempo tanto di superiorità che di inferiorità. Ma è anche il decennio cruciale e decisivo che cominciò con la sua breve ma intensissima partecipazione alla guerra civile spagnola. Nel suo Omaggio alla Catalogna (1938) sono raccontati quei magnifici e terribili sei mesi, dicembre 1936-estate 1937, passati combattendo sia contro il fascismo di Franco sia contro la sinistra stalinista che dava la caccia agli anarchici e agli antifascisti dissidenti per eliminarli. Orwell precisò la propria identità e il proprio impegno di scrittore nell’articolo del 24 giugno 1938 in cui spiegava perché si era iscritto al Partito Laburista Indipendente:
Forse l’approccio più sincero sarà quello di partire dalla mia situazione personale. Sono uno scrittore. E l’impulso di ogni scrittore è quello di “tenersi alla larga dalla politica”. Desidera essere lasciato in pace per poter continuare a scrivere tranquillamente i propri libri. Purtroppo è sempre più chiaro che questo è un ideale irrealizzabile [...]. L’era della libertà di parola è arrivata al capolinea [...]. Verrà il tempo -non fra un anno, forse, né fra dieci o venti- in cui lo scrittore si troverà a un bivio: ridursi al silenzio oppure produrre la droga che una minoranza privilegiata gli richiederà.
Sento il dovere di oppormi a tale tendenza, come sento il dovere di oppormi all’olio di ricino, ai manganelli e ai campi di concentramento, e l’unica forma di governo che, a lungo termine, avrà il coraggio di consentire la libertà di parola è quella socialista [...]. Chiunque abbia la capacità di pensare non può vivere in una società come la nostra senza provare il desiderio di cambiarla. Più o meno negli ultimi dieci anni ho cominciato a comprendere la vera natura della società capitalista. In Birmania ho visto all’opera l’imperialismo inglese e nel mio Paese ho avuto esperienza degli effetti provocati dalla povertà e dalla disoccupazione. Grande o piccolo che sia stato, il mio contributo alla lotta contro il sistema è consistito nello scrivere libri con cui speravo di influenzare il pubblico dei lettori. Continuerò a farlo, naturalmente, ma in un momento come questo non basta scrivere libri. Il ritmo degli eventi è sempre più incalzante; i pericoli che un tempo sembravano riguardare le generazioni future si parano già minacciosamente davanti alla nostra.
(in Romanzi e saggi, Meridiani Mondadori 2000,
a cura di Guido Bulla, pp. LXXVI)
Ma merita rileggere, fra i tanti pessimismi per i quali Orwell è diventato famoso, le prime pagine di Omaggio alla Catalogna, con l’emozionata, liberatoria scoperta di una guerra civile che fu, almeno all’inizio, una promessa e un’esperienza di rivoluzione:
Nella caserma Lenin di Barcellona, il giorno prima del mio arruolamento fra i miliziani, ne vidi uno, italiano, in piedi davanti al tavolo degli ufficiali.
Era un giovanotto dall’aspetto rude, sui venticinque o ventisei anni, con capelli biondo-rossicci e spalle possenti. Il berretto di cuoio a punta gli calava spavaldamente su un occhio. Lo guardavo di profilo, il mento sul petto, mentre osservava con un cipiglio di perplessità una carta geografica che uno degli ufficiali teneva aperta sul tavolo. Qualcosa, nel suo volto, mi commosse profondamente. Era il volto di un uomo che poteva commettere un omicidio, e buttare via la propria vita per un amico: il tipo di faccia che vi aspettereste in un anarchico, anche se con ogni probabilità era un comunista. C’era in lui ferocia e candore insieme; nonché il patetico rispetto che gli illetterati hanno per i loro supposti superiori. Era chiaro che di quella carta non capiva niente, e che considerava la lettura delle carte geografiche una straordinaria impresa intellettuale. Non saprei dire perché, ma di rado ho incontrato qualcuno che mi ispirasse una così immediata simpatia. Mentre parlavano intorno al tavolo, risultò da non so che osservazione buttata lì che io ero uno straniero. L’italiano alzò la testa e domandò subito:
“Italiano?”
“No, inglés”, risposi nel mio cattivo spagnolo. “Y tu?”
“Italiano”.
Nell’attraversare la stanza per andarsene, mi afferrò strettamente la mano. Che strano l’affetto che si può sentire per uno sconosciuto! [...]. Sperai che mi avesse in simpatia come io avevo lui. Ma capii anche che per conservare quella mia prima impressione avuta di lui non dovevo rivederlo, ed è inutile dire che non l’ho mai più rivisto. Si fanno sempre incontri di questo genere in Spagna [...]. Ero venuto in Spagna con la vaga idea di scrivere degli articoli per qualche giornale, ma mi ero arruolato nella milizia antifranchista quasi immediatamente, perché a quel tempo e in quell’atmosfera sembrava la sola cosa che si potesse pensare di fare. Gli anarchici avevano ancora il virtuale controllo della Catalogna e la rivoluzione era ancora nel suo pieno vigore [...].
Era la prima volta che mi trovavo in una città in cui la classe operaia era al potere. Praticamente ogni edificio di qualunque dimensione era stato occupato dai lavoratori e coperto con bandiere rosse, o con quelle rosse e nere degli anarchici; su tutti i muri erano scarabocchiati la falce e il martello con le iniziali dei partiti rivoluzionari, quasi ogni chiesa saccheggiata e le immagini sacre bruciate [...]. Botteghe e caffè esibivano scritte che ne annunciavano la collettivizzazione; perfino i lustrascarpe erano stati collettivizzati e le loro cassette dipinte in rosso e nero. I camerieri e gli inservienti di negozio vi guardavano in faccia trattandovi alla pari [...], ognuno chiamava gli altri “compagno” usando il “tu” e diceva “Salud!” invece di “Buenos dias”. Qualsiasi mancia era proibita dalla legge.
Questo il tono e l’atmosfera indimenticabili all’inizio della guerra civile spagnola, che poi annegò negli scontri a fuoco fra comunisti e anarchici, determinando la sconfitta della sinistra repubblicana antifranchista. Delusione e demoralizzazione furono enormi e annunciarono l’incapacità europea di fermare, poco dopo, la guerra scatenata da Hitler e Mussolini.
Ricordando ancora una volta quella guerra civile, il clima in cui avvenne e il sogno rivoluzionario che la accompagnò anche fuori dalla Spagna, Orwell descrisse così il suo viaggio da Parigi verso Barcellona nel dicembre del 1936:
Il treno, un accelerato, era pieno di cechi, tedeschi, francesi, tutti diretti verso la stessa destinazione [...]. La mia vettura di terza classe era strapiena di giovanissimi Tedeschi denutriti, biondi, con vestiti miserabili. A ogni fermata si precipitavano fuori dal treno per comprarsi bottiglie di vino da poco prezzo, bevevano e poi si addormentavano. Verso la metà del viaggio tutti i viaggiatori normali erano ormai scesi. Qua e là c’era qualche indefinibile giornalista come me, ma il treno era diventato una tradotta e il paese lo sapeva. Al mattino, mentre si arrancava nella Francia del sud, ogni contadino che lavorava nei campi si girava verso di noi, si metteva sull’attenti e alzava in segno di saluto il pugno chiuso. Erano come una guardia d’onore che accompagnava il treno, miglio dopo miglio.
L’apocalittico Orwell, colui che poco prima di morire a soli quarantasei anni immaginò un possibile totalitarismo futuro più perfetto di quelli precedenti, visse almeno in Spagna per alcuni mesi l’ultimo breve sogno di una rivoluzione socialista in Europa.
Orwell in Spagna
di letteratura e altro
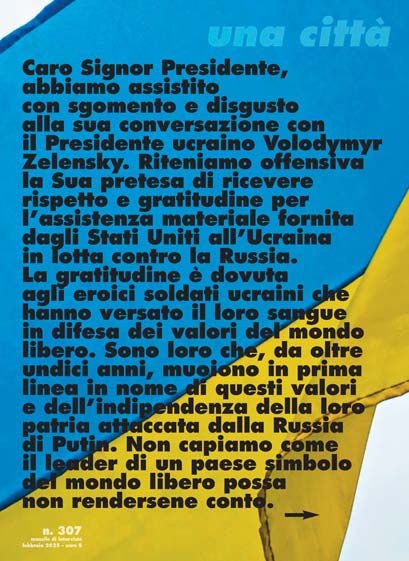
Una Città n° 307 / 2025 febbraio
Articolo di Alfonso Berardinelli
Orwell in Spagna
di Alfonso Berardinelli
Archivio
BASTA CON AMLETO
Una Città n° 106 / 2002 Agosto-Settembre
Realizzata da Franco Melandri, Gianni Saporetti
Realizzata da Franco Melandri, Gianni Saporetti
Alfonso Berardinelli, critico letterario e saggista, recentemente ha pubblicato: Stili dell’estremismo (Editori Riuniti), Cactus (ed L’ancora), Nel paese dei balocchi, (ed. Donzelli), La forma del saggio (Marsilio).Uno dei principali obiettivi polemici de...
Leggi di più
E TU A COSA SERVI?
Una Città n° 116 / 2003 Ottobre
Realizzata da Katia Alesiano, Franco Melandri
Realizzata da Katia Alesiano, Franco Melandri
Alfonso Berardinelli, critico letterario e saggista, recentemente ha pubblicato: Stili dell’estremismo (Editori Riuniti), Cactus (ed L’ancora), Nel paese dei balocchi, (ed. Donzelli), La forma del saggio (Marsilio).Di che cosa parliamo quando parliamo di ...
Leggi di più
LA VARIETA’ DEL REALE
Una Città n° 35 / 1994 Ottobre
Realizzata da Rocco Ronchi, Franco Melandri
Realizzata da Rocco Ronchi, Franco Melandri
Nel suo ultimo libro lei sostiene che è in crisi l’autocomprensione che la pratica poetica ha avuto di se stessa nella modernità e quindi è necessario che la poesia si riapra, che ritrovi uno spazio comunicativo. Ma cosa vuol dire che la poesia, e la lett...
Leggi di più
COSE FATTE, SEMPLICEMENTE
Una Città n° 27 / 1993 Novembre
Realizzata da Franco Melandri
Realizzata da Franco Melandri
L’attuale crisi italiana ripropone la discussione fra chi vede nella politica solo l’ambito della mediazione e chi invece ritiene che essa debba anche indicare scopi generali o modelli di società... Direi innanzitutto che oggi, come venti o trenta anni fa...
Leggi di più
Norberto Bobbio tra politica e cultura
Una Città n° 314 / 2025 ottobre-novembre
Filosofo del diritto e della politica, intellettuale impegnato nella discussione sui rapporti fra intellettuali e potere, fra cultura e politica, Norberto Bobbio è stato per decenni un punto di riferimento etico e teorico in Italia e non soltanto. ...
Leggi di più


















