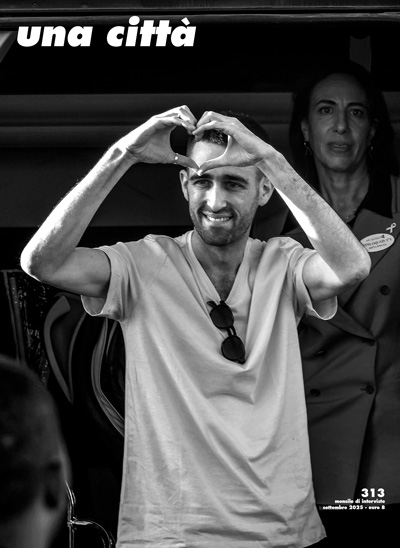Vorremmo partire da concetto di genocidio e dalla sua elaborazione.
Il concetto risale al lavoro di Raphael Lemkin, un giurista ebreo polacco, che durante i suoi studi negli anni Venti all’Università di Leopoli rimase scioccato da quello che all’epoca veniva definito il massacro degli armeni. La parola genocidio non esisteva ancora. Lui non si dava pace e chiese al suo professore come mai quel crimine non venisse perseguito dalla giustizia internazionale. Il professore gli rispose, esprimendo perfettamente il senso della legge dell’epoca, che gli stati sono sovrani e quindi possono fare quello che vogliono con i loro cittadini. Se si tratta di massacrare cittadini altrui è un’altra storia, ma i cittadini per il loro stato sono come le galline per il contadino. Questa l’espressione che usò.
Tali considerazioni spinsero Lemkin ad approfondire quello che era un fenomeno che lui percepiva come inedito. Questo è uno dei nodi fondamentali: non parliamo solo di un concetto, ma proprio di una realtà nuova. Lemkin infatti intuì che il genocidio non era semplicemente un massacro più grande; c’era l’intenzione del genocidario di sterminare un gruppo e questo costituiva un crimine nuovo.
Si potrebbe obiettare che nella storia ci sono sempre stati massacri, però se vai a leggere i resoconti dei massacri fatti da Tacito o nella Storia segreta dei mongoli o nella descrizione della Caduta di Costantinopoli nelle parole di Enea Silvio Piccolomini, ecc., tutti presentano un elemento comune: la violenza dura per un certo periodo e poi finisce. Perché con il passare del tempo, quando il desiderio di far del male ad altri viene saziato, se rimangono dei sopravvissuti, la reazione è di lasciarli stare. Ecco, per i genocidari è l’opposto: spesso loro non provano alcun piacere. In Rwanda, un genocidario mi ha detto: “Sa, signore, l’uomo è un grande animale, ci vuole molta forza per ucciderlo e anche per continuare a farlo, giorno dopo giorno... Però -aggiungeva- io sono una persona seria, non posso tirarmi indietro mentre gli altri portano a termine il loro lavoro”.
Questa è una dinamica che ritroviamo anche nel grande libro di Christopher Browning, Ordinary Men. Gli “uomini comuni” di Browning erano padri di famiglia, gente adulta, non certo giovani in preda al testosterone, e però anche loro si sono messi a uccidere quando hanno ricevuto l’ordine.
Qui bisognerebbe anche ricordare che nessuno nelle forze armate tedesche è stato seriamente punito per aver rifiutato di partecipare al genocidio e anche questo è interessante.
Allora, il genocidario è una persona mossa, non dal piacere di fare del male agli altri, che è la motivazione dei massacratori, ma dalla visione di un mondo migliore da conquistare grazie alla sparizione del gruppo “nocivo”, che va dunque eliminato per la felicità degli altri.
Ecco, Lemkin ha avuto questa intuizione. In un primo tempo ha lavorato all’idea di “vandalismo e barbarie” e nel formulare una definizione -siamo ancora negli anni Trenta- già si concentrava su come convincere l’umanità che un tale crimine andava contrastato. Lui, tra l’altro sottolineava come, per certi versi, fossimo tutti vittime di quel crimine, perché le vittime immediate perdono la vita, ma l’umanità perde la possibilità di approfittare della loro creatività. Parlando degli armeni diceva: quanti compositori, quanti poeti, quanti filosofi abbiamo perso perché i turchi hanno sterminato questo popolo? Insomma, c’era questa tesi che i nostri stessi interessi fossero in gioco.
Inizialmente Lemkin voleva presentare questa sua idea di un nuovo crimine a un congresso internazionale di diritto tenutosi a Madrid nel 1934; era nella delegazione polacca, ma all’ultimo momento il governo lo fece desistere per paura che questa nuova formulazione potesse irritare i vicini occidentali con i quali la Polonia voleva avere buone relazioni.
Lui però continuò a lavorare; tenne anche dei corsi di diritto privato a Varsavia; la mia mamma ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!