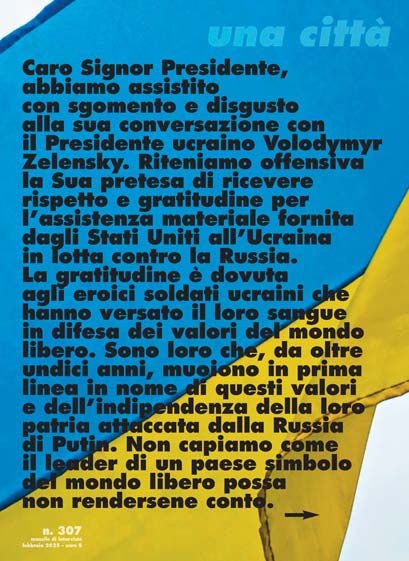Pino è entrato vivo in questura e ne è uscito morto. Voglio sapere il perché’”. Così, con la semplicità asciutta del grande cronista, Giampaolo Pansa ricordava questa donna straordinaria che dal 12 dicembre 1969, dopo la strage di piazza Fontana, vide la propria vita trasformata in un tragico labirinto, nel quale fu introdotta da turpi tresche delle istituzioni e da menzogne inverosimili, indegne di una paese civile. Con un coraggio e una determinazione esemplare cercò di testimoniare la sua fiducia nell’innocenza del marito e nella verità.
Licia Rognini Pinelli è mancata il 12 novembre dello scorso anno. Un mese dopo, nell’anniversario della orribile strage in piazza Fontana, davanti a centinaia di persone, il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva annunciato alla città la decisione di onorarla conferendole l’Ambrogino d’oro alla memoria, commentando: “è un riconoscimento e un doveroso plauso di Milano a una donna coraggiosa e tenace che ha difeso e onorato la memoria di suo marito Pino, trasformando il dolore in un impegno di testimonianza e di lotta per la giustizia e la verità”.
La motivazione del riconoscimento civico spiega: “Trovatasi protagonista, suo malgrado, di una vicenda drammaticamente centrale nella storia della città di Milano e del nostro Paese, è stata capace di trasformare il dolore per la perdita del marito Giuseppe ‘Pino’ Pinelli in una grande battaglia per la giustizia e la verità, per la convivenza civile e la dignità. Fin dalla sua morte, avvenuta presso la questura cittadina il 15 dicembre 1969, ha mostrato un coraggio non comune nell’affermazione dell’innocenza del marito, riconosciuta dallo Stato soltanto molti anni dopo.
Ha portato avanti il suo impegno lontana da qualsiasi istinto di vendetta o di rancore, ma sempre lucida, coerente, con un’attenzione costante, collettiva e mai individuale: ogni sua azione era volta non solo a difesa sua e della sua famiglia, ma a difesa di tutti. La sua Storia quasi soltanto mia rappresenta un importante esempio di cittadinanza oltre che di profonda umanità. Milano è grata a Licia Rognini Pinelli, donna coraggiosa, forte, capace di fare del suo dolore una missione di impegno civile, animata da un grande senso delle istituzioni che ha guidato la sua domanda di giustizia, rimasta priva delle sufficienti risposte”.
La citazione “Una storia quasi soltanto mia” deriva dal titolo del volume edito da Feltrinelli nel quale con l’aiuto del giornalista Piero Scaramucci, già militante di Lotta Continua, Licia Pinelli racconta, con soavità poetica, gli anni felici del suo matrimonio e con tragica determinazione la vita di una famiglia divorata nel buio dei torbidi della ragion di Stato, dai quali cerca di uscire con dignità.
Si erano conosciuti alla scuola di esperanto: credevano in una lingua universale. Era il 1952. “Se gli uomini si fossero potuti conoscere non avrebbero fatto tutte le schifoserie che fanno”, questo il programma della loro vita da innamorati.
Licia conosce Pino, un bravo ragazzo, lo giudica “un po’ piccolino. Era gradevole, anche bello, era solo un po’ piccolino, quel giorno era in maniche di camicia, la volta dopo si è messo l’abito blu. Anche gli uomini sono vanitosi. Ma io sono più attratta da quel che dicono le persone, che da come si presentano. Anch’egli pensava di cambiare il mondo attraverso l’esperanto; ma parlava in modo più articolato, più profondo, più concreto. La sua visione era più utopica. Mi piaceva il suo modo di dire e poi tartagliava. Io facevo la commessa, lui era disoccupato. Ci aspettavamo tutte le sere e facevamo a piedi via Manzoni fino a viale Monza. Qua ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!