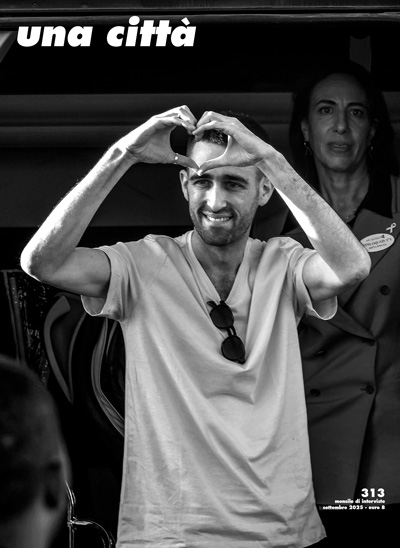Singolare figura di intellettuale e di scrittore, quella di Nicola Chiaromonte (1905-1972). Tanto singolare e anomala da essere stata ignorata quasi del tutto nella cultura italiana sia politica che letteraria del Novecento, e proprio nei decenni, dal 1930 al 1970, nei quali la lettura dei suoi articoli e saggi sarebbe stata più utile e necessaria. Del resto Chiaromonte non visse molto in Italia. Emigrò nel 1934 a Parigi, dove conobbe Albert Camus, di cui restò amico, e dove fu in contatto con i fratelli Rosselli e il loro gruppo di Giustizia e Libertà. Conobbe presto Andrea Caffi, che considerò suo maestro. Durante la guerra civile spagnola del 1936-’39 combatté nella squadriglia aerea organizzata da André Malraux. Nel 1941, a Casablanca, incontrò Garosci e Valiani. Partì poco dopo per gli Stati Uniti, dove frequentò Gaetano Salvemini e collaborò con Dwight Macdonald e le sue riviste “Partisan Review” e “politics”, per le quali scrivevano anche Hannah Arendt e Charles W. Mills. Tornato in Italia, fu a fianco di Ignazio Silone nell’ultimo decennio della sua vita, dirigendo la rivista “Tempo Presente”. Letterariamente ammirevoli le sue recensioni teatrali raccolte nel volume La situazione drammatica (1960). Ora il Meridiano Mondadori Lo spettatore critico (2021), a cura di Raffaele Manica, è per ogni aspetto esauriente.
Modello esemplare di saggista e giornalista sempre ai più alti livelli per originalità di pensiero e chiarezza di stile, Chiaromonte è stato un filosofo dell’attualità che ha cominciato a ricevere l’attenzione da sempre meritata solo a fine Novecento. Tra i suoi saggi migliori e più rappresentativi c’è La situazione di massa e i valori nobili (1956). Chiaromonte apre il suo discorso con una citazione di Ortega y Gasset tratta dal suo famoso libro La rivolta delle masse uscito nel 1930. Dice Ortega: “Per l’uomo massa, vivere significa non incontrare nessun tipo di limite, dunque abbandonarsi tranquillamente a se stesso. Per un tale uomo, non c’è praticamente nulla di impossibile né di pericoloso, e il suo principio primo è che nessuno è superiore a nessun altro”. A un tale tipo di uomo si oppone, secondo Ortega, l’uomo nobile “caratterizzato dalle esigenze che impone a se stesso e non dai diritti che rivendica e si attribuisce”. Mentre l’uomo massa è un “miscuglio di confusione, arroganza e soddisfazione di sé, in contrapposizione Ortega pone “l’ideale classico dell’aristocratico e del filosofo: l’uomo cosciente, ragionevole, libero perché padrone di sé”. Si tratta di un’eredità che deriva da Platone, che è, dice Chiaromonte, “il solo filosofo che abbia dato una definizione rigorosa, anzi, ben più che una definizione, un’immagine limpida, di quell’esigenza intellettuale che noi usiamo vagamente circoscrivere col termine di ‘umanesimo’. La forza dell’ideale platonico viene dal meraviglioso accordo che esso riesce a mantenere fra il dubbio socratico e l’assolutezza delle Idee in sé e per sé, fra l’infinita contingenza delle opinioni e l’incontrovertibile realtà del Vero”.
Ma il libro di Ortega ha, secondo Chiaromonte, un punto debole decisivo: le élites infatti si sono massificate insieme alle masse con l’inizio del Ventesimo secolo:
È comunque evidente che, di per sé, l’avvento delle masse quale lo descrive il grande intellettuale spagnolo non significa la sconfitta di Platone, di Spinoza e di Voltaire, ma sicuramente una crisi radicale della tradizione umanistica sulla quale, fino al 1914, era ancora lecito credere che fosse fondata la vita morale dell’Europa. Il problema delle masse è per l’appunto il problema dell’impotenza, reale o apparente, dell’intellettuale e dell’educatore nella società di massa.
(tutte le citazioni vengono da Lo spettatore critico, Meridiani Mondadori 2021, pp. 307-334)
Riprendendo una considerazione di Hannah Arendt, viene stabilita un’ulteriore interruzione nella storia e nel pensiero politico. Mentre quello tradizionale ha inizio con Platone e Aristotele, quello moderno nasce con Marx, “secondo il quale la filosofia e la verità, lungi dal trovarsi fuori dagli affari umani e dal mondo reale, sono situate precisamente dentro di essi, e non possono essere realizzate che nella sfera della vita collettiva, mediante la formazione dell’uomo socializzato”:
Per Marx, l’intellettuale ha l’obbligo di non pensare che dei pensieri di tal sorta: dei pensieri efficaci. Quello che, insomma, Marx dice è che il filosofo non è filosofo se non in quanto egli pensa con la massa, e nell’interesse della massa, dei pensieri i quali siano, oltre che pensieri, anche azioni possibili [...]. Non bisogna pensare la verità, bisogna pensare la situazione sociale presente [...]. Marx giunse a tali conseguenze in nome dell’umanità reale: della collettività e, bisogna pur dirlo, delle masse [...]. Fino al momento in cui l’umanità non sia integralmente liberata, non ci saranno veramente degli individui, ma solo delle classi, delle forze e dei numeri: da una parte il piccolo numero degli sfruttatori, dall’altra il gran numero degli sfruttati. Fra queste due forze non c’è nulla [...]. Quel che secondo Marx distingue le masse e caratterizza la situazione sociale in cui esse diventano il fatto dominante è lo stato di necessità. Questa situazione, l’intellettuale non ha il diritto d’ignorarla: per essere degno della sua missione egli dovrà anzi farsi una coscienza di massa [...]. Il che si può anche esprimere dicendo che, secondo Marx, l’intellettuale non pensa nulla se non pensa la situazione storica.
Ora, lo stato di necessità in cui si trova l’individuo nell’era dell’industrialismo e dell’organizzazione Marx non l’ha certo inventato [...]. Hannah Arendt ha ragione di dire che, rovesciando radicalmente il rapporto classico fra il pensiero e l’azione, Marx ha segnato la fine di una tradizione, annunziando una crisi che ancora dura e che è, in primo luogo, la crisi della cultura e dei “valori nobili” nel mondo contemporaneo.
Ma dall’Ottocento in poi democrazia e società di massa diventano sinonimi, il che significa che l’una e l’altra non appaiono più criticabili. Questo complica le cose:
Ai giorni nostri, il macchinismo, la burocrazia, la complessità crescente della tecnica, la specializzazione scientifica, mentre da una parte sono fenomeni tipici della società di massa, dall’altra sembrano esautorare non solo l’individuo, ma anche il principio democratico della maggioranza, a favore di un’oligarchia di specialisti e, al tempo stesso, di un anonimo principio di organizzazione e di disciplina. L’ideale collettivo più razionale dell’epoca moderna, il socialismo “iperdemocratico”, sembra -e non da oggi- condurre necessariamente a una società autoritaria e gerarchica.
L’impulso egualitario porta a quello Stato “iperdemocratico” che provoca la subordinazione degli individui, poiché “oggi, l’entità in nome della quale si governa è sempre il Demos: il gran numero, tutti, cioè la Massa”. Il richiamo ai valori significa “richiamarsi al patrimonio culturale [...] alla tradizione ellenica, umanistica, razionalistica” che ha formato gli intellettuali, la cui funzione è di apprezzare ciò che c’è di meglio. Il problema non è quello storico del “rapporto fra la paideia platonica e la praxis marxista” quanto invece il fatto che ormai i valori della tradizione culturale sembra che non abbiano più potere, come può succedere a ogni e qualunque classe politica dirigente.
I valori nobili sono una certa idea di passato che crea negli individui intellettuali una particolare situazione di coscienza in una situazione storica di massa che provoca quella “degradazione dei valori” che chiamiamo nichilismo. In una situazione di massa nella quale “trovare posto” ha cominciato a essere un problema di tutti i giorni, è una comune esperienza di angoscia e di esclusione. Questa situazione riguarda sia l’intellettuale più raffinato che il più modesto operaio. A questa necessità o servitù materiale non ci si può più sottrarre: “Isolarsi, in verità, non si può che in compagnia: per iniziare una rivolta, o per fondare una comunità. L’uomo solo può essere un esempio solenne o terribile; ma è sempre un mostro”. E c’è da chiedersi “se colui il quale esce dalla folla dopo esservisi confuso sia davvero il medesimo individuo”. L’esperienza della folla non rende soltanto tutti uguali ma tutti intercambiabili.
L’impotenza sociale degli intellettuali e della cultura di cui sono eredi e memori, è nell’essere un fatto di coscienza personale e non di esperienza comune, quotidiana e di massa:
Se, nella società in cui viviamo, predominano le condizioni e i rapporti di massa, ciò non può non avere conseguenze sull’immagine del mondo e dei rapporti umani che noi tutti ci formiamo vivendo, e quindi sulla maggiore o minore efficacia dei valori nobili nella vita collettiva [...]. Vivere in una società di massa significa compiere automaticamente, e per la maggior parte del tempo, degli atti non liberi, facendo quel che si fa non perché sia naturale, e neppure perché lo si ritenga positivamente utile, ma piuttosto per evitare le complicazioni e i mali che verrebbero (a sé e agli altri) dall’agire diversamente [...]. Dal punto di vista della coscienza è l’esperienza di un disordine retto da leggi di ferro.
Si agisce in un certo modo perché non se ne può fare a meno. Fra gli individui in una situazione di massa non c’è posto per valori nobili, cioè nati dalla migliore cultura:
Come è possibile leggere Kant o praticare la saggezza e la virtù epicurea, cristiana o buddista, in mezzo alla folla? Evidentemente non c’è una maniera cristiana di lavorare al tornio, o un modo umanistico di viaggiare in un treno affollato. Nella situazione moderna e nella società di massa i valori cristiani o umanistici sono sospesi.
Il problema che Chiaromonte in questo saggio lasciava in eredità all’intellettuale critico o impegnato in un secolo come il Novecento tra fascismi, comunismi e democrazie di massa, è un’etica sia platonica che stoica di individui che di fatto sono politicamente irrilevanti e socialmente scettici (“dalla caverna platonica non si esce in massa, ma solo uno per uno”).
Questa la tirannia moderna con il suo avvenirismo tecnocratico sia capitalistico che socialista, con persuasori occulti in attività, idee prefabbricate e burocrazia elettronica: è chiaro che partendo da un tale punto di vista non si arriverà mai all’“individuo autonomo”. Nessuna coscienza individuale, infatti, può essere compensata o sostituita da propagande ideologiche.
Chiaromonte giornalista filosofo
di letteratura e altro

Una Città n° 310 / 2025 maggio-giugno
Articolo di Alfonso Berardinelli
Chiaromonte giornalista filosofo
di Alfonso Berardinelli
Archivio
BASTA CON AMLETO
Una Città n° 106 / 2002 Agosto-Settembre
Realizzata da Franco Melandri, Gianni Saporetti
Realizzata da Franco Melandri, Gianni Saporetti
Alfonso Berardinelli, critico letterario e saggista, recentemente ha pubblicato: Stili dell’estremismo (Editori Riuniti), Cactus (ed L’ancora), Nel paese dei balocchi, (ed. Donzelli), La forma del saggio (Marsilio).Uno dei principali obiettivi polemici de...
Leggi di più
E TU A COSA SERVI?
Una Città n° 116 / 2003 Ottobre
Realizzata da Katia Alesiano, Franco Melandri
Realizzata da Katia Alesiano, Franco Melandri
Alfonso Berardinelli, critico letterario e saggista, recentemente ha pubblicato: Stili dell’estremismo (Editori Riuniti), Cactus (ed L’ancora), Nel paese dei balocchi, (ed. Donzelli), La forma del saggio (Marsilio).Di che cosa parliamo quando parliamo di ...
Leggi di più
COSE FATTE, SEMPLICEMENTE
Una Città n° 27 / 1993 Novembre
Realizzata da Franco Melandri
Realizzata da Franco Melandri
L’attuale crisi italiana ripropone la discussione fra chi vede nella politica solo l’ambito della mediazione e chi invece ritiene che essa debba anche indicare scopi generali o modelli di società... Direi innanzitutto che oggi, come venti o trenta anni fa...
Leggi di più
LA VARIETA’ DEL REALE
Una Città n° 35 / 1994 Ottobre
Realizzata da Rocco Ronchi, Franco Melandri
Realizzata da Rocco Ronchi, Franco Melandri
Nel suo ultimo libro lei sostiene che è in crisi l’autocomprensione che la pratica poetica ha avuto di se stessa nella modernità e quindi è necessario che la poesia si riapra, che ritrovi uno spazio comunicativo. Ma cosa vuol dire che la poesia, e la lett...
Leggi di più
Auden e il suo sguardo da fuori
Una Città n° 309 / 2025 aprile
Autorevole guida di un gruppo di giovani poeti fin da quando era studente a Oxford, Wystan H. Auden (1907-1973) è stato il poeta e intellettuale più precocemente esemplare nella letteratura inglese degli anni Trenta. Fin dall’inizio de...
Leggi di più