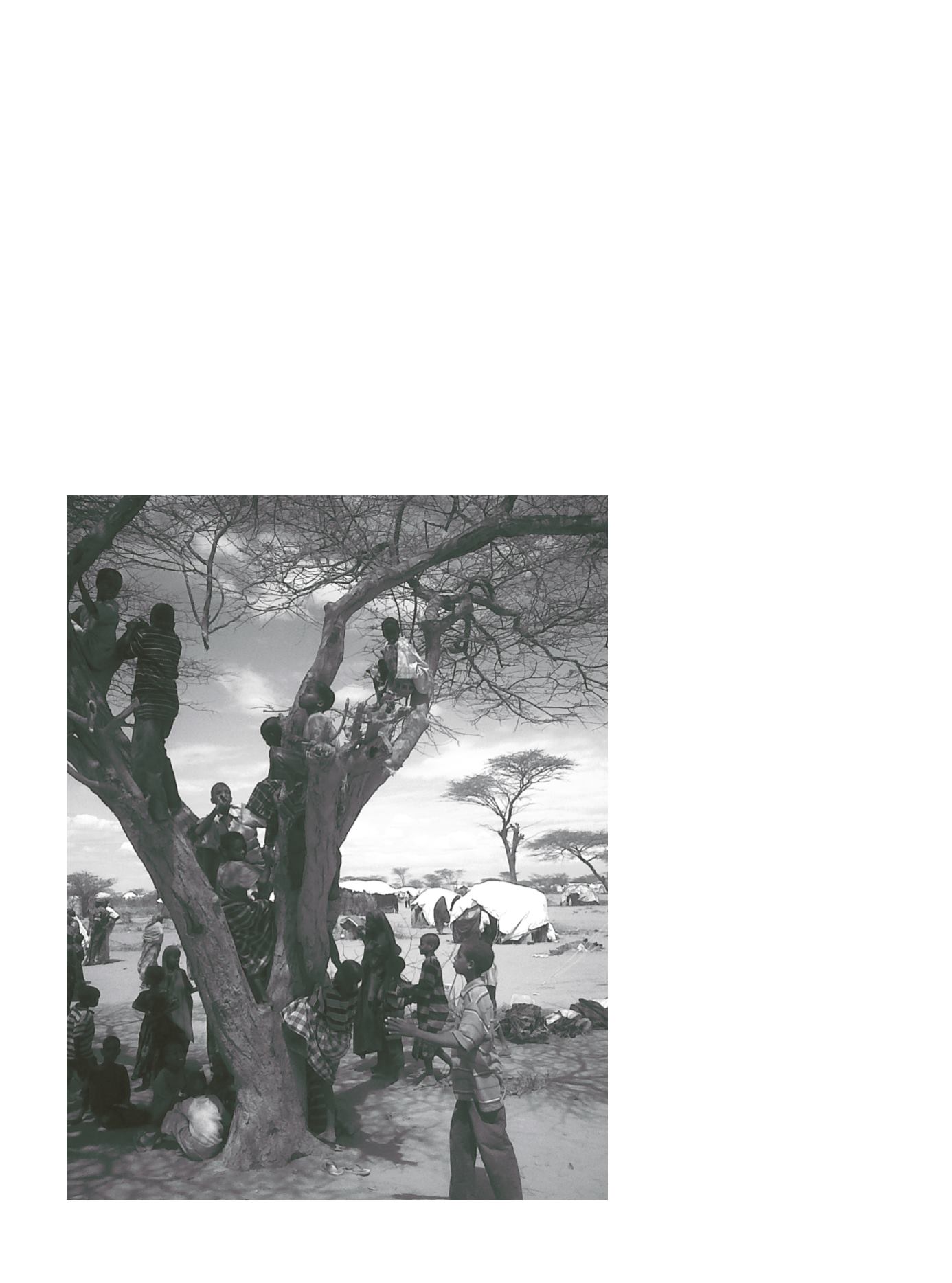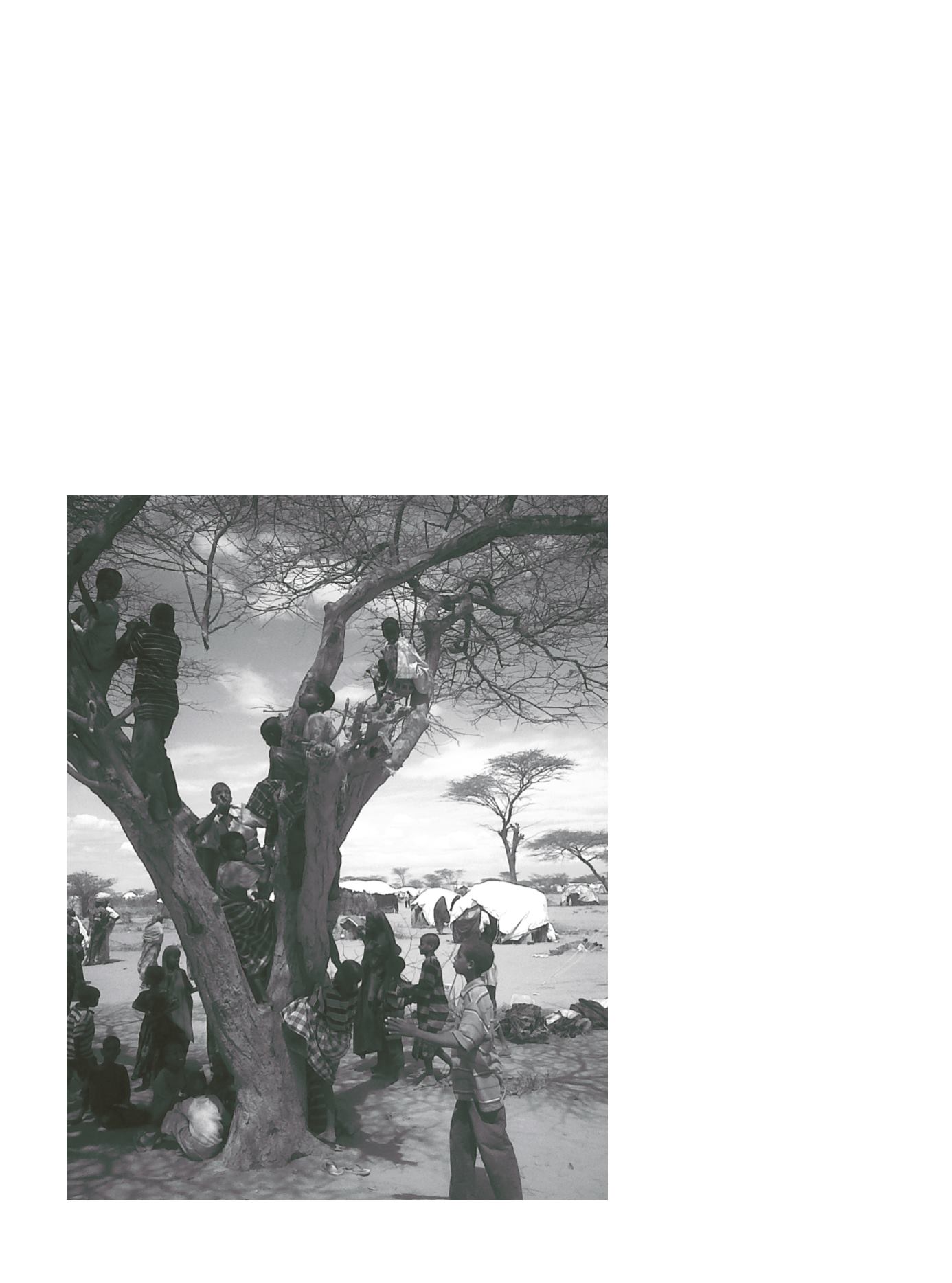
10
gioni profonde di una divisione che in Rwan-
da è stata politica prima che etnica significa
non disconoscerne la complessità storica che
è strettamente intrecciata con la storia della
decolonizzazione del Congo e della sua re-
gione orientale, il Kivu.
Se andiamo a vedere altri campi di rifu-
giati presenti nelle zone sensibili, nel Sud
Sudan, nella Repubblica Centrafricana e in
Africa Occidentale, in Costa d’Avorio, Li-
beria, Sierra Leone, Guinea Conacry, ecc.,
riscontriamo le stesse dinamiche. Il proble-
ma non è tanto o solo la scarsezza di mezzi
materiali, ma la mancanza di sensibilità,
nei governi locali e negli organismi interna-
zionali. Per questo ripeto che è imperativo
trattare i rifugiati come soggetti portatori di
diritti universali, soprattutto qui nella ricca
e sviluppata Europa dove la presunta man-
canza di mezzi spinge a ghettizzare rifugiati
e migranti e a trattarli come “altri” diversi,
privati anche del diritto di essere ascoltati.
Scontri etnici e interessi di potere
I conflitti in Africa vengono invariabilmente
fatti risalire ad animosità di carattere etni-
co, senza considerare che alla radice degli
scontri etnici c’è la gestione del potere, le
eredità delle divisioni, gerarchie e memorie
storiche, l’affermarsi di interessi egemonici
della decolonizzazione e dall’indipendenza
in poi, in cui s’intrecciano interessi, interna-
zionali e interni a ciascun contesto.
La testimonianza di Yolande Mukagasana
ci svela che l’identità etnica esiste come
portato di storie familiari, sociali, politiche,
ma nello stesso tempo è qualcosa che si co-
struisce a seconda delle congiunture sociali
e politiche. Dietro questa costruzione c’è la
competizione per il potere, e contestualmen-
te c’è la negazione dell’altro come persona.
Questo discorso riguarda anche, e direi so-
prattutto, il migrante. Noi italiani, proprio
per la nostra storia, dovremmo capirlo più
di ogni altra nazione-etnia. La gestione dei
campi rifugiati, così come la gestione dell’ac-
coglienza, dovrebbe ripartire da questa con-
sapevolezza. Come stiamo facendo in questi
giorni qui a Bolzano nel contesto del premio
della Fondazione Alexander Langer dovrem-
mo mettere le persone insieme a raccontare,
a discutere, confrontandoci criticamente con
la riproduzione di reciproci stereotipi, pre-
giudizi, preconcetti; con franchezza, quindi
smontando le teorie complottiste, escluden-
ti, perché quello è il discorso del potere. Par-
lare, parlarci per capire e capirci, pone dei
problemi ovunque e tanto più in Italia dove
generalmente c’è una scarsissima conoscen-
za dell’Africa e le sue problematiche.
L’Africa è un continente di circa un miliar-
do di abitanti, perlopiù giovani, che proba-
bilmente saranno due miliardi nel 2050, e
rappresenta il 60% delle terre ancora non
coltivate e oltre un terzo delle ricchezze mi-
nerarie mondiali.
L’Africa non è, come troppo spesso si rap-
presenta, un antiquato museo di tribù e
etnie, di tradizioni obsolete, ma un mondo
in ebollizione che sta assistendo a rapide e
traumatiche trasformazioni, un mondo ricco
di talento culturale, dall’enorme e diversifi-
cata vivacità, musicale, artistica. L’Africa è
anche la diaspora sparsa in tutto il mondo.
Rifugiati ambientali
Un altro elemento importantissimo e spesso
dimenticato è che molti dei rifugiati dell’A-
frica sono rifugiati ambientali, scampati
e sopravvissuti a grandissimi disastri am-
bientali, perché l’ Africa, fra l’equatore e i
due tropici, ha una natura estrema, molto
difficile e crudele. Anche la rinnovata cor-
sa ad appropriarsi e sfruttare le ricchezze
naturali di questo continente (foreste, terre,
miniere, acqua) sta mettendo in pericolo la
stabilità ambientale. Il cambiamento clima-
tico a sua volta ha creato disastri, alluvioni
alternate a devastanti siccità che si ripetono
in cicli sempre più riavvicinati. Da ultimo
si dibatte su un fenomeno qui poco valu-
tato ovvero l’acqua. I paesi arabi desertici,
casseforti di petrodollari, nella Rift Valley,
stanno comprando territori che sono veri e
propri serbatoi di acqua.
Yolande ha parlato del fatto che in Rwanda
è stata introdotta la proprietà privata della
terra. Il Rwanda è un paese povero, non ha
grande risorse, produce caffè, tè, pochissi-
mo altro. Anche altri paesi hanno adottato
nuove leggi di riforma della terra, e ovunque
si tenta di equilibrare il discorso della pro-
prietà privata con il mantenimento di pro-
prietà di tipo comunitario, con risultati con-
troversi. Di fatto chi ha il potere riesce ad
appropriarsi di aree o di territori che hanno
un forte valore, non solo agricolo. Continue
sono le denunce di abusi e numerose le pro-
teste e i conflitti sulla gestione delle riforme
dello statuto della terra. Popolazioni senza
altra risorsa che la terra, nel contesto del-
le politiche di liberalizzazione in auge dagli
anni Ottanta-Novanta, sono messe di fronte
a un’accelerazione della commercializzazio-
ne delle risorse naturali. Dal 2000 il tasso
e i ritmi dei trasferimenti del possesso o
proprietà della terra hanno visto un’acce-
lerazione: si tratta di trasferimenti non
sempre volontari, non sempre trasparenti.
Nelle comunità contadine la perdita del-
la terra implica la perdita dei fondamenti
della sopravvivenza anche perché sono po-
che le alternative sul mercato del lavoro.
La privazione è ancora più significativa se
Dadaab, campo profughi del Kenya