Da anni, città, università, scuole di eccellenza e istituti scolastici di Pisa ricordano l’infamia commessa quel giorno, 5 settembre del lontano 1938, nella Villa Reale di San Rossore. La sigla da parte di Vittorio Emanuele III dei “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”, progettati da Mussolini e dai suoi ministri Bottai e Di Revel: primo dei numerosi decreti fascisti che avviarono la persecuzione degli italiani ebrei (e degli ebrei stranieri) e premessa della loro deportazione e sterminio durante la Seconda guerra mondiale.
Alla conoscenza e alla coscienza storica dell’antisemitismo nella storia d’Europa e d’Italia ho cercato di dare per anni il mio contributo, con saggi, lezioni, incontri nell’ateneo e nella Sns di Pisa, come in tante università italiane, francesi, americane, israeliane, palestinesi. Alla riflessione storica ed etica sul 5 settembre 1938, in particolare, ho dedicato la mia presenza nel Comitato Scientifico San Rossore 1938, che organizzò la commemorazione di tutti gli atenei nazionali per l’ottantesimo dei Provvedimenti, nel 2018. È per ragioni di mestiere di storico, dunque, che ho qualche titolo per chiedermi e chiedere: quale funzione possiamo attribuire oggi alla memoria della persecuzione e dello sterminio degli ebrei d’Europa; oggi, cioè, dopo il 7 ottobre 2023, con la guerra di sterminio in corso a Gaza? La coscienza storica si forma nel dialogo tra memoria e storia e s’impegna prima di tutto nella difesa dalle falsificazioni e dall’oblio, ma dev’essere anche monito contro la possibile ripetizione della catastrofe (Primo Levi: è accaduto, può ancora accadere, e non solo agli ebrei).
È accaduto, in Israele, in Palestina. Il massacro del 7 ottobre perpetrato da Hamas mirava tatticamente a distruggere -in sinergia con ayatollah iraniani, huthi yemeniti, hezbollah libanesi- ogni possibile compromesso per la convivenza tra israeliani e palestinesi, come quelli che, a partire dagli anni Novanta, si sono ispirati al paradigma degli accordi di Oslo, sino ai Patti di Abramo. Più oltre, l’obiettivo strategico di Hamas era, dichiaratamente, la distruzione di Israele. Così la strage di ebrei più tragica dopo la Shoah è stata percepita come il ritorno di questa: è accaduto, può ancora accadere.
Ma la risposta militare del governo Netanyahu si è tradotta, a Gaza, in guerra di sterminio ai civili: bombardamenti indiscriminati, fame, sete, deportazione e pulizia etnica. Ufficiali e comandanti israeliani hanno affermato a più riprese che l’esercito avrebbe potuto adottare una condotta profondamente diversa, mentre invece i rappresentanti nel governo dei partiti nazionalisti di destra e religiosi hanno tramutato la politica dei coloni in Cisgiordania in ragion di Stato, legittimando razzie e pogrom.
Liliana Segre ha senza ombra di dubbio tutta l’autorità per definire genocidio una parola malata -qualsiasi cosa ne pensi Francesca Albanese; David Grossman, e gli storici Omer Bartov e Amos Golberg l’hanno invece evocata, quella parola. L’unicità dello sterminio nazista non impedisce certo il confronto storico con altri genocidi, come il Medz Yeghem degli armeni, il Porrajomos di Rom e Sinti, l’Holodomor degli ucraini. Ognuno si rivolga al proprio tribunale, ma nessun tribunale delle parole potrà pronunciare una sentenza univoca. E, con un libro coraggioso, Anna Foa ci avverte: massacri ed estirpazione dei palestinesi dalla loro terra non tutelano la sicurezza di Israele, sono anzi la premessa di un suicidio, e Israele, agendo così contro i palestinesi, agisce in realtà contro se stesso e contro l’ebraismo, perché sollecita un antisemitismo antico, mai sopito.
E distrugge le basi della memoria, dunque di uno dei pilastri della coscienza storica, aggiungo io. La storia non può che essere sempre ripensata dalle radici, e con essa devono essere ripensate le radici e i fini della conoscenza storica. E le radici di questa storia affondano nell’occupazione di Gerusalemme Est, Gaza, Cisgiordania, Golan e Sinai (questi poi restituiti) con la guerra del 1967 contro la coalizione degli Stati arabi. Con la scelta di mantenere negli anni successivi l’occupazione, la “questione palestinese” non è mai stata superata o risolta ma, anzi, è stata inglobata all’interno di Israele.
La “questione palestinese” è da decenni una questione interna e costitutiva dello Stato d’Israele. Yeshayahu Leibowitz, l’eminente studioso israeliano, fu profeta di tale sventura: il nuovo colonialismo nazionalista, che egli definì l’“idolatria del terra”, avrebbe “corrotto” Israele. Oggi l’annessione di Gaza o di una sua parte, e l’espulsione dei palestinesi, potrebbero sprofondare Israele nell’abisso: la patologia cronica di conflitti continuati per decenni e degenerati nel duello tra nazionalismo islamista e nazionalismo coloniale, -quello che Amos Oz definì “the Hamas-Likud Connection”- potrebbe esplodere in una doppia catastrofe terminale, palestinese ed ebraica.
Impensabile che la catastrofe non coinvolga anche la coscienza storica della Shoah. Questo è il punto che a me oggi preme. La coscienza storica della persecuzione è fatta di studi, ricerche, istituzioni internazionali dedicate alla cooperazione pedagogica, come di una memoria corroborata da occasioni pubbliche incardinate sulla Giornata dedicata, musei straordinari (come a Berlino), una filmografia imponente ed eccellente, ma anche documenti discutibili come la Dichiarazione di Stoccolma, poi Ihra. Anch’essa, la memoria, tuttavia, ha una sua duplicità. Esiste una memoria che dialoga con la conoscenza storica della natura dello sterminio nazista, che fu al tempo stesso l’intenzione originaria hitleriana e risultato ultimo dell’antisemitismo, ma anche una conseguenza funzionale della guerra totale dei fascismi: tale memoria è quella ispirata alla democrazia e all’universalismo dei diritti. Esiste però anche un’altra memoria, affidata soprattutto all’empatia con le vittime e con Israele, in quanto Stato delle vittime sopravvissute: una memoria con la quale, dal processo Eichmann in poi, lo Stato di Israele ha radicato la propria legittimità solo nella tragedia europea del genocidio, e spesso obliando le tradizioni illuministiche della diaspora e modificando inesorabilmente anche il progetto dei pionieri sionisti e socialisti (nella stessa diaspora, in Europa e in Usa, la memoria è talvolta considerata soprattutto memoria privata, nazionale).
Tra Otto e Novecento, invece, intellettuali e politici democratici europei ebrei -Lévy in Alsazia, Kuranda in Boemia, Horn a Budapest, Lasker a Berlino, Jacoby a Francoforte- si erano sempre impegnati non solo nella conquista dei diritti civili e politici per gli ebrei, ma anche per i diritti di autodeterminazione nazionale e per le libertà costituzionali di tutti i gruppi religiosi e nazionali oppressi: cristiani libanesi, cattolici irlandesi, polacchi, italiani. Difesa particolare delle comunità ebraiche e universalismo dei diritti erano per loro la stessa cosa.
L’istituzione della Giornata Internazionale della Memoria del 27 gennaio, con la risoluzione Onu del 2005, si fonda su questa tradizione dell’universalismo dei diritti e afferma una concezione della memoria fondata sulla realtà storica e sulla Dichiarazione Universale dei Diritti del 1948, che della Shoah fu la prima presa di coscienza. La dichiarazione dell’International Holocaust Remembrance Alliance (2020) rischia invece di ridurre la definizione dell’antisemitismo a un meccanismo di protezione da qualsiasi critica delle politiche dei governi israeliani, anche di quelle sospettabili di apartheid, con il rischio di una eterogenesi dei fini, cioè che la storia di Israele venga assimilata a un capitolo del colonialismo, come avviene in alcuni degli studi post-coloniali, o ne esca legittimata una sua versione ideologica estrema, come lo fu nei testi della Conferenza di Durban del 2001. In ogni caso, la concezione universalistica della memoria della Shoah ne viene comunque compromessa.
Nel corso della guerra del Libano (1982), Amos Oz scrisse al premier Begin e al ministro Sharon: “Hitler ha assassinato un terzo del popolo ebraico, ma decine di migliaia di arabi morti non guariranno mai questa ferita”. Se il 7 ottobre di Hamas viene presentato come l’avvio della nuova Shoah, la guerra contro Hamas può essere allora presentata come la nuova guerra antinazista. Golda Meir disse che chi bombardò Dresda (300.000 tedeschi bruciati in una notte) non poteva dire agli israeliani come condursi in guerra. Forse aveva una sua ragione, ma se tale guerra diventa essa stessa una guerra di sterminio, il suo accostamento ad altri stermini diventa difficile da evitare. Esiste una cesura nella storia, dopo Hiroshima (e Dresda), e dopo Auschwitz, ma può non rimanere la sola. La distinzione tra la Shoah e gli altri genocidi della storia rimane cruciale, ma la condotta di governo ed esercito a Gaza fan correre il rischio che, lentamente e inesorabilmente, si dissolvano tutte le differenze e si frantumi la memoria stessa dello sterminio degli ebrei d’Europa.
Con essa, anche del ricordo di quel miserabile 5 settembre 1938, a San Rossore.
5 settembre 2025
San Rossore 1938. La memoria al tempo di Gaza
discussioni
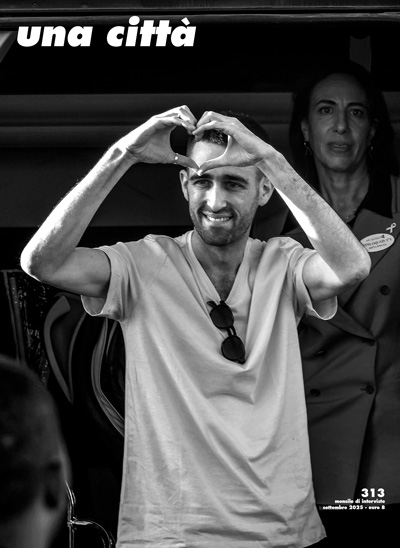
Una Città n° 313 / 2025 settembre
Articolo di Michele Battini
San Rossore 1938. La memoria al tempo di Gaza
Archivio
"IN MANO AGLI EBREI"
Una Città n° 189 / 2011 novembre
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Michele Battini è professore ordinario di Storia Contemporanea e presidente del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici nell’Università di Pisa. è membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza Ferruccio Parri e...
Leggi di più
Ricordo di Tonino Lucarelli (1945-1994)
Una Città n° 304 / 2024 ottobre
I. “Ho l’impressione di aver sempre pensato che sarei andato in mare. Altri sono andati a vivere in campagna, il mare è una gran campagna d’acqua. Fare il pescatore è stata una vera scoperta: la gente pensa che in mare non ...
Leggi di più
Non siamo tutti galileiani
Una Città n° 314 / 2025 ottobre-novembre
Un “caso” illumina la storia plurisecolare dei rapporti conflittuali tra saperi teologici e scientifici, e tra i poteri dall’Antico Regime: quello di Galilei e della sua persecuzione. Lo dimostra perfettamente Massimo Bucciantini in Alla...
Leggi di più
Nervi dei nostri nervi
Una Città n° 305 / 2024 novembre
I. Comporre una ricerca e scriverne il testo a quattro mani può costituire un rischio, e per molte ragioni. Può risultare difficile connettere le rispettive sezioni della ricerca e del libro che ne è risultato; può emergere un ...
Leggi di più
Meditazioni sullo sterminio e sul Giorno della Memoria
Una Città n° 306 / 2024 dicembre 2024-gennaio 2025
Partiamo dalla domanda sempre fondamentale. Come si spiega l’insorgenza dell’antisemitismo di Stato proprio nel 1938, in quel momento della già non breve storia del regime fascista? La decisione persecutoria venne prima adombrata (con u...
Leggi di più


















