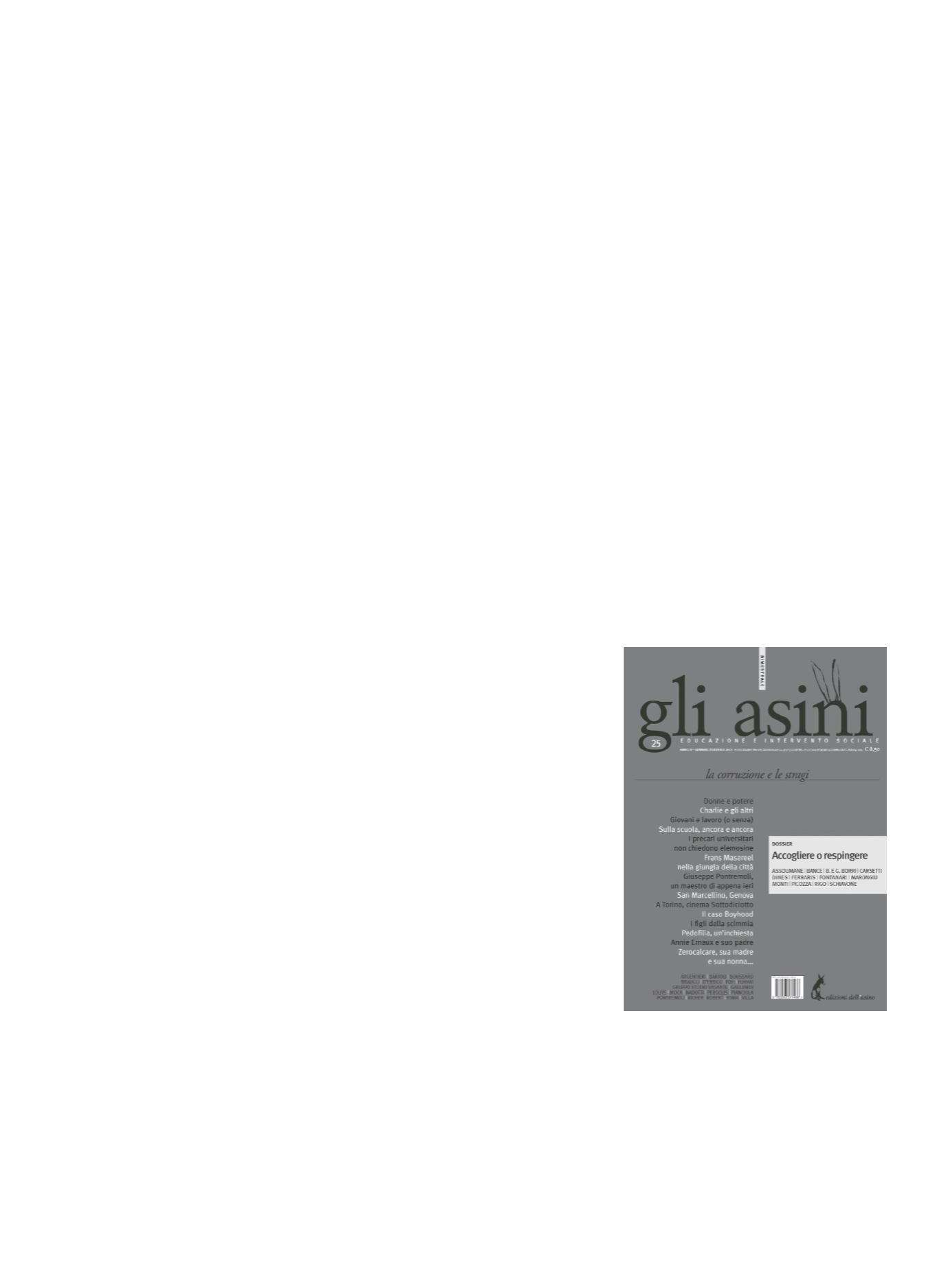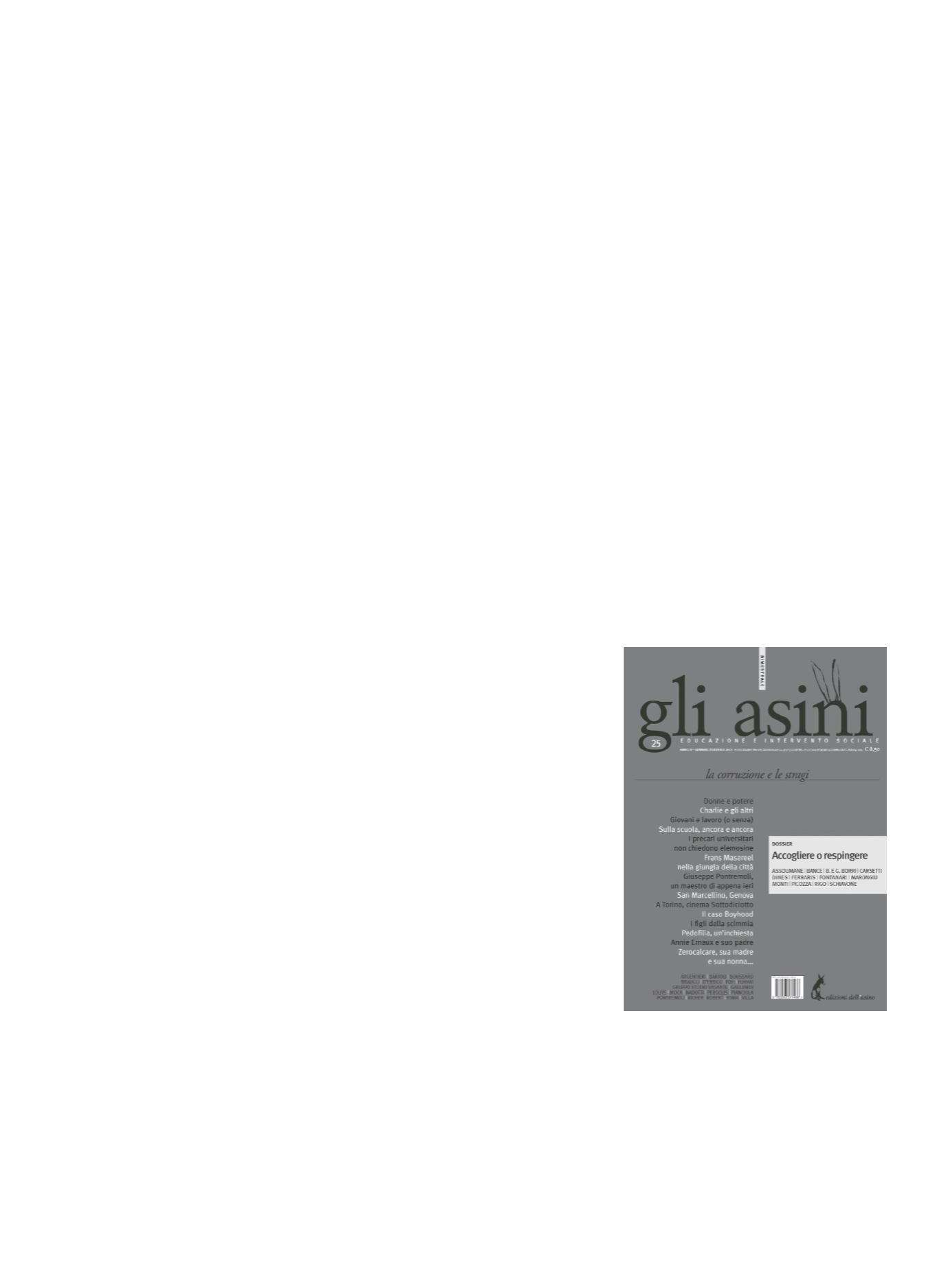
25
Il diritto e la politica
Per capirci qualcosa di più, per farmi un
quadro più preciso, ho iniziato a studiare
il lavoro e le analisi dei gruppi e degli os-
servatori più attenti e attivi che in quegli
anni, come oggi, portavano avanti “proget-
ti antagonisti” nell’ambito delle politiche
migratorie: penso soprattutto agli avvoca-
ti dell’Asgi, agli analisti di Sbilanciamoci!
ai collettivi che ruotano intorno a Melting
Pot, A buon diritto, ecc. E il quadro giuri-
dico e amministrativo mi è risultato presto
molto chiaro: assenza di una legge organica
sull’asilo; una gestione diffusa sul territorio
(uno dei pochi aspetti positivi inaugurati
dall’Ena) ma senza che i territori avessero
preparazione né strumenti operativi ade-
guati; convenzioni stipulate dalla Protezio-
ne civile prima e dalle Prefetture poi con
cani e porci (alberghi, agriturismi, centri di
accoglienza palesemente corrotti o che sono
stati educati alla corruzione durante la ge-
stione emergenziale); il folle inserimento di
tutti i profughi nel percorso della procedura
d’asilo, che ha generato tempi d’attesa lun-
ghissimi e domande di protezione per paesi
(quelli da cui provenivano, non dalla Libia,
dalla Tunisia o dall’Egitto, da cui scappava-
no) in cui magari in quel periodo nemme-
no c’erano condizioni politiche e sociali che
giustificassero qualche forma di protezione
internazionale; l’imprevedibile discrezio-
nalità sommata all’incapacità gestionale di
molte questure italiane, “stati nello stato”,
che al di là dei frequenti episodi di razzismo,
avevano tempi di convocazione e rilascio dei
permessi lunghissimi se non palesemente
“fuorilegge”.
Insomma, un enorme e complicatissimo gro-
viglio di nodi di ordine giuridico e politico.
Per questo, sul fronte delle rivendicazioni,
le poche voci che in quei mesi si levavano
più insistentemente a difesa dei profughi
reclamavano un’accoglienza più lunga, più
soldi, più servizi.
La pedagogia
Ma lentamente i conti hanno iniziato a non
tornarmi. Inutile girarci attorno: raramente
la matrice dei problemi che i miei studenti
portavano a scuola era di ordine giuridico e
direttamente collegabile al razzismo buro-
cratico su cui da allora si è detto e scritto
tantissimo. Certo si potrebbe ammettere
che la bolla di inedia e di attesa usurante
in cui erano avvolte le loro giornate e che
impediva loro di apprendere la lingua ita-
liana dipendesse principalmente dai tempi
imposti dalla legge italiana sull’asilo e da-
gli accordi europei di Dublino, accentuati
dall’estemporaneità del giro di valzer di
decreti e ordinanze emergenziali. Nonché
dall’impossibilità di lavorare e vivere impo-
sta dalla procedura per la richiesta d’asilo:
come altro si impara la lingua, se non viven-
do e lavorando?
Detto questo però i conflitti, quando non
l’aggressività vera e propria, e soprattutto
l’anestesia delle spinte vitali dei miei stu-
denti nigeriani, del loro istinto di sopravvi-
venza, l’annebbiamento della loro capacità
di reagire e di “far da sé” che mi sembrano
gli effetti peggiori che una relazione educa-
tiva possa produrre, mi sono apparsi spesso
inevitabili e messi a sistema dalle relazio-
ni d’aiuto di cui in quel momento erano og-
getto. Non dipendenti principalmente dalla
normativa vigente, né dalla mancanza di
fondi negli interventi programmati, quanto
dagli strumenti e dalla cultura professiona-
le dei loro “assistenti”. Sarebbe a dire di noi
educatori e operatori sociali.
Estremizzo, è evidente, ma molto spesso, di
fronte alla confusione dei miei alunni, alla
loro rassegnazione, alla loro inedia, alle
loro recriminazioni, giustificate o meschine
che fossero, mi ha sfiorato, e con una certa
presa, un pensiero “cattivo”: che se non ci
fosse stata tutta l’impalcatura assistenziale
del programma di aiuto e degli attori che lo
stavano attuando avrebbero avuto molte più
chance di mettere radici, che è quello che
loro avrebbero voluto e che la legge italiana
imponeva loro di fare.
I problemi che i miei studenti nigeriani por-
tavano a scuola erano più prosaicamente
di quest’ordine: la collocazione in territo-
ri molto isolati; la convivenza forzata; una
gestione irrazionale, infantilizzante e assi-
stenzialistica della gamma molto ristretta
di strumenti con cui operatori ed educatori
gestivano la loro quotidianità (il sistema dei
pocket money, ad esempio, o il trasporto,
quasi a uso taxi, con mezzi delle “miseri-
cordie” e delle “croci verdi”); una confusione
primordiale, loro e dei loro “assistenti”, sui
confini precisi del programma di protezione;
l’altrettanto confusa sovrapposizione degli
attori e delle istituzioni in ballo (per i miei
studenti la commissione territoriale, i ser-
vizi sociali, la questura, la prefettura, il co-
mune, la scuola facevano parte di un’unica
confusa nebulosa); la socializzazione al lavo-
ro che aveva più del riempitivo quando non
dello sfruttamento di manodopera gratuita;
infine quel misto di paternalismo, morali-
smo, controllo poliziesco, sistema di premi
e punizioni, insieme seduttivi e autoritari,
che mettevamo in piedi, spesso inconsape-
volmente, noi operatori. Ecco se dovessi dire
quello che di più inguaiava i miei studenti
-anche in vista del momento in cui, finito il
programma di accoglienza, se la sarebbero
dovuta cavare da soli- può essere attinto da
quest’ordine di problemi più che dalla man-
canza di fondi o dalla legge, seppur assur-
da, che regolava e regola il diritto d’asilo in
Italia.
Spreco d’umanità
Chi ha conosciuto e trascorso un po’ di tem-
po, oggi come allora, con profughi e richie-
denti asilo sa che in molti casi la dipenden-
za assistenzialistica e lo spreco d’umanità
in cui sono immersi non sono originati solo
dall’assurdità della legge, italiana ed euro-
pea. La “galera” che quotidianamente co-
struiamo intorno a loro è frutto in buona
misura dei servizi e degli assistenti sociali
che li hanno in carico, degli educatori, del-
le cooperative per cui gli educatori lavora-
no, del meccanismo con cui gli enti pubblici
appaltano alle cooperative la gestione dei
profughi, degli operatori della prefettura,
degli assessori, dei dirigenti… Un esercito
di “brave persone” che continuano a servire
principi astratti e burocrazie amministrati-
ve ormai completamente scollate dalla real-
tà. Accettando in questo modo -ed è questa a
mio avviso l’elemento più gravido di conse-
guenze- la profonda irrazionalità e irrealtà
del loro lavoro.
Dico che è uno degli aspetti più gravidi di
conseguenze perché è a partire dal momen-
to in cui metto a tacere il mio buon senso e
accetto che il mio lavoro sia in regola solo
perché risponde a procedure formali; è a
partire da quel momento che lentamente la
mia intelligenza, il mio senso pratico, le mie
capacità educative cominciano a consumar-
si. E a quel punto anche una buona legge
sull’asilo o trasferimenti finanziari per fare
tante buone cose non serviranno poi a molto.
Morti e zombie
Può suonare molto stonato, a pochi giorni
dal naufragio del peschereccio che, nella
notte tra il 18 e il 19 aprile 2015, ha causato
la morte di oltre 800 persone (i cui cadaveri,
nel momento in cui scrivo, non sono ancora
stati recuperati né contati) spostare l’atten-
zione dalle istanze giuridiche e politiche che
sole potrebbero garantire un ingresso digni-
toso ai migranti cosiddetti economici e un
reale diritto all’asilo a chi fugge dalla guer-
ra. Ma se di riforme politiche si vuole par-
lare, che siano reali, efficaci, radicali: una
gestione degli ingressi improntata a forme
di liberalizzazione (poter entrare con il solo
I
l profugo sta diventando l’icona del “sociale” di
questi anni come il matto lo è stato negli anni
Settanta, il tossicodipendente negli anni Ottanta
o l’immigrato a cavallo del millennio. In quan-
to “icona” la categoria del profugo è una rappre-
sentazione speciale della realtà: da una parte ne
restituisce un’immagine verosimile, ma dall’al-
tra l’opacità della rappresentazione che ne dà è
tale da giustificare e sorreggere un’impalcatura
assistenziale -trasferimenti finanziari, impianti
giuridici, dialettica politica, cultura e pratiche
pedagogiche- che con il reale ha ben pochi punti
di contatto (dall’editoriale del dossier “Accogliere
o respingere”).
se non ci fosse stata tutta l’impalcatura
assistenziale del programma di aiuto
avrebbero avuto molte più chance