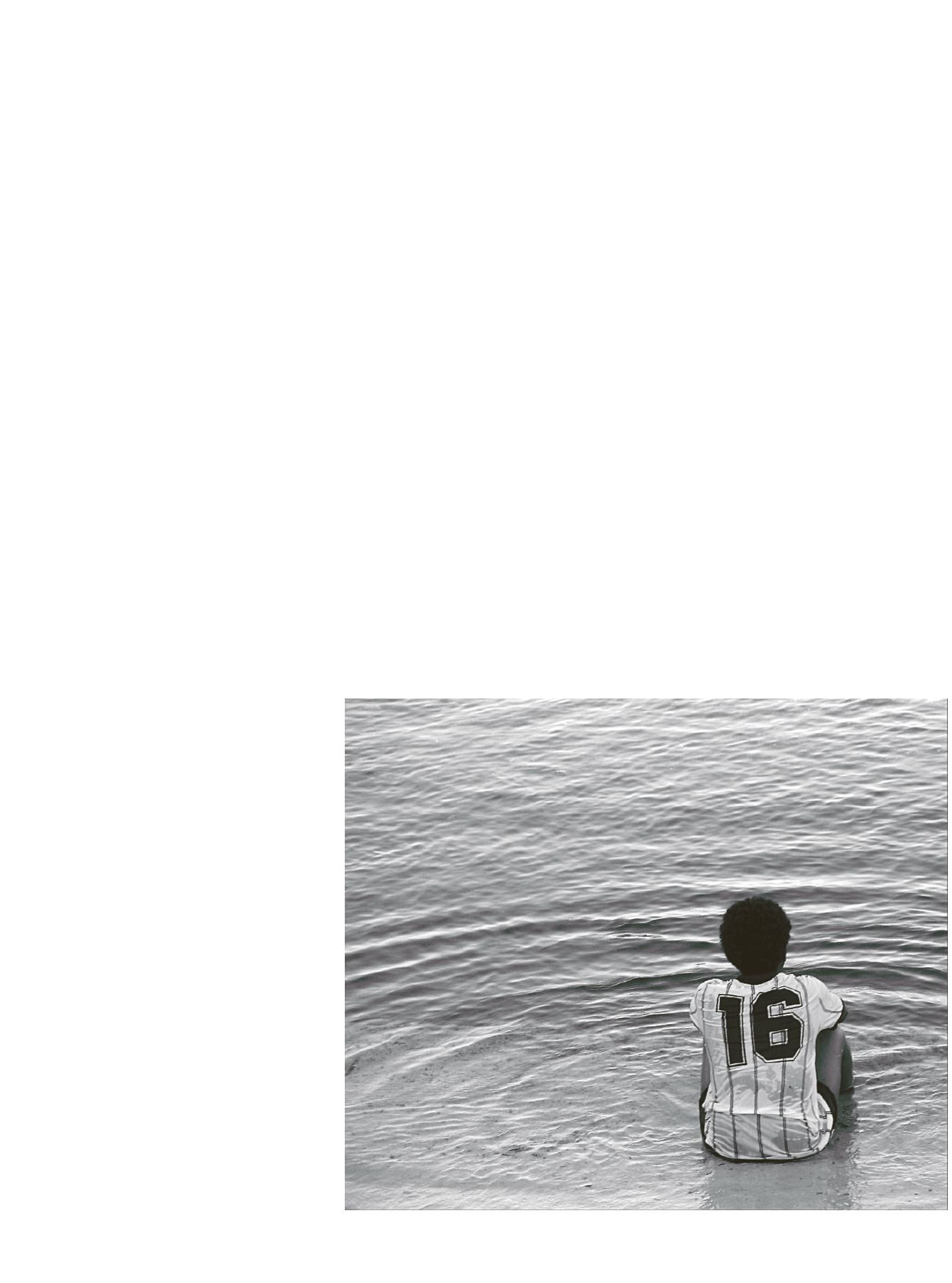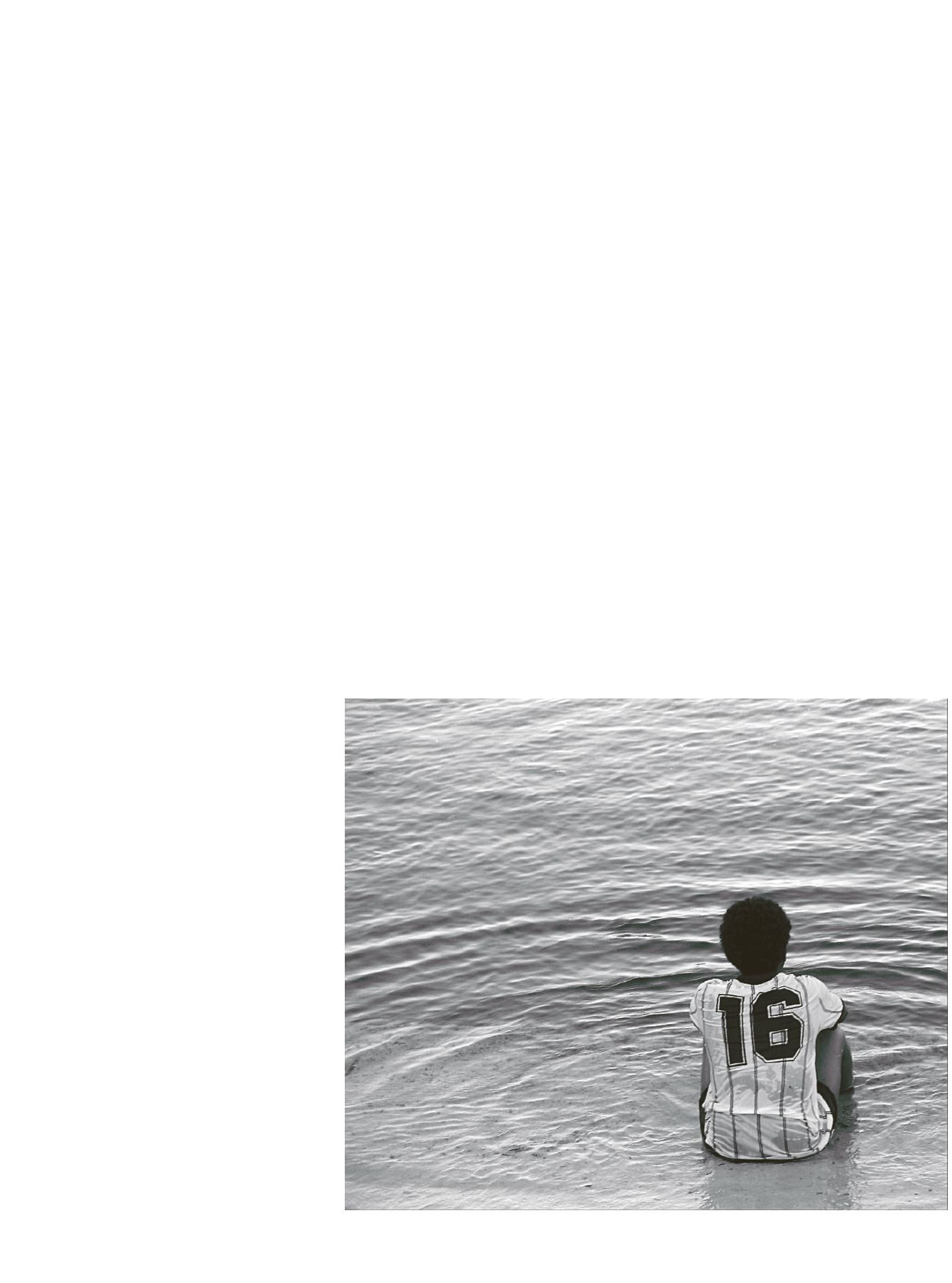
27
Un racconto a più voci, tra cui quelle di
Michele Liuzzo, Santina Lombardo, Cetti-
na Nicosiano, Calogero Santoro, raccolto
da Bettina Foa con alcuni animatori de “I
Girasoli”, un’associazione sorta nel 2006 a
Mazzarino che ha curato l’accoglienza di ol-
tre 500 minori non accompagnati richieden-
ti asilo.
Il progetto di accoglienza di minori
non accompagnati di Mazzarino è con-
siderata una buona pratica sia in Italia
che all’estero.
Il nostro progetto si chiama “Mazzarino,
città d’accoglienza”. Mazzarino, situato in
un ambiente collinare particolarmente bel-
lo, pieno di oliveti e di alberi da frutta, è
una città accogliente. Ha anche una tradi-
zione di lotte contadine e alcuni dei nostri
nonni erano a Portella della ginestra il 1°
maggio del 1947. Questo ambiente favore-
vole è importante e significativo, ma qui
in Sicilia ci sono anche situazioni difficili e
contraddittorie. Il progetto di Mazzarino ha
sviluppato un approccio che si articola sui
tre assi principali dell’assistenza di base
(vitto e alloggio), dell’integrazione lavorati-
va e nel tessuto sociale (studio dell’italiano
e formazione) e della tutela (psicologica, le-
gale e sanitaria). Vari interlocutori hanno
considerato originale il nostro modello di
accoglienza/integrazione/tutela, che non è
puramente assistenziale, ma basato sulla
promozione della centralità della persona e
della sua storia. E in effetti questo modello
è oggetto di studio sia a livello nazionale che
internazionale. Nel 2012 siamo stati invita-
ti a partecipare al Festival internazionale di
terapia familiare, dove la psicologa del pro-
getto ha presentato una relazione su questa
esperienza. Sempre nel 2012, nell’ambito
dell’
European Network of Asylum Reception
Organisations
(Enaro), che comprende una
ventina di organizzazioni europee impegna-
te nell’accoglienza dei richiedenti asilo, il
progetto è stato indicato dal servizio centra-
le dello Sprar come idoneo per uno scambio
di esperienze. Kari Madssen, responsabile
del sistema di accoglienza norvegese, è ve-
nuta a Mazzarino e si è fermata qui per un
po’ di tempo per capire le prassi adottate nel
nostro progetto elaborando poi un rapporto
molto positivo. Per noi questo scambio di
esperienza è stato un momento di confronto
arricchente. Il valore aggiunto importante
del nostro progetto è il modo in cui si lavora
quotidianamente e l’interazione con il conte-
sto sociale, che ci permettono inoltre di ap-
profondire i rapporti di collaborazione con le
istituzioni. Noi siamo convinti del fatto che
sia molto importante, per tutti, capire che il
servizio di accoglienza non è, e non può es-
sere, il tramite di una mera prestazione, ma
il flusso di relazioni e di interazioni tra tut-
ti gli attori coinvolti nel servizio, interni ed
esterni alle strutture, che sollecita inevita-
bilmente un’evoluzione culturale. L’aspetto
relazionale presente nel confronto con gli in-
dividui, e quindi con i processi comunicativi
e intersoggettivi, induce a non ridurre il ser-
vizio di accoglienza a una semplice relazione
dove il ragazzo beneficiario sollecita l’opera-
tore. Vi sono due modelli diversi di riferi-
mento per quanto riguarda, più in generale,
i servizi rivolti alla cura delle persone: un
modello tradizionale in cui la persona bene-
ficiaria dipende dal servizio e gli operatori
hanno un ruolo centrale rispetto all’utenza
che è passiva; e un modello legato all’orga-
nizzazione comunitaria in cui il potere degli
operatori viene meno. In quest’ultimo mo-
dello le informazioni sono condivise, e sono
valorizzate le competenze e le potenzialità
dei beneficiari dei servizi che assumono un
ruolo più autonomo e attivo in quanto mem-
bri consapevoli della comunità. Ed è questo
tipo di servizio di accoglienza che può essere
un’esperienza creativa di senso e di signifi-
cati culturali, un luogo che arricchisce insie-
me i ragazzi beneficiari, gli operatori e tutto
il territorio. Un luogo in cui si manifestano
flussi di relazioni, in cui il dialogo è signifi-
cativo e importante a condizione che i dialo-
ganti, però, siano disposti a farsi trasforma-
re da questa esperienza. Stiamo cercando
di eliminare dal nostro linguaggio le parole
“aiutare” (da parte degli italiani) e “grazie”
(da parte dei migranti).
è bene sempre privilegiare un’accoglienza
consapevole e condivisa dall’intero territo-
rio. Interazione, integrazione, inserimento
lavorativo e sociale, non solo dal punto di
vista degli stranieri. La scelta dei luoghi
di accoglienza non è stato casuale e tiene
conto di questa necessità. In passato si è
sempre lavorato come in una fase perenne
di emergenza in cui prevaleva l’assistenzia-
lismo (forse per compiacere i nostri orien-
tamenti valoriali) senza stimolare forme di
autonomia dei beneficiari. La stessa politica
dell’accoglienza ha sottovalutato per troppo
tempo i bisogni formativi e culturali facendo
prevalere l’importanza delle necessità pri-
marie (salute, alloggio), dimenticando che i
bisogni formativo-culturali non sono un “di
più”, un lusso da riservare agli immigrati di
cui si siano soddisfatti i bisogni essenziali.
Chi sono gli ospiti dello Sprar di Maz-
zarino? Com’è organizzata la vita di
La parola “aiutare”
e la parola “grazie”
la politica dell’accoglienza
ha sottovalutato per troppo tempo
i bisogni formativi e culturali